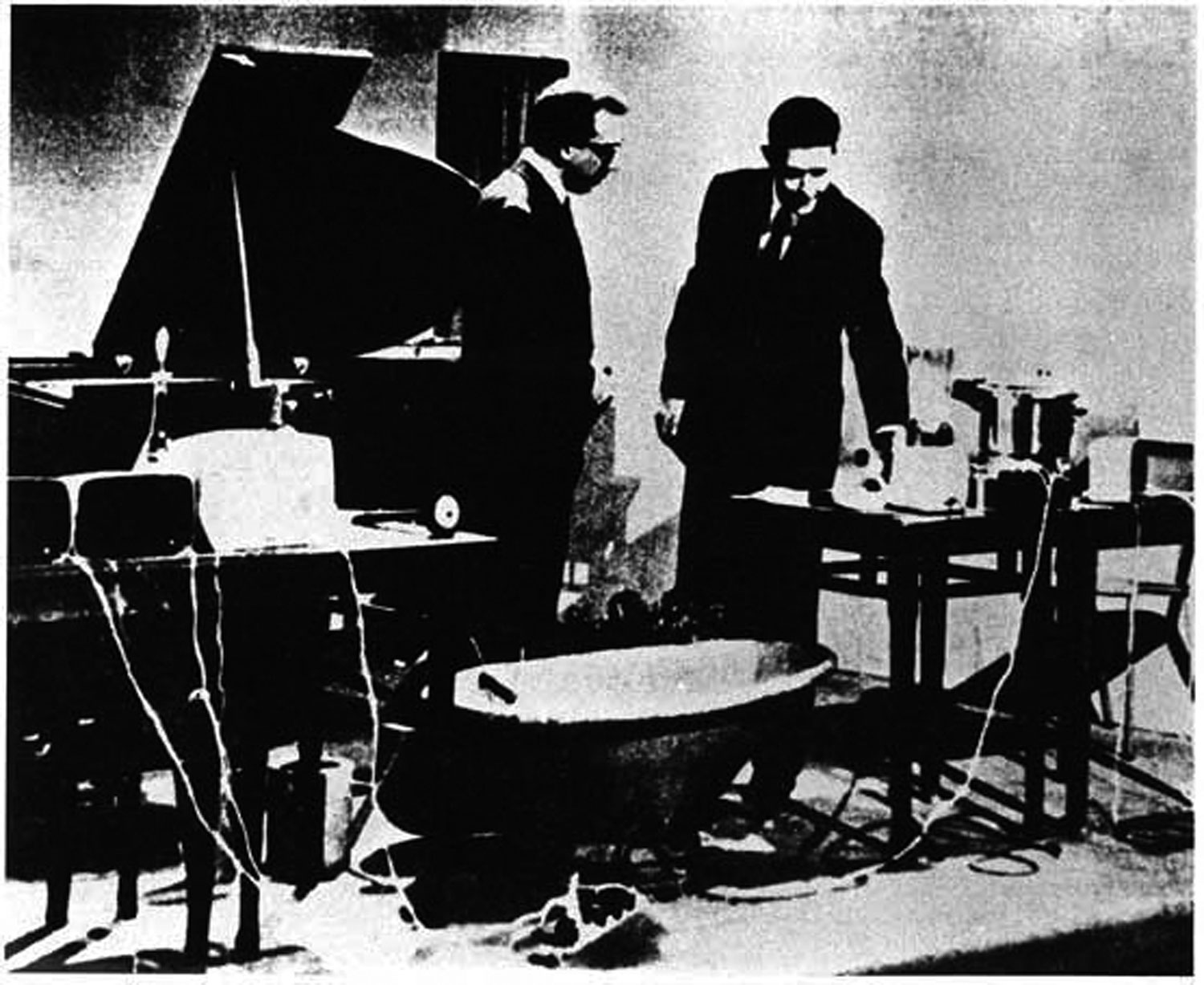Neville Wakefield: Sono affascinato da quello che un’intervista può portare alla luce.
Victor Man: Le aspettative intorno a essa…
NW: Esattamente. In qualche modo le aspettative che non sono state soddisfatte nel lavoro possono trovare riscontro nell’intervista.
VM: Quando fai un’intervista ti senti come in un cerchio di fuoco, devi stare il più possibile al centro per non bruciarti.
NW: Che cosa dicevi prima riguardo a Fellini?
VM: Riguardava il concetto di intervista o conferenza stampa. Fellini si domandava: “Perché, anziché parlare, non rimanere semplicemente seduti, scambiarsi sorrisi e alla fine anche regali?”. In questo modo sarebbe molto più piacevole passare il tempo insieme. Potremmo scambiarci dei regali anche noi, volendo.
NW: Mi piace l’idea. Mi interessa il fatto che tu possa creare un lavoro intenzionalmente opaco e, per certi versi, refrattario a una chiave di lettura univoca, e che al contempo tu ceda a un’intervista che inevitabilmente cerca delle rivelazioni.
VM: Anziché accettare di trovarsi di fronte a qualcosa di dissonante, si cerca di capire come guardarlo e come reagire. Bisogna passare del tempo con il lavoro o aspettare di vederne altri per capire di che si tratta. Attraverso l’intervista si tenta di scoprire ciò che non si riesce a recepire direttamente in un lavoro. Inoltre, per molte persone può essere una lettura più piacevole rispetto a un testo accademico. È la speranza di avere una rivelazione sull’artista. Non so se questo tipo di confessione possa essere una sorta di soluzione per il mondo.

NW: È una concezione molto cattolica. Forse posso essere il tuo prete.
VM: Sì, ma poi devi promettermi di non rivelare a nessuno le mie paure.
NW: [Ride] Cosa temi in questo momento?
VM: Ho paura che questa intervista diventi una dichiarazione o una confessione. Domani andrò ad Arezzo a vedere gli affreschi di Piero della Francesca. Per coincidenza andrò a vedere qualcosa che ha a che fare con la confessione. O meglio, con un certo tipo di confessione. In un affresco di Piero della Francesca c’è una testa di cavallo, sulla cui fronte qualcuno ha inciso il proprio nome: Giuseppe Sacchi. Ne sono rimasto molto colpito. Che cosa cercava di esprimere chi ha compiuto questo gesto? Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che esisteva un pittore chiamato Giuseppe Sacchi. È folle immaginare che abbia inciso il suo nome sulla fronte del cavallo. Era il figlio di un famoso pittore barocco, Andrea Sacchi. Giuseppe morì molto giovane, senza realizzare il suo sogno artistico, semmai ne avesse avuto uno. Ciò che ne è rimasto è questo strano scenario: un graffito su un lavoro di Piero della Francesca, quasi come la testa di un Golem.
NW: Ti interessano di più i graffiti o il modo in cui l’identità di qualcuno è stata sovrapposta a quella di un altro?
VM: Mi interessa scoprire quali sono i motivi che hanno spinto qualcuno a scrivere il proprio nome sulla testa di un cavallo. A che cosa stava pensando o che cosa voleva ottenere con tale gesto? Forse è qualcosa di molto complesso che riguarda l’acquisizione di un certo potere. O forse mi sbaglio e il suo gesto potrebbe significare esattamente l’opposto, potrebbe rappresentare una sorta di riverenza.

NW: È interessante pensare a ciò che è contenuto in una fi rma, alla quantità delle informazioni trasmesse. Penso al modo in cui l’identità artistica viene condensata.
VM: Quello che cerchi di fare è determinare ciò che è finzione e ciò che è realtà.
NW: È una distinzione importante per te?
VM: Credo sia qualcosa che il lavoro può stimolare. Non mi preoccupa che cosa è fi nzione e cosa è realtà. Alla fi ne non conta avere una risposta interessante. Prendi qualcosa di molto personale, privato, lo trasformi in qualcosa d’altro, in una fi nzione, e segui semplicemente questo processo, che ti porta dove ti porta. Dopotutto, a chi interessa?
NW: Al pubblico importa. È interessante, siamo giunti a queste considerazioni parlando di opacità e del modo in cui i tuoi dipinti eludono qualsiasi significato, e ora ti chiedo di dare loro un signifi cato attraverso questa intervista e questo processo volto alla scoperta di te. Che importanza rivestono i dettagli autobiografici per te?
VM: Vorrei restare nell’ombra, non li ritengo importanti. A volte è divertente vedere come certe persone riescono a identificarsi con certi elementi dei miei lavori e pensano che io sia personalmente legato al contenuto di certe opere. Mi è accaduto a Miami. C’era un ragazzo vestito da drag queen che si è avvicinato a me, insinuando che noi due avevamo in comune un certo feticismo. Mi sono imbarazzato. È come andare al cinema e identificarsi con l’eroe; quando esci ti senti così forte da provare le stesse mosse di karate viste sullo schermo. Oppure, come quando hai un bambino e devi affrontare l’acquisto di un passeggino. Improvvisamente, inizi a notare tutte le carrozzine per strada… il tipo di ruote, le forme e le dimensioni. Cose a cui prima non prestavi la minima attenzione.
NW: Sono le porte della percezione. Molte attività cerebrali escludono gli stimoli visivi, li allontanano; per esempio, non noti i passeggini fi nché non hai bisogno di vederli, dopodiché cominci a identificarti con loro.
VM: E improvvisamente diventa una preoccupazione, che può trasformarsi a sua volta in una passione!
NW: Penso che dipenda anche dal modo in cui opera l’impero dei segni. Osservando il tuo lavoro, ciò che ottengo sono una serie di immagini archetipiche; tuttavia, non sembrano legate necessariamente agli archetipi che conosco…
VM: Sono come delle cose residue. Non sai che cosa farci. Assumono l’identità di un residuo. Non sai realmente da dove provengono e al contempo non puoi spingerle indietro nella loro nicchia.
NW: Esatto, c’è una sorta di valenza scartata in loro, una zona d’ombra che suggerisce un certo valore d’uso che avevano, mentre ora veicolano un significato diverso. Non mi è mai chiaro qual è questo significato in realtà.
VM: Così ci domandiamo: “Quando termina questo disorientamento?”
NW: Proprio così. Sei alla ricerca di situazioni di disorientamento nella tua vita?
VM: Certo, mi sento sempre perso.
NW: Come arrivi a questo disorientamento? Lo ottieni artificialmente, attraverso le droghe, o in modo naturale, attraverso il paesaggio e la perdita?
VM: No, mi sento confuso giorno pergiorno. Devo muovermi e fare tutto da me… a volte è davvero disorientante. Ogni giorno cerco di mettere a punto una pratica e stabilire una cornice all’interno della quale vivere, tranne le volte in cui viaggio. Questa cornice funziona come una linea guida.
NW: Dipingi tutti i giorni?
VM: Ci provo. Non dipingo quotidianamente, ma convivo con la pittura ogni giorno. Mi occupo di lavori che non sono propriamente oggetti o installazioni, ma in qualche modo si combinano. È come vivere in un villaggio con queste cose intorno a te e talvolta concedersi un viaggio. Così, vivi altre esperienze che ti invogliano a tornare al tuo contesto quotidiano con un bagaglio di nuove idee. Ci sono artisti che sono davvero produttivi e creano in continuazione e altri che impiegano molto tempo per dare forma alle loro idee; occorre un lungo lavoro di rimozione per giungere al risultato desiderato. A volte devi convivere con queste cose per diverso tempo, per assicurarti che mantengano l’energia iniziale, la quale sappiamo viene persa facilmente.
NW: O forse fortunatamente… Allora, si tratta di “ammazzare il tempo”? In tal caso, è un altro modo per preservare l’energia?
VM: Il lavoro è come uno specchio; esiste fintanto che ci guardi dentro. Questa è la cosa migliore che l’“ammazzare il tempo” possa offrire, il suo riflesso, e puoi sempre voltarti.
NW: Dunque è questa la rivelazione a cui l’intervista voleva condurre?
VM: Direi piuttosto che si tratta di un tentativo di riempire un vuoto lasciato aperto tra realtà e finzione. Una sorta di Jabberwocky.