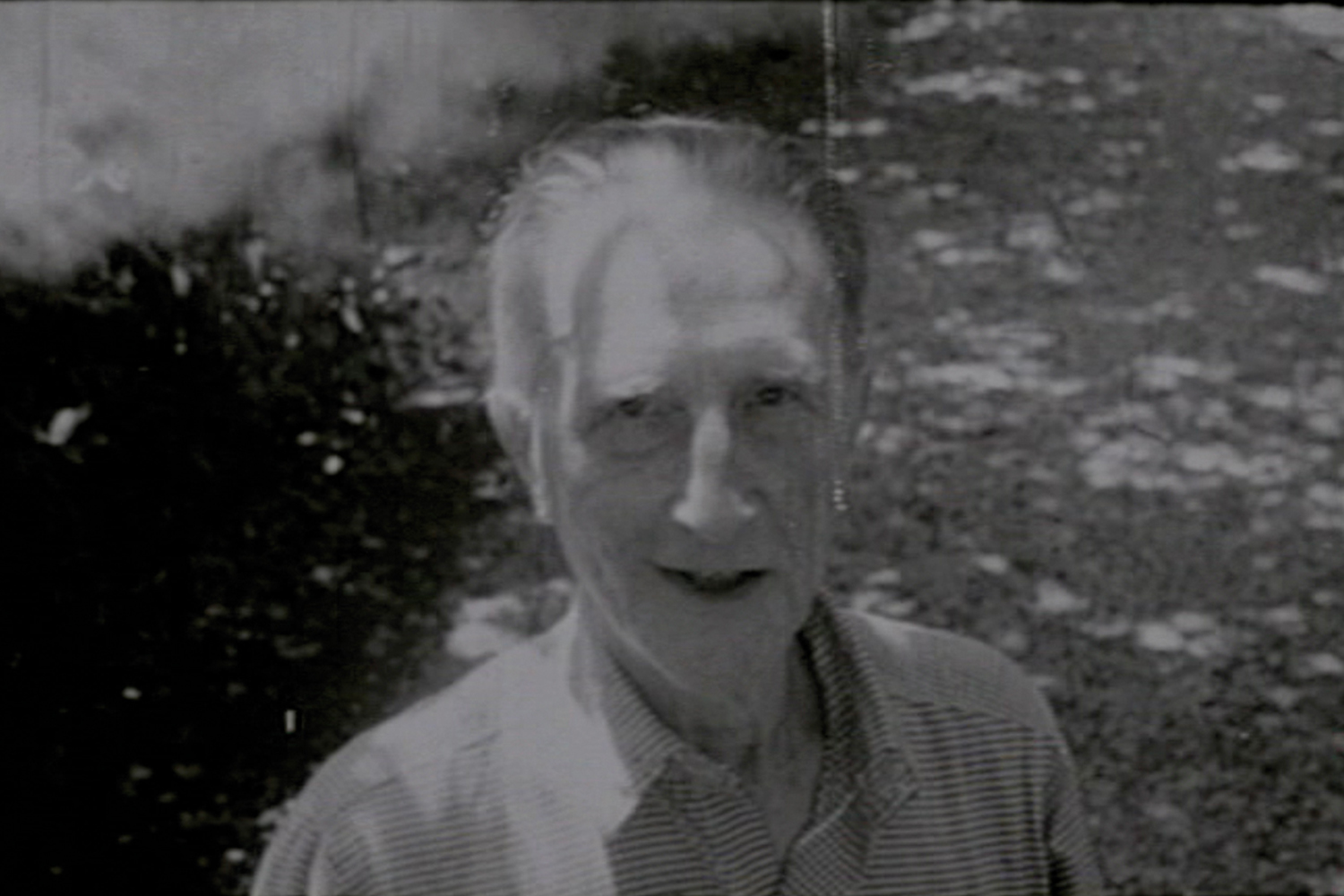So di essere lontano dall’entrare da solo in uno strano, incredibilmente intenso rapporto con l’opera di Walter De Maria. Quasi ogni volta che mi sono imbattuto nel suo lavoro, questa sensazione è ritornata: una particolare combinazione di dolore, eccitazione… e piacere intenso. Quando guardo un nuovo lavoro per la prima volta o rivedo The Broken Kilometer per la ventesima volta, mi viene un nodo in gola accompagnato da una sensazione di euforia. Questa sensazione si può chiamare soltanto “sublime”. Non nel casuale, quotidiano senso della parola — “bene, è positivamente sublime” — ma in un significato molto più profondo, quello che Edmund Burke, due secoli fa, vedeva come qualcosa direttamente connesso all’istinto umano di auto-conservazione e legato al nostro incontro con l’assoluto, con l’infinito e la morte.
L’estetica del sublime emerse nel XVIII secolo come una sorta di alternativa alla dominante, utilitaristica visione dell’arte diffusasi durante l’Illuminismo. In anni recenti, il sublime ha attirato l’attenzione ancora una volta, anche come risultato della rivolta postmodernista contro il chiuso spazio pittorico e l’ordine gerarchico che costituisce l’eredità classica del Modernismo. Nella filosofia contemporanea, è Jean-François Lyotard a raccogliere l’eredità di Burke; nell’arte, invece, il grande precursore è Barnett Newman.

Il vivaio del sublime è il favoloso, che non può realmente essere compreso dalla ragione, si può solo fare esperienza di esso: il deserto, l’oceano, l’uragano, la tempesta. Quando Brian Wallis afferma, a proposito del lavoro di De Maria, che “c’è un’incomprensibilità che è a malapena mascherata dal loro schiacciante impatto visivo” si riferisce al sublime. Nel XIX secolo, più di oggi, il sublime era l’opposto del razionalmente definito, accademico concetto di tekné. Può sembrare un paradosso quando De Maria consapevolmente racconta tutti i fattori fisici che riguardano i nuovi lavori: le loro dimensioni, il peso, la duttile forza e la resistenza nella lavorazione. Nel fare questo, è riuscito a puntare l’attenzione sullo scarto tra esperienza e fatto; egli include nel lavoro l’assurdità di provare a descrivere il sublime con un paio di bilance e un metro. Ciò non potrebbe mai essere spiegato così concretamente e chiaramente come in 5-7-9 Series, realizzate da De Maria a partire dal 1992. Inizialmente, ogni cosa del suo lavoro sembra perfettamente ovvia. Anche le dimensioni sono tali che potremmo riuscire a misurarle con le nostre mani con un ragionevole grado di precisione: 1 piede, 50 centimetri, 5 centimetri… la sistemazione appare semplicemente classica: un gruppo di tre barre poligonali, con cinque, sette e nove lati rispettivamente, emergono da una base e si ripetono in ogni combinazione possibile — una semplice mutazione matematica. E ancora, concettualmente, impressiona. C’è qualcosa di tremendamente attraente e stimolante in un sistema in cui tutte le possibilità sono state esplorate. Nonostante questo, il lavoro di De Maria ci trascina in un’onda vorticosa, dal suo microcosmo al macrocosmo delle possibilità. E i nostri occhi confermano che queste possibilità non sono limitate al regno della matematica. Il nostro più lieve movimento prima che uno di questi lavori produca nuove e complesse informazioni. Momenti impercettibili di ordine visivo cedono al disordine senza fine della variazione. Una superfice bianca si sta espandendo, un angolo affilato come un rasoio si sta rivelando. Una questione da prendere in considerazione è se l’approccio che abbiamo di fronte all’opera di De Maria è lo stesso che abbiamo di fronte alle forze della natura, sebbene ovviamente non siano della natura.

Puoi fare esperienza delle sue opere fisicamente — puoi camminare all’interno di The Lightning Field, sentire le sue dimensioni e la struttura, restare stupito dalla forza dell’efficace illuminazione — e, ancora, non comprenderle realmente con la tua mente. È possibile percepire la tua esperienza “inizio e fine dell’infinito” guardando la barra di ottone di 25 metri che reca questo titolo, ma farlo significa entrare sicuramente in contrasto con la scienza. Queste collisioni e vuoti sembrano rendere sempre più inutili i nostri tentativi di considerare il sè come entità indivisibile. Corriamo sempre il rischio di essere scissi, proprio come, nello spazio, la disintegrazione minaccia i nostri corpi. Ci sono nell’universo più di un milione di gallassie, come ci ricorda De Maria in un lavoro eponimico. “Il sublime è suscitato dalla paura che niente altro possa accadere” afferma Lyotard. In alcuni dei più importanti lavori di De Maria, un’oscura premonizione di una minaccia fatale, forse addirittura letale, gioca un ruolo centrale nell’esperienza dello spettatore. Questo senso di incombente pericolo può essere connesso con l’aura di perfezione del lavoro — “la minaccia che niente altro possa accadere” — ma è anche più concreta. Le punte arrotate dell’obelisco in Beds of Spikes, e le aste di acciaio che attraggono la luce di The Lightning Field, anch’esse appuntite, hanno portato a rilasciare una liberatoria da parte dell’artista e della sua galleria che li sollevava da ogni responsabilità in caso di incidente. Nei lavori di De Maria, anche quelli di più modesto formato, c’è un tendere verso l’assoluto, non in senso autoritario ma nello spirito del sublime, dell’anti-gerarchico. È un tentativo, come ha notato Burke, di cercare di raggiungere non l’elevazione ma l’intensificazione — in altre parole, una qualità intimamente collegata a un altro importante aspetto dell’opera di De Maria: l’energia.