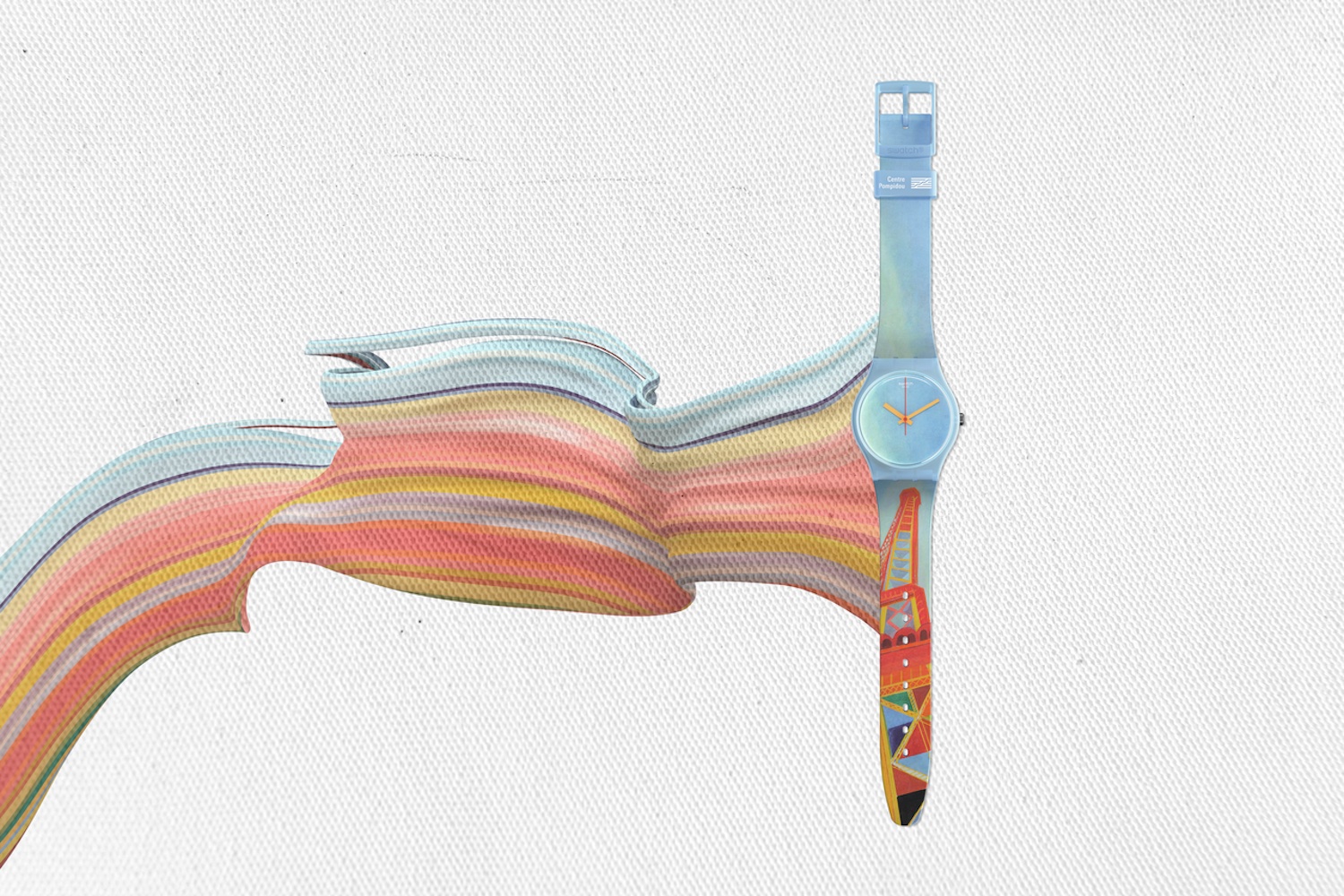Arnold Braho: Qualche giorno fa ti scrivevo che l’immagine che ho formulato riguardo la tua mostra Grandi lucenti presso galleria Zero…, il modo in cui era stata rappresentata online prima di averla vista fisicamente nello spazio, mi ricordava la copertina di F♯ A♯ ∞, album dei Godspeed You! Black Emperor. Mi riferisco in particolare a Supervision (Storm) (2024): il video di una tempesta che lentamente attraversa tutta la parete sinistra dello spazio sottostante alla galleria. Forse per l’immaginario oscuro dell’esposizione, dove hai utilizzato quasi del tutto solamente la luce naturale della galleria, o forse per i suoni che associavo come accompagnamento a queste immagini glitchate – e che poi, come solitamente nella tua pratica artistica, non si presentano. A partire da queste considerazioni, mi chiedo come tu stessa percepisca le rappresentazioni di cui ti servi per il tuo lavoro. Queste riproduzioni, o forse attitudini, di fatto esistono nell’infosfera come un grande cinema diffuso.
Irene Fenara: Mi affascina molto quando si riesce a percepire la presenza del dispositivo che ha generato o che permette la visualizzazione di un’immagine. Guardando online la copertina dell’album che mi hai suggerito, ho notato che questo tipo di immagini, come quelle che ho scelto per la mostra, cambiano tanto nei vari passaggi di riproduzione digitale. Si tratta di immagini in bianco e nero in cui l’eccesso di luce o di buio ne rende difficile la lettura attraverso un altro dispositivo. I colori sono sempre virati e la grana cambia in ogni versione. La stessa cosa è successa alle immagini che sono comparse sui social, fatte dal pubblico, ognuno con un telefono diverso che interpreta quello che registra come meglio crede. La cosa affascinante degli smartphone è che in realtà hanno sensori microscopici e lenti pessime che però ottengono immagini lavorate in automatico da algoritmi di postproduzione, così da far sembrare il risultato finale una fotografia nitida, che però è frutto di elaborazioni grafiche più che ottiche. Quello che vediamo è in realtà una rielaborazione, una rimediazione costante. Ogni mezzo reinterpreta il contenuto già espresso da un altro medium, perché si esprime con un linguaggio e forme specifiche, ma spesso si arriva a un livello di immediatezza che non ci fa percepire lo scarto. D’altronde le tecnologie nascono copiando gli organismi viventi e la fotografia computazionale degli smartphone ha aggiunto un cervello, un processore, che gestisce le informazioni visive non solo leggendo i pixel ma completando l’immagine in base alla sua esperienza. La presunta funzione documentale della fotografia, così come quella di sorveglianza dei dispositivi che utilizzo, perdono di significato e aprono nuove possibilità di interpretazione.
AB: Parlo di attitudine perché credo che a partire dal tuo lavoro si possa instaurare uno studio antropologico sulla natura della rappresentazione. Se è vero che le telecamere di sorveglianza sono sostanzialmente dispositivi di controllo, caratterizzati innanzitutto dal modello di fabbricazione (lente, tecnologia, ecc.) — allo stesso tempo risulta chiaro come queste sfuggano continuamente al loro utilizzo originale. Sia a causa di difetti causati dalla obsolescenza, sia semplicemente per il fine di chi ne fa uso, spesso totalmente inaspettato. Perché mai sorvegliare una tempesta?
IF: Mi piace pensare che i dispositivi attraverso cui osservo siano in grado di esercitare una forma di libertà, sfuggendo allo scopo univoco che l’uomo gli ha dato, e permettendosi la contemplazione della natura, silenziosamente. Questo è un grande tema di cui si occupano anche la filosofia e l’antropologia contemporanea: l’agentività non umana, cioè la possibilità che anche una videocamera di sorveglianza possa incarnare un punto di vista sul mondo e in quanto tale incarni anche una soggettività inumana. Ogni punto di vista per vedere il mondo deve essere esso stesso sottoposto allo sguardo del mondo. C’è sempre una reversibilità negli sguardi. A me interessa mostrare questa reversibilità e di conseguenza la ricchezza di punti di vista che non siano il nostro. Questo decentramento di prospettiva mette in crisi il pregiudizio antropocentrico secondo il quale il nostro, quello umano, sia l’unico sguardo possibile e apre a possibilità e punti di vista diversissimi, che possono solo ampliare la nostra visione del mondo. Trovo, infatti, sorprendenti le immagini che incontro, mi fanno vedere e pensare al di là di come sono abituata, mi arricchiscono e mi perdo anche io nel guardare una tempesta svanire nel rumore.
AB: Nei tuoi lavori c’è spesso una resa scultorea dell’immagine: apparizioni, frammenti temporali o semplicemente glitch inaspettati della telecamera prendono forma nello spazio espositivo. Supervision (Aerial leaves) (2024), video installato orizzontalmente al suolo, rappresenta l’evanescenza di alcune foglie di un albero, talmente illuminate dalla sovraesposizione che sono difficilmente percepibili dal nostro sguardo. Supervision, installazione composta da un’immagine anche qui al limite dell’astrazione, stampata su carta da lucido, è considerabile un lightbox naturale: in sostanza si “accende” e “spegne” in relazione alla quantità di luce esterna che lo spazio riflette, in base all’orario della giornata e alle condizioni meteorologiche. Ho sempre pensato che non esistano spazi neutrali, mi interessa sapere a come pensi alle tue opere in relazione allo spazio espositivo.
IF: Le mostre sono sempre un lavoro sullo spazio. Credo che le opere e lo spazio convivano in maniera simbiotica, in relazione e osmosi con l’ambiente. Mi sono aggrappata all’architettura della galleria, senza stravolgerla strutturalmente ma creando opere che stimolassero una nuova percezione della spazialità. Mi interessa come le immagini stesse siano in grado di far muovere lo sguardo e il corpo all’interno dello spazio, in questo caso tramite grandi videoproiezioni, pozzi di luce, schermi scultorei e elementi che attirano e spingono lo sguardo al di fuori della galleria. C’è un cartellone pubblicitario sulla strada, appena fuori dalla galleria, che ospita un’opera e c’è la luce che entra da una grande finestra, che si mescola ad altri tipi di luce presenti nello spazio fondendosi all’interno della grande immagine semitrasparente che si trova al piano terra. Anche la temporalità è meravigliosa. In questi mesi da inizio febbraio a fine marzo la luce e le giornate cambiano molto, dal buio dell’inverno pieno ci stiamo avvicinando alla luce della primavera. La mostra così muta di continuo pur rimanendo fatta di ambienti immersi nell’oscurità, al limite della visibilità e paesaggi che sembrano provenire da altri universi con luci simili a riflessi e oggetti non ben identificati.
AB: Hai presentato Supervision (2024) anche in formato billboard, fuori dallo spazio della galleria: una penisola sconosciuta, illuminata da un sole splendente. Il momento è quello in cui la telecamera raggiunge l’angolo esatto in rapporto alla luce, necessario all’apparizione del “lens flare”. Quando l’ho vista, nel canonico grigiore milanese, ho provato un certo grado di familiarità verso quell’immagine, pur non conoscendone l’origine. Credi che nel fotogramma che hai scelto infatti sia insito innanzitutto un linguaggio fatto di intenzioni e pratiche? Mi chiedo poi se questa regia diffusa e dispersa, fatta di reti globali anonime, sia ormai talmente canonizzata nella modalità di produzione dell’immagine nel momento in cui viene ridotta in termini di risoluzione.
IF: In un contesto caratterizzato dall’inseguimento continuo dell’alta definizione, questo tipo di immagini prolifera per le loro caratteristiche legate al peso, alla facilità di visualizzazione e alla loro capacità di circolare nell’immenso ambiente in continua trasformazione che è la rete, cambiando continuamente definizione e temperatura. Paradossalmente in un mondo HD gli strumenti non professionali che utilizziamo quotidianamente, dagli smartphone alle videocamere di sorveglianza private, diventano sempre più piccoli ma anche scadenti. L’estetica che producono si manifesta nei pixel, negli errori ottici legati alle lenti e nella trasmissione errata dei segnali. Tutto questo, forse, delinea il carattere di queste immagini che ridefiniscono il nostro panorama percettivo. Le immagini che io raccolgo dal flusso continuo di uno streaming video possiedono alcune di queste caratteristiche ma tramite l’azione della selezione, attuando quindi una scelta e dandogli un corpo, le porto in una dimensione più vicina alla nostra che ci permette di comprenderle all’interno dell’esperienza umana. L’ingrandimento e la matericità di un supporto, che sia carta o monitor, produce forme estreme di pixelatura che la stampa o la proiezione esibisce in tutti i suoi dettagli e ci porta a posizionarci nello spazio grazie all’immagine che stiamo guardando. Il vedere diventa quindi metafora dello stare nel mondo e la luce, con riflessi e ombre, ci fa percepire di essere su un pianeta o in uno spazio al di là.