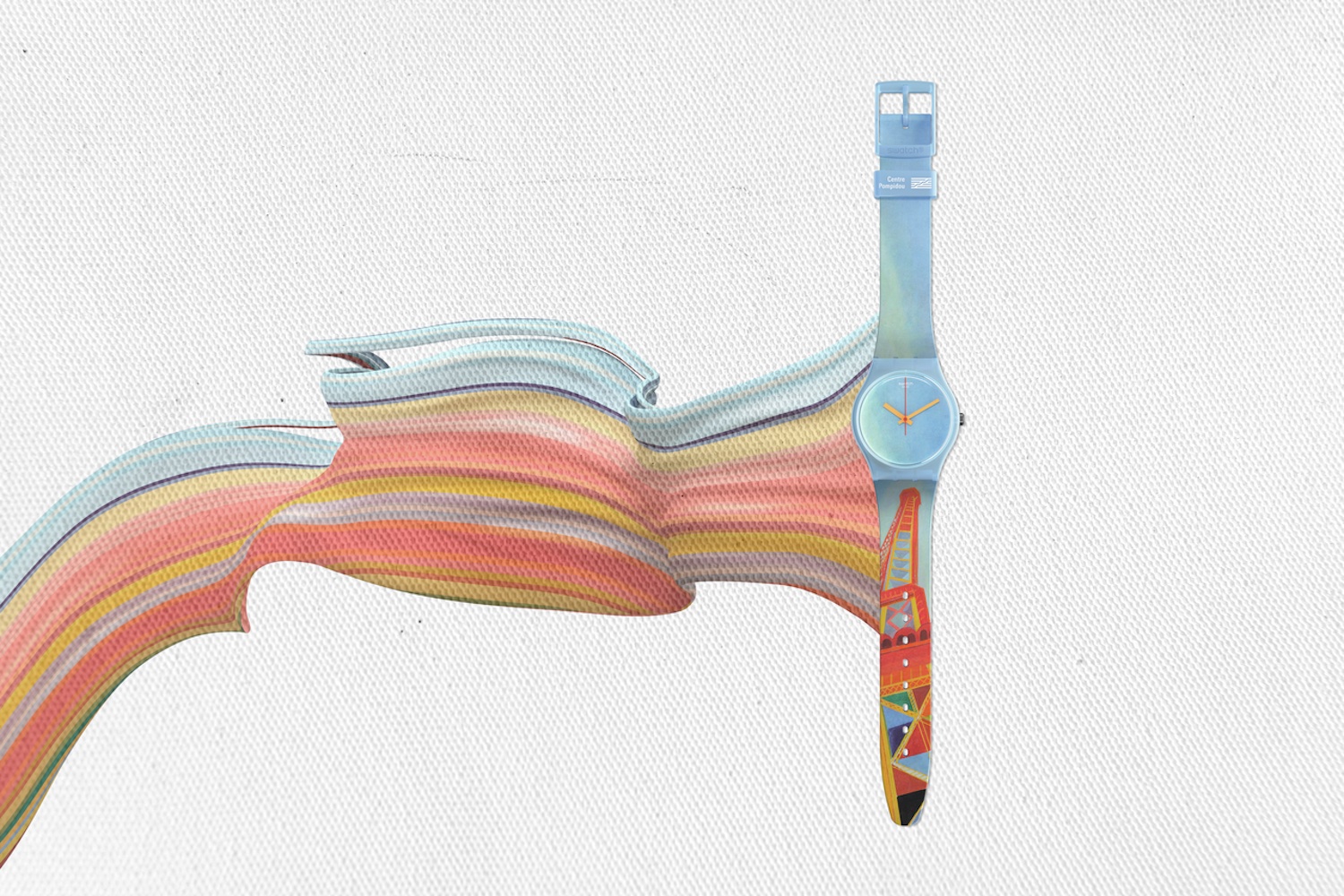Gianni-Emilio Simonetti, in un articolo pubblicato nel 1973 su Flash Art, esamina i paradigmi della musica moderna che John Cage, per primo, ha avuto il coraggio di superare. La composizione sperimentale, che l’artista identifica come una composizione i cui risultati non sono prevedibili, ha il merito di denunciare quello che Adorno definisce il sadomasochismo dello spettatore, ovvero il comportamento del pubblico disposto ad acclamare, in mancanza di altri Fürher, lo stile autoritario del direttore d’orchestra1. In un certo senso, anche “A Comparative Dialogue Act” è una composizione sperimentale che rifiuta la prevedibilità delle forme tradizionali. Il programma di residenze con artisti che si influenzano reciprocamente e la struttura stessa del padiglione non sono semplicemente una conseguenza di quel pietismo metodologico chiamato collaborazione, ma sono un atto deliberato di sovversione delle strutture disciplinari che regolano l’interpretazione artistica.
TP: Il titolo del padiglione, “A Comparative Dialogue Act”, sottolinea il potenziale trasformativo del suono come strumento per coltivare comprensione, connessione e condivisione del sapere. Da quali esigenze nasce questa idea e perché vi interessa lavorare proprio con il suono?
JV: Fin dall’inizio, l’idea era di adottare un metodo di lavoro che fosse il più collaborativo possibile proprio perché il padiglione rappresenta il Lussemburgo, che è un Paese che per via delle sue dimensioni e della sua collocazione si nutre di costante apertura verso gli altri. Quindi l’idea era, sì, di lavorare con un artista lussemburghese, ma di aprirsi il più possibile a un dialogo con l’altro. Anche Andrea Mancini, che è appunto lussemburghese, sentiva a sua volta questa necessità, e così è nata la collaborazione con Every Island, che è un collettivo multidisciplinare basato a Bruxelles, ma i cui ma i cui protagonisti vengono da paesi differenti.
Abbiamo scelto di lavorare con il suono sia perché Andrea Mancini viene da questo mondo e io ne sono molto affascinata, ma anche perché l’impatto degli sviluppi tecnologici ha ormai permeato ogni aspetto della nostra vita, rimodellando non solo la nostra routine quotidiana ma anche il tessuto delle nostre strutture sociali. I nostri modi di vivere, lavorare e comunicare hanno subito una radicale trasformazione, inaugurando un’era segnata dall’individualismo piuttosto che da un’etica di collettività e pratiche condivise, per questo ci siamo focalizzati sulla parola, sulla trasmissione orale e sullo scambio umano come risposta critica verso la “nuova era oscura” che stiamo vivendo. In un’epoca dominata da un costante sovra stimolazione di informazioni digitali, la comunicazione verbale può infatti offrire un senso di veridicità, facendo affidamento sulla connessione diretta tra chi parla e chi ascolta.
TP: Come è strutturato fisicamente e concettualmente il padiglione? E in che modo il concept si traduce nell’allestimento?
JV: L’intero padiglione è concepito come un’infrastruttura per la trasmissione del suono. L’idea del collettivo Every Island era quella di lavorare su una sorta di tool funzionale scenografico, che è il padiglione, che poi potesse divenire uno strumento per la produzione e la diffusione del suono grazie ad Andrea Mancini, e alla sua expertise legata alle sonorità e alla produzione musicale. L’infrastruttura del padiglione è costituita da quattro elementi fondamentali: quattro pareti, la pavimentazione, il soffitto e un sipario. Le quattro pareti, o muri sonori, sono posizionate su ruote e consentono agli artisti di interagirvi spostandole nello spazio. Si possono attivare in sintonia, ripetendo in loop una performance precedente ma anche in reciproca interferenza. Ognuno di questi momenti di confronto o sovrapposizione tra lavori diversi è definito ‘dialogo’. La pavimentazione, realizzata con piastrelle per impianti flottanti, funziona da superficie vibrante ed è sintonizzata con le pareti. Le piastrelle sono infatti fissate a una rete di bass shaker, un tipo di trasduttore che trasmette le basse frequenze al suolo. Il controsoffitto ospita un’installazione luminosa e i terminali elettrici centrali, mentre un sipario divide acusticamente il padiglione dal resto delle Sale d’Armi.
TP: Come si configura il programma di residenze che abiterà il padiglione durante tutto il periodo della Biennale?
JV: Innanzitutto c’è da dire che avremmo voluto invitare centinaia di artisti in residenza per poter occupare tutti i sei mesi della Biennale. Poi, per motivi di budget, logistici e pratici non è stato possibile, quindi siamo dovuti scendere a compromessi e invitarne solo quattro. Le artiste selezionate non hanno necessariamente nelle loro pratiche, non so come dire, una coerenza, un fil rouge, se non che utilizzano il suono come strumento principale e, questa però è una mia interpretazione, che sono accumunate da un sentimento di rabbia o comunque dalla necessità di esprimere un malcontento rispetto alla società in cui viviamo. Quindi, il padiglione ha una presa di posizione sociale e politica che però non è espressamente dichiarata.
Il programma di residenze si svolge nell’arco di tutti i sei mesi, ma ci sono quattro settimane dove le artiste saranno fisicamente in residenza: la prima settimana per l’opening della Biennale, la seconda residenza a fine giugno, la terza a fine luglio, e l’ultima a inizio settembre. Durante ogni settimana sarà esposta la produzione dell’opera dell’artista in residenza, che è effettivamente l’esecuzione del lavoro prodotto. Trascorsa la settimana, all’interno dello spazio resta una traccia dell’artista che va sempre più a sfumarsi man mano che le residenze avvengono. In questo modo si comporrà una sorta di caos tra le varie residenze e tra le varie pratiche artistiche.
TP: Questo punto si collega perfettamente alla prossima domanda, riguardo le librerie sonore che si mescolano e confluiscono insieme. Qual è il loro ruolo, e come le artiste interagiscono con esse?
JV: Un aspetto per noi importante come critica all’istituzione della Biennale è che troppo spesso viene posta centralità sul singolo individuo che deve rappresentare un’intera nazione o un intero discorso artistico di un determinato paese. Per noi era importante sfumare questa definizione, questo ruolo monolitico. Quindi abbiamo pensato di chiedere alle quattro artiste ospitate, prima che la Biennale inaugurasse, di produrre una sorta di archivio di suoni che andasse a rappresentare la propria pratica specifica. Questa libreria di suoni diventa poi parte degli strumenti del padiglione che ogni artista può utilizzare liberamente, proprio per abbandonare l’idea di autorialità individuale.
TP: Chi sono le artiste scelte e quali sono i loro approcci peculiari?
JV: Selin Davasse è un’artista turca che lavora con la parola, e ha un approccio molto ironico riguardo le condizioni politiche del suo paese. Nello specifico, per la Biennale si è servita di quattro animali non accettati dalla società, per parlare di xenofobia, della paura dell’altro e dello sconosciuto. Céline Jiang, a.k.a. Bisou Magique è una transfeminist che lavora sulla presenza online, offline, con una prospettiva femminista quindi anche lei indaga criticamente l’ipercapitalismo e la nostra dipendenza dalla tecnologia.
Stina Fors, che è la terza artista in residenza, ha una screaming practice, quindi lei è una donna meravigliosa e molto arrabbiata che ha reso sua, nella sua pratica, questa rabbia e questo bisogno di urlare, sia con la sua voce ma anche con gli strumenti che usa, come la batteria. E infine c’è Bella Báguena, artista spagnola non binaria, che lavora con diverse discipline, tra cui musica, performance, gioielleria, e colloca al centro della propria produzione artistica l’autoanalisi di genere e il conseguente processo emotivo che ne scaturisce.
TP: Qual è il ruolo della performance nell’ambito del progetto e come si integra nella produzione artistica complessiva?
JV: Lavoro da quattro anni al Mudam, dove prima di me non c’era realmente un programma di performance. E per quanto le istituzioni siano sempre più interessate ad avere un programma di performance, c’è spesso incongruenza tra questo desiderio e ciò che effettivamente vuol dire portare delle performance all’interno di un’istituzione. Negli ultimi quattro anni ho quindi cercato di trovare delle strategie per guadagnare più spazio, budget, tempo e fisicamente più spazio. Proprio perché di solito la performance viene utilizzata come “intrattenimento” o come “tappa buchi” all’interno di una programmazione museale, mentre nella mia visione ha un peso totalmente diverso. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non è solo l’atto performativo di per sé, ma è tutto il processo che ruota attorno alla performance che mi interessa. E infatti in “A Comparative Dialogue Act” anche quando l’artista non è fisicamente nello spazio lascia una traccia. Quindi, anche se può sembrare provocatorio, non per forza una performance deve essere un corpo inserito nello spazio ma anche l’eredità o l’anticipazione di quel momento può essere identificata come atto performativo.
TP: Nel tuo testo “The birth of the listener must be” che accompagna la pubblicazione affermi che le voci singolari degli artisti convergono in un’unica opera sonora. In che modo “A Comparative Dialogue Act” mette in discussione la radicata nozione occidentale di autorialità artistica individuale?
JV: Come premessa devo sicuramente ammettere che è stato un esperimento, e come in ogni esperimento si prevede come risultato il fallimento e il caos. Ciò che volevamo ottenere è appunto che si perdesse l’autorialità individuale per abbracciare un approccio più corale, e anche se chiaramente questo non è stato possibile in modo assoluto perché i nomi degli artisti sono identificati, devo ammettere che nella settimana di opening c’è stata molto confusione rispetto a chi ha prodotto esattamente cosa. Ad esempio, non era chiaro se l’artista Selin Davasse avesse prodotto lei lo script della performance o se questa fosse stata prodotta, o scritta, da Andrea Mancini. A me piace molto il fatto che questa cosa fosse ambigua. E anche nel team che ha prodotto il padiglione è interessante notare come i ruoli si siano un po’ confusi. Ad esempio, Lorenzo Mason, il grafico che inizialmente era stato invitato solo per lavorare all’identità visiva ha poi fatto parte di tutto il processo creativo fino a partecipare anche all’operazione artistica. Insomma, gli artisti hanno fatto i curatori, i curatori hanno fatto gli artisti, gli scenografi hanno fatto gli architetti e via dicendo.
TP: Come hai concepito la pubblicazione che accompagna l’esposizione?
JV: Per l’inaugurazione della Biennale abbiamo lavorato a una piccola pubblicazione che voleva riflettere il concept del padiglione, e infatti più che a un catalogo sembra un vinile. L’interno del libro è una sorta di karaoke, e quindi da un lato viene subito posta enfasi sulla presenza del suono e sulla musicalità del padiglione e dall’altro si invitano gli spettatori e i lettori a partecipare a questa coralità intonando la canzone che abbiamo scritto sul padiglione. Questo dovrebbe essere il side A del progetto editoriale, mentre il side B sarà invece effettivamente un vinile che raccoglie le quattro residenze sviluppate nell’arco dei sei mesi. In questo modo, questa anti-autorialità, questa confusione sarà resa ancora più esplicita.