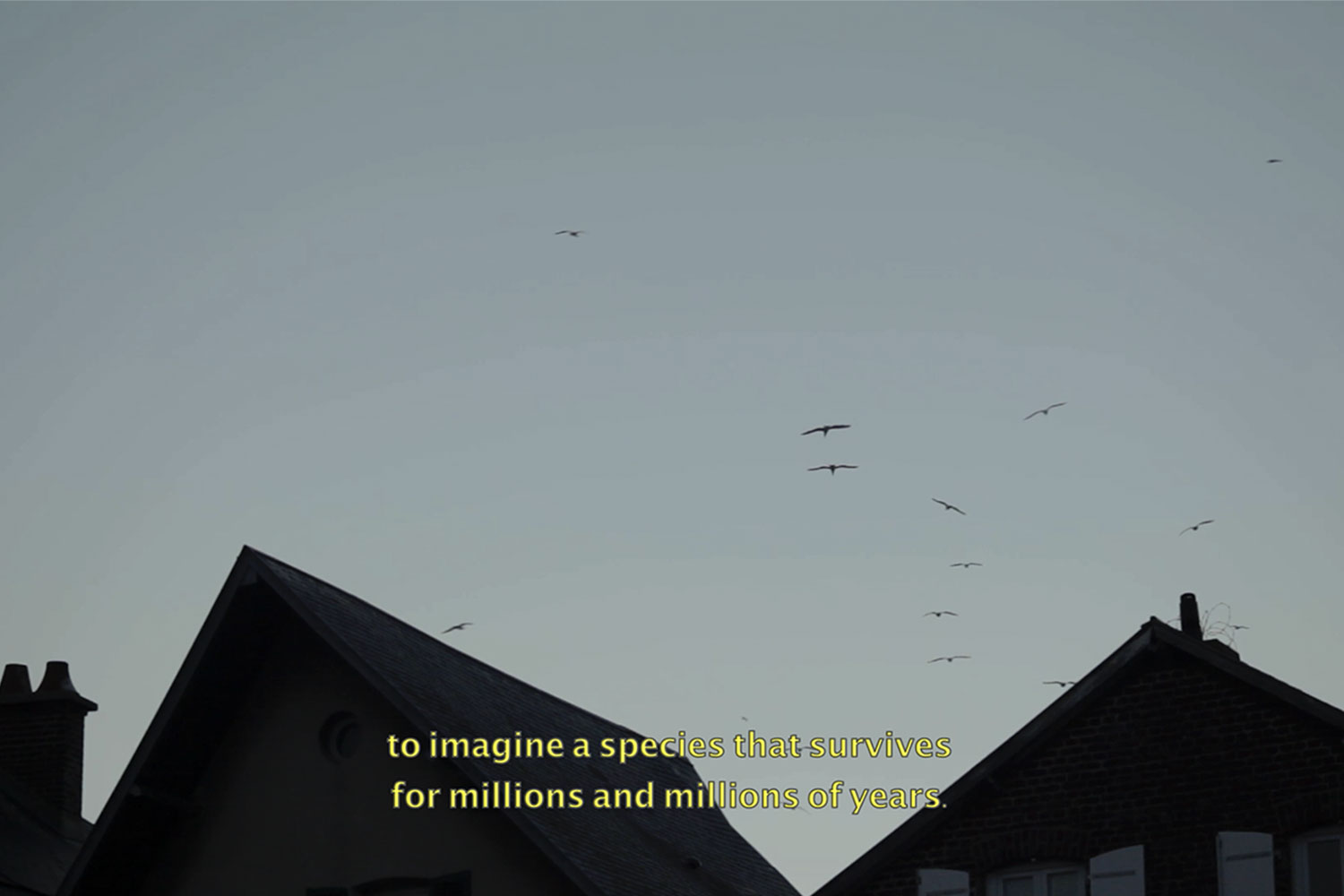C’è un’opera del 1961 di Giosetta Fioroni che è quasi un manifesto programmatico: uno schermo dipinto, con un perimetro disegnato e all’interno una maieutica del segno, una stratificazione lirica di tracce argentate su fondo dorato. Tralasciamo il discorso sullo schermo (siamo in un’epoca, soprattutto a Roma, in cui diviene un riferimento primario dell’avanguardia, per Schifano, Mauri e molti altri), perché ciò che veramente è stimolante di quest’opera è l’atmosfera sospesa che fa i conti con l’assenza totale di un racconto, d’altronde è lei stessa qualche anno fa a palesare a Obrist su Flash Art: “Direi che il nostro cuore era sull’altopiano della pittura americana”. Già all’epoca la Fioroni non racconta, ma setaccia icone o, come in questo caso, eventuali immagini nascoste sotto segni ingarbugliati. All’interno si respira però l’idea del fermo-immagine, seppur vuoto e assente, direi metafisico. Perdura la felicità di una pennellata densa, aperta, capace di generare tracce che di volta in volta cambiano tenore e c’è quella stratificazione che anche nelle opere di questi ultimissimi anni affiora sempre. Non a caso Germano Celant qualche anno fa nel suo catalogo ragionato dedicato alla Fioroni lo pubblica a piena pagina. Il colore argentato è quello generativo che l’artista adotterà con particolare pregnanza a partire da tre-quattro anni dopo, quando mettendo ordine tra le immagini che fuoriuscivano dalle magmatiche tele presentate già nel 1961 alla Tartaruga in una doppia personale con Umberto Bignardi decide di isolarne alcune restituendole con una meditata compiutezza.
Alle opere argentate è dedicata gran parte della mostra da M77 a Milano “Speculum. Guardare, guardarsi, esser guardata” a cura di Cristiana Perrella e realizzata in collaborazione con la Fondazione Parise e Fioroni. Al centro di tutto c’è un archivio aperto, casuale, disordinato, a cui lei attinge. A ben guardare tutto il suo lavoro, anche quello più maturo e volutamente seriale è legato a un’idea intima di archivio. Se nei Sessanta era il mondo del cinema – ma anche i ritratti fotografici di amici e conoscenti o del suo grande amore di una vita Goffredo Parise – ad attrarre la sua attenzione, tanto da estrapolare dei fotogrammi per poi riutilizzarli come silhouette essenziali sulle superfici apparentemente fredde delle sue tele, successivamente saranno le fiabe, la tradizione orale e il fantasmagorico paesaggio veneto con le sue foglie e i suoi sassi (con Parise ha a lungo vissuto in quell’area) ad entrare nelle sue tele dove nel mentre era ricomparso un poetico disordine visivo di stratificazioni di segni e immagini intervallato da riferimenti letterari a lei molto cari. La mostra milanese ha il merito di soffermarsi, soprattutto sugli anni cruciali – il percorso comincia con un lavoro delle origini, datato tempestivamente 1960, Laguna –, comprendendo non soltanto diverse opere argentate, ma anche un nucleo di film d’artista, una selezione ragionata di disegni e tele dei Novanta e una raccolta di immagini d’archivio provenienti dalla fondazione con sede a Roma in quel magnifico studio dove Giosetta lavora ancora (quelle scattate da Tano Festa sono tra le più intense). Le tante immagini che costituiscono la sezione documentaria della mostra di M77 sembrano riecheggiare quello strabiliante collage di fotografie con amici e compagni di strada che accoglie i fortunati che varcano l’ingresso dell’atelier dell’artista.