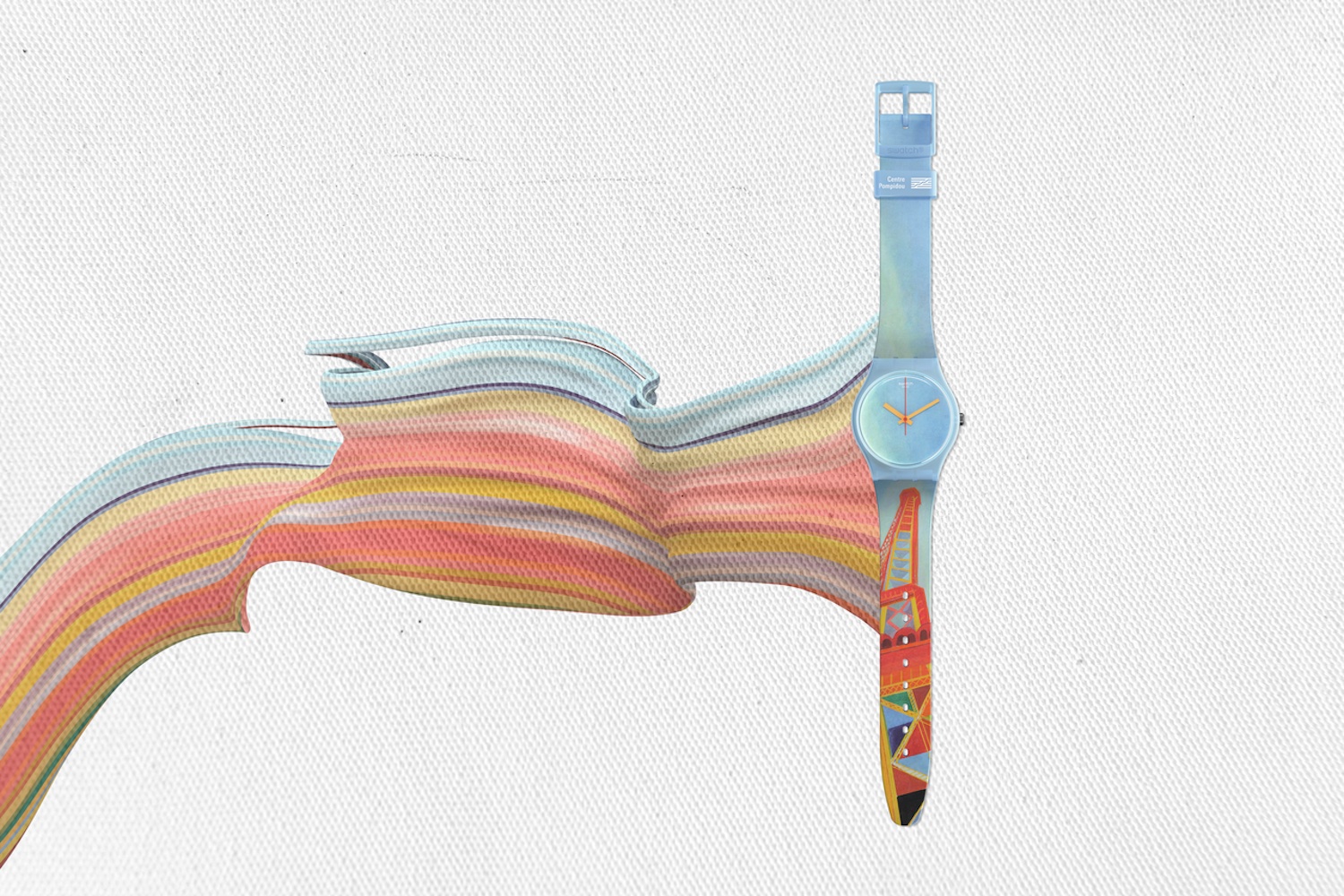Se dovessi immaginare gli incroci che mi hanno portato a incontrare l’opera di Saodat Ismailova, parlerei di orbite, di mappe o di quei racconti mitologici che si incastrano uno dentro l’altro fino a toccare – non senza contraddizioni interne e salti temporali – l’origine di tutte le cose.
Una sensazione del genere si respira nella mostra antologica visitabile all’HangarBicocca di Milano fino al 12 gennaio 2025. Una qualità quasi geografica, non solo per forma delle sue strutture, modellate sui corsi dei due maggiori fiumi dell’Asia Centrale. Amu Darya e Syr Darya, ma anche per un’intensità implicita nel dialogo tra le opere in mostra, che si inseriscono in narrazioni più grandi e più lunghe della vita umana, capaci quindi di contenere al loro interno segreti lontanissimi, sconvolgimenti politici, mutamenti climatici e le trasformazioni di tutti i corpi.
Nel suo potentissimo Donne che corrono coi lupi, Clarissa Pinkola Estes – prima di percorrere il potere manifesto e non delle fiabe popolari raccolte nel corso della sua vita – si autodichiara parte della millenaria stirpe della cantadora: le donne che conservano e propagano le storie dell’umanità.
Per quanto lei sottolinei la natura collettiva del proprio lavoro (o forse proprio per questo), Saodat Ismailova sembra inserirsi all’interno di una genìa simile, la cui opera, sfumando i confini tra singolare e plurale, leggendario e dolorosamente attuale, diventa un grande diapason attorno a cui si armonizzano i tanti destini di un territorio. L’intervista che segue parte da questa qualità narrativa e cerca di inseguirne le forme, lasciando che il resto emerga di conseguenza.
Valentina Avanzini: Vorrei partire da un elemento centrale del tuo lavoro: la narrazione, la trasmissione, tenendo conto anche della valenza ambigua e contraddittoria che assume nel tuo lavoro. La tua retrospettiva ora ospitata da Pirelli Hangar Bicocca, “A Seed Under Our Tongue”, affonda le sue radici proprio in questo. Il seme di dattero conservato sotto la lingua dal saggio Arslanbob viene dato ad Akhmand Yasawi perché lo pianti: da questo gesto nascerà una foresta di noci. Questa impossibile trasformazione porta con sé meraviglia, promesse, ma anche aspetti oscuri: il noce torna spesso nelle storie che attraversano le tue opere come albero popolato da spiriti, allucinatorio e misterioso anche per la sua copiosa produzione di anidride carbonica. Tenendo presente questa ambivalenza, pensando al potere liberatorio, meraviglioso, ma anche potenzialmente pericoloso delle storie (quando, ad esempio, diventano uno strumento di propaganda), vorrei esplorare con te il valore e il ruolo della narrazione – orale, collettiva, sfuggente, contraddittoria – nel tuo processo artistico.
Saodat Ismailova: In generale, la compresenza contraddittoria di positivo e di ciò che potremmo chiamare negativo è proprio quello che costituisce una narrazione. Qualcosa di molto basico, una confluenza di forze contrastanti: il giorno e la notte, l’illusione e la realtà. E per me è proprio questo a essere interessante. In particolare, mettere in discussione realtà e illusione è ciò che mi tormenta, la mia ispirazione a creare un’opera, che esiste per me solo in uno spazio di mistero, lì dove fino alla fine non è possibile comprendere. Potremmo dire che il motore che spinge la mia arte è il tentativo di entrare in questo spazio di non chiarificazione. La mia intenzione, ad esempio quando utilizzo video d’archivio nati come forma di propaganda, è quello di realizzare nuove traduzioni, nuovi significati: in questo caso i video si trasformano in uno strumento che porta nuovi significati e maggiore complessità alla narrazione. Quindi per me questa natura ambigua, sfuggente e collettiva è l’essenza stessa della narrazione. Senza contraddizione non c’è discorso, non c’è modo di sollevare interrogativi. E questo è ciò che mi interessa del mio lavoro: non trovare risposte ma generare domande.
VA: C’è una parola, un’idea che mi sembra percorrere silenziosamente molte delle tue opere, senza dominarle ma quasi avvolgendole: protezione. Come la Tigre di Turan di The Haunted (2017), simbolo di una protezione più che umana che, però, non è stata protetta dall’uomo. Questa forma di cura si estende oltre i confini del regno dei vivi, attraversando organismi e generazioni. Quando manca, i suoi effetti sono devastanti, soprattutto per quanto riguarda il disfacimento dei legami uomo-ambiente. Guardando le tue opere, gli archivi di sogni e racconti antichi che raccogli e conservi, lo studio dei tessuti tradizionali, mi chiedo se questa dimensione, questa tensione alla protezione si possa trovare anche qui, se pensi alle tue opere come a una forma di cura.
SI: Certamente c’è una forma di cura e protezione nella trasmissione delle storie in modo che continuino a propagarsi, ma per come la vedo io, si tratta solamente di una trasformazione di mezzi. Se fossi nata cento anni fa, probabilmente avrei scelto una trasmissione orale o in forma tessile. Ora i miei strumenti sono differenti, ma non vedo differenze tra me e un cantastorie, anzi: vedo una continuità all’interno della tradizione della trasmissione. Questa trasmissione di narrazioni crea uno spazio di sicurezza, che potremmo vedere come una forma di protezione. Per me, crea una forma di stabilità mentale, assolutamente essenziale. La vita biologica umana ha dei limiti fisici e temporali, e all’interno di questo lasso di tempo avvengono moltissimi cambiamenti di tipo politico, sociale, climatico, che hanno un ritmo ancora più veloce. Le narrazioni, invece, hanno una dimensione temporale più lenta, che crea stabilità.
VA: Verso la fine del secolo scorso, la società occidentale si è interrogata a lungo sulla trasformazione dei suoi riti e della sua spiritualità. Nel dare forma a una società costruita in modo asfittico intorno all’individuo, ci si chiedeva se le forme di espressione contemporanee potessero ancora portare in sé il nucleo di comunità e di formazione dell’identità un tempo associata al rituale. Antropologi come Victor Turner hanno trovato una risposta, seppur parziale, nel teatro, anche se la sua creazione presuppone l’autorialità di un drammaturgo, di un regista, che invece si disperde nella funzione rituale. Mi sembra di ritrovare questa tensione nel tuo lavoro: l’unione di storie che non ti appartengono e di suoni e reminiscenze di grandi registi cinematografici come Bergman e Tarkovskij. Hai mai pensato al cinema in questo senso. La trasformazione di un’altra narrazione funzionale, comunitaria? E più in generale: come negozi il rapporto tra individuale e collettivo nel tuo lavoro?
SI: Se parliamo del cinema come a uno strumento di trasmissione della memoria, è esattamente ciò che mi interessa, è ciò su cui lavoro. Molte delle mie opere non si riferiscono a una me individuale, ma a una condizione collettiva, alle persone che vivono in una parte del mondo, alle loro storie, a ciò che raccolgo, che sento, che cerco di sviluppare. Non vedo una contraddizione tra tutte questi tentativi di creare storie e raccontarle. E non è necessario che siano forme antiche: il cinema, il gioco, si può usare tutto per lo stesso scopo. Dipende dalle intenzioni, ma la questione degli strumenti non ha limiti, si può adattare a qualsiasi tecnologia, a qualsiasi forma di comunicazione che abbia senso in quel momento. Riguardo alla questione dell’individuo e della collettività, da una parte penso che tutto quello che faccio sia collettivo, dall’altra penso che questo non possa mai pienamente accadere. È sempre un’artista o una persona a fare sì che una storia collettiva possa essere vista e ascoltata. E le storie non sono mai raccontate nello stesso modo, c’è sempre un elemento di trasformazione, di mutamento e quando questo accade significa che la storia è viva. Quando invece viene trasmessa sempre nello stesso modo, sempre dalla stessa prospettiva, allora non c’è più davvero bisogno di trasmissione.
VA: Guardando le tue opere, mi rimane un’impressione onirica, non solo perché il sogno è uno dei grandi protagonisti di video come Stains of Oxus (2016), ma anche per la natura stessa delle storie che decidi di trasmettere, in cui le leggi della fisica vengono stravolte. Penso al dialogo tra l’ascensione dello sciamano Qorqut e l’ambizione di conquista del cielo di Gagarin in Two Horizons (2017), ma anche al racconto dell’innaturale scomparsa del Lago d’Aral che scorre come un fiume carsico in molte delle tue narrazioni. Sconvolgimenti mitici e storici si rincorrono, per creare un grande sogno/realtà comune che, come in Stain of Oxus, può essere trasmesso, ereditato. Vorrei quindi chiederti di parlare del sogno nel tuo lavoro, come dispositivo comunitario, narrativo, ma anche politico.
SI: Penso che i sogni non siano una parte integrante della nostra vita da pochissimo tempo, forse cento anni appena. Prima di allora hanno sempre accompagnato l’umanità, giocando un ruolo fondamentale nella costruzione degli immaginari. Erano uno strumento attivo. Sicuramente dipende molto anche dal modo in cui si lavora con i sogni. Esiste uno spazio molto astratto, dove è facile perdersi. È necessario capire e in qualche modo definire la natura dei sogni. Ne esistono di molti tipi. Quando lavoro sul campo, amo i sogni, spesso diventano un modo per creare una connessione diretta con le persone, perché lo spazio dei sogni è concepito come uno spazio sicuro. Bisogna sapere come accedervi, ma ci sono modi e strumenti diversi per entrare in quello spazio, e al suo interno avere accesso ad altri strati non solo di ricordi ma anche di realtà. Ci sono domande a cui le persone non hanno nessuna voglia di rispondere se affrontate a livello di realtà, ma che diventano avvicinabili se le si affronta passando per i sogni. È come se i muri fossero più sottili. C’è una certa delicatezza, una sospensione dalla pressione di norme e aspettative sociali, come una liberazione: è uno spazio fisico che permette di calarsi più a fondo negli stati della realtà. È uno spazio più importante di quello che potremmo chiamare vigile, anche se avrei dubbi ad affermare che quello che chiamiamo spazio reale si collochi nella realtà o nei sogni.