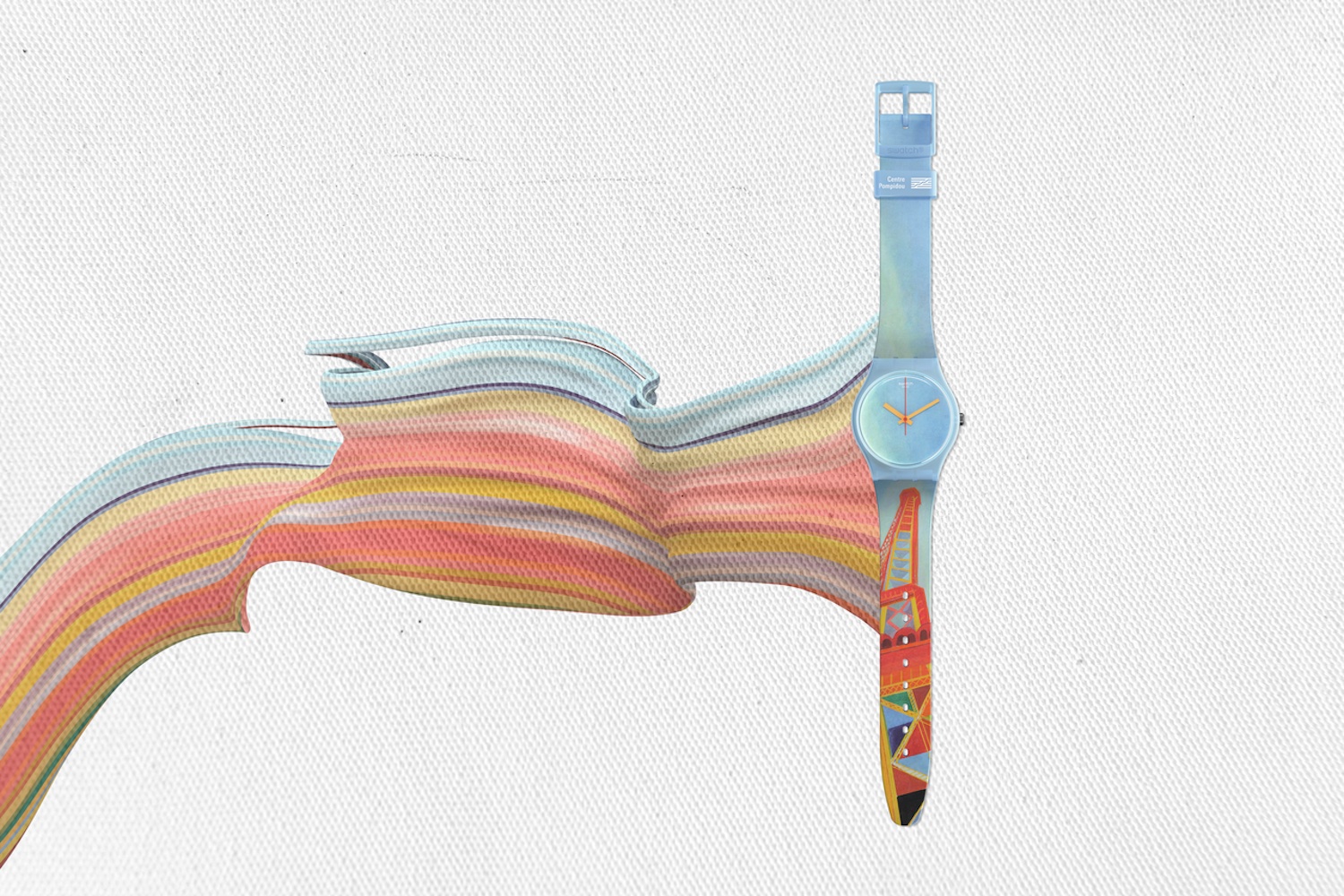A inizio luglio ho incontrato Lucrezia Calabrò Visconti, la nuova Head Curator dell’Istituto Svizzero a Roma, Milano e Palermo, per parlare dei primi progetti dal suo insediamento. Abbiamo ripercorso le mostre “Con lo zucchero in bocca” e “The House of Dorothy”, appena concluse presso le sedi di Roma e Milano, riflettendo sull’identità di questi due spazi e le traiettorie per una curatela che, pur mantenendo gli strumenti della ricerca, si manifesta orizzontale.
Leonardo Bentini: Inizierei dalla mostra “Con lo zucchero in bocca”, appena conclusa all’Istituto Svizzero di Roma. Il tema centrale, più che il “dolce”, mi sembrava essere l’inganno. Una condizione che oggi sembra perpetuarsi nelle società occidentali attraverso una pulsione capitalistica che fa sempre più leva sul costante bisogno di colmare una mancanza, e la paura stessa di quel vuoto. Il piacere effimero dello zucchero, in mostra ha preso sembianze diverse in tutte le opere, rivelandosi dopo una prima occhiata quasi giocosa, un inquietante e violento dispositivo geo-politico ed economico.
Questa dimensione dell’inganno nel percorso espositivo è stata una scelta curatoriale, oppure solo una mia suggestione?
Lucrezia Calabrò Visconti: La mostra è partita da una ricerca sull’Istituto Svizzero e sulla sua storia. Mi sono chiesta come costruire una programmazione all’interno di questo contesto, sentendo l’urgenza di capire quali domande porre a quello spazio. Ho scoperto che la storia dell’edificio che ospita la sede romana dell’Istituto Svizzero è strettamente legata alla produzione dello zucchero: Emilio Maraini [un tempo proprietario insieme a Carolina Maraini Sommaruga della villa] imprenditore svizzero, importò in Italia la coltivazione della barbabietola da zucchero verso la fine del 1800, e poco dopo fece costruire la villa, come simbolo del potere che aveva rapidamente guadagnato. Sebbene la produzione della barbabietola abbia una storia piuttosto breve, e legata alla produzione locale, la storia dello zucchero si estende per oltre duemila anni e attraversa forme estreme di estrattivismo – inteso sia come estrazione di risorse naturali che come sfruttamento di risorse umane. La produzione dello zucchero di canna, nello specifico, ha implicazioni con il colonialismo e la manodopera schiavile. È una vicenda che ha contribuito in modo tragico e disastroso alla formazione della modernità che conosciamo. La storia della villa mi sembrava quindi un punto di osservazione privilegiato: una piccola parentesi che permette però di aprire lo sguardo su fenomeni molto più vasti.
Un altro aspetto che mi interessava esplorare era il modo in cui la dolcezza, anche in ottica metaforica, ha funzionato per nascondere questi fenomeni di estrattivismo; quindi in parte sì, c’è un discorso sul nascondimento e “addolcimento” che si avvicina all’idea di inganno: un fenomeno che oggi viene anche descritto come cutification, ovvero quel processo che rende più accettabili storie di violenza e sopraffazione attraverso il loro renderle più “carine”.
Apparentemente, la mostra raccoglie opere che guardano criticamente alla storia dell’estrattivismo. In realtà, però, ciò che mi interessava di più di questi lavori è che portano anche una riflessione sul linguaggio: su come queste storie siano state raccontate, e letteralmente nascoste sotto un velo di dolcezza, che spesso le opere in mostra riescono a valicare..
Un esempio emblematico è il lavoro di Oz Oderbolz, che riflette sulla figura del cowboy: un personaggio passato per generazioni come simbolo positivo di mascolinità e virilità attraverso la cultura pop, ma che storicamente è legato al cosiddetto “colonialismo di insediamento”, all’esproprio delle terre delle popolazioni indigene e al loro spostamento forzato. Oz indaga anche la dimensione di erotizzazione di questa figura all’interno della cultura gay, mostrando come alla sua romanticizzazione si accompagni sempre una rimozione della violenza originaria.
In questo senso, la mostra vuole essere una riflessione su come certe narrazioni – apparentemente innocue o “edulcorate” – siano state costruite per celare storie di sfruttamento e violenza che sono alla base della modernità. Nel lavoro di Oz, insieme ai disegni di Milva Stutz sulle pareti, la mascolinità tout-court diventa un’altra delle narrazioni che è urgente decostruire.
LB: È interessante come la mostra ha un apparato teorico davvero importante, che si interfaccia con la dimensione narrativa che emerge durante il percorso espositivo. Effettivamente – rispetto anche al concetto di cutification che citavi –, ogni opera sembra quasi un dispositivo rivelatore. Ti trovi a interagire con simboli che per anni ti sono arrivati in un certo modo, e poi improvvisamente si rivelano per quello che sono davvero. Questa cosa l’ho trovata incredibile; a partire dalle opere-torta di Gina Fischli fino a Resurrection Ranch (2024) di Virginie Sistek, nel quale per esempio c’era la volontà di rappresentare questa stalla attraverso un linguaggio visivo quasi infantile, recependo solo successivamente tutta la questione legata all’estrazione degli ormoni dalle cavalle per le terapie della menopausa e scontrandosi ancora con il rapporto tra inganno e attrazione.
LCV: Effettivamente questa cosa che dici dell’impianto teorico, per me è stata anche molto liberatoria, devo dire. Perché uno degli aspetti più interessanti dell’Istituto Svizzero è proprio la sua vocazione a indagare il rapporto tra arte e ricerca.
Questo ti da la possibilità di approfondire criticamente le tematiche e di capire come queste possano entrare nel percorso espositivo, ed essere sviluppate anche attraverso la programmazione discorsiva. Ad esempio ho collaborato con Ilyas Azouzi, il responsabile della programmazione scientifica dell’Istituto, per costruire un public programme dedicato, intitolato Sweet Extractivism, nel quale abbiamo invitato figure accademiche ad approfondire il modo in cui lo zucchero e altri prodotti legati alla dolcezza sono intrecciati alla colonialità, agli studi sulla razza, alla giustizia ambientale e alla disuguaglianza economica. È una cosa davvero rara potersi permettere, all’interno di una mostra, di aprire così tanti livelli di lettura e approfondimento.
LB: Esatto, dal mio punto di vista è centrale anche la dimensione site-specific della mostra, perché come spiegavi prima le fondamenta narrative partono proprio dalla collina dalla quale sorge l’Istituto Svizzero – e da quell’idea di detrito, che confesso mi ha catturato molto. Il detrito inteso anche come storia scartata, come ciò che resta fuori dai racconti ufficiali, come storia con la “s” minuscola. È stato interessante vedere come il discorso narrativo ricade in un modo quasi fisico dentro la mostra: salivi e, attraverso il percorso espositivo, ripercorrevi le storie delle opere attraverso la metafora del dolce. Spesso l’apparato teorico curatoriale rimane molto scollato dalle opere all’interno delle mostre, separando bruscamente la ricerca teorica dalla curatela; invece in “Con lo zucchero in bocca” è come se pratica e teoria, curatela e opere, avessero parlato la stessa lingua.
LCV: Ad evitare questo scollamento secondo me ha aiutato molto anche A partire dal dolce (1979) l’opera di Gianfranco Baruchello presente in mostra.
LB: Sì infatti si percepisce un rapporto speciale in generale con Gianfranco Baruchello. Penso per esempio alla mostra “Get Rid of Yourself (Ancora Ancora Ancora)” del 2019, presso Fondazione Baruchello; progetto che hai curato e che era stato selezionato anche da lui stesso. Hai deciso di “partire dal dolce” e la relazione di Baruchello con Roma, o è stato un caso?
LCV: Non ci avevo mai pensato, però la mia esperienza a Roma è stata molto legata al lavoro su quella mostra alla Fondazione Baruchello, che aveva a sua volta dei risvolti politici piuttosto densi. Guardandola ora, mi sembra incredibile: era appena uscito il primo decreto sicurezza di Salvini e in mostra, tra la storia di Mina e le strategie sovversive dei black bloc, c’era un discorso che trovavo in quel momento importante fare sull’invisibilità e la visibilità rispetto allo spazio politico in cui vivevamo.
Se penso a come si è evoluto lo scenario politico da allora, il primo decreto sicurezza era niente rispetto a quello di quest’anno. È incredibile quanto fossimo tutte profondamente toccate da quella situazione, anche le artiste che avevo coinvolto, e che oggi sia peggiorata in modo così radicale.
È stato proprio in quell’occasione che ho scoperto che la Fondazione Baruchello stava restaurando, per la prima volta, il film A partire dal dolce. Quindi avevo in mente quel lavoro già da tempo. Quando ho cominciato a pensare alla mostra per l’Istituto Svizzero, era qualcosa che avevo nella retrocamera del cervello e che poi è diventato una sorta di fil rouge della mostra, disseminato in sette schermi nelle varie sale della villa.
A partire dal dolce è questo progetto in cui Baruchello approfondisce il concetto di dolcezza attraverso una ricerca corale che ha coinvolto persone della scena parigina che frequentava in quel periodo, tra filosofə, cuochə, e persone che lavoravano nelle fabbriche di dolci [Pierre Klossowski e Denise Marie Roberte Morin-Sinclaire, Jean-François e Andre Lyotard, Felix Guattari, Noëlle Châtelet, pasticcierə come Boris Tissot, lavoratorə impiegatə nelle fabbriche di caramelle. Videoriprese di Alberto Grifi. N.d.A]. Tutte queste conversazioni per me erano interessanti perché, riproposte nello spazio espositivo, continuano ancora oggi, attualizzandosi: le opere in mostra si mettono in dialogo con quegli stimoli, finendo per porcile stesse domande.
La cosa più sorprendente, che devo ammettere non sapevo all’inizio (sembra perfetta, ma in realtà l’ho scoperta dopo aver deciso di inserire quest’opera in mostra), è il motivo per cui Baruchello inizia questa (quasi ossessiva) ricerca verso la dolcezza.
All’interno dell’Agricola Cornelia S.p.A1 – quel progetto in cui aveva occupato delle terre e aveva cominciato a coltivarle, come critica alla land art – si era trovato a gestire un’iperproduzione di barbabietole da zucchero. C’è questa fotografia iconica: un cumulo di barbabietole enormi che non potevano essere lavorate dal macchinario e che restavano lì, come una sorta di monumento. Da quel momento Baruchello inizia a riflettere sulla dolcezza. Mi è sembrata una coincidenza clamorosa, ed è diventato così il nume tutelare della mostra: una presenza fantasmatica che accompagna tutto il percorso.
LB: Infatti questa idea di diffonderlo nello spazio espositivo era anche per metterlo in relazione con le altre artiste? Oppure era più per renderlo un centro, il cuore pulsante della mostra, qualcosa di ancora più presente?
LCV: Sì in un certo senso, credo che i frammenti del film dialoghino in modo profondo e poetico con le opere in mostra. C’è un bellissimo passaggio del film in cui Felix Guattari costruisce una narrazione sul rapporto che per lui ha la morte con la dolcezza, raccontando di come sua nonna, facendo la marmellata, usava coprirla con dei giornali per evitare che le mosche ci si posassero sopra. Quando poi morì suo nonno, il cadavere venne coperto a sua volta, sempre dalla nonna, con dei giornali, per lo stesso motivo:evitare che le mosche ci andassero sopra. In questa sovrapposizione delle due immagini si trova una profonda – e quasi cannibalistica – relazione tra la dolcezza e la morte. Ho deciso di utilizzarlo come il primo frammento di A partire dal dolce che si incontra in mostra, accanto all’opera Resurrection Ranch di Virginie Sistek, dove le mosche sono un elemento di transizione tra vita e decomposizione, creando un cortocircuito di significati.
LB: Quel parallelismo tra le mosche come presenze “liminali” (attratte sia dalla dolcezza della marmellata che dalla carne morta) e il loro ruolo nell’opera di Sistek, nella quale estraggono qualcosa dalle cavalle, mi sembra per esempio suggerire un filo conduttore tra la dolcezza e la morte, legato dalla fragilità e dalla cura. E l’idea che il video funzioni quasi a metà come qualcuno che visita la mostra e una delle opere, penso amplifichi e rielabori questioni radicali nella mostra, rendendo espliciti legami che altrimenti resterebbero sotterranei. Anche il posacenere (Next Day Delivery, 2024) di Gina Fischli che hai allestito sopra uno degli schermi video sembrava quasi il residuo di una conversazione che era avvenuta nello spazio poco prima che il pubblico entrasse.
LB: Ho trovato molto interessante anche come queste prime due mostre fossero metaforicamente legate a forme di straniamento.
“The House of Dorothy” – presso la sede di Milano di Istituto Svizzero dell’artista Vincent Grange – per esempio, permetteva l’ingresso attraverso un piccolo cunicolo dal quale gattonando si accedeva all’interno di una ricostruzione in scala reale di una casa privata: la casa di Dorothy. Li, si perdeva il confine con l’Istituto Svizzero, ma anche con la città di Milano, calandosi lentamente dentro a una ricostruzione metaforica della cultura LGBTQ+ attraverso spazi privati di una figura che c’è e non c’è, esiste e non esiste.
Dall’altra in “Con lo zucchero in bocca” era interessante come ogni opera, come dicevo prima, fosse quasi una piccola trappola visiva. Guardando per esempio Hell Rider (2025), le selle di Oz Oderbolz in queste stanze luminose, piano piano ti rendevi conto dell’importante estetica omo-erotica che dava forma alle opere, e quanto il cowboy non è altro che una costruzione culturale di virilità. Oppure all’ingresso, con il lavoro Resurrection Ranch di Virginie Sistek, che a primo impatto sembra quasi una ricostruzione favolesca di un piccolo Ranch, in realtà rivela questioni legate allo sfruttamento delle cavalle per l’estrazione di ormoni relativi alle implicazioni farmaceutiche per le cure della menopausa. Finendo quindi per riconsiderare, estraniati, il rapporto con le immagini, le cose e i simboli, dove il potere si rifugia nascosto.
Ti va di raccontarci come hai deciso di gestire questi “circuiti” all’interno dello spazio espositivo? E in che modo, se c’era questa intenzione, le mostre hanno avuto a che fare con il concetto di straniamento?
LCV: Per straniamento cosa intendi esattamente?
LB: Come se ci fosse una condizione di depersonalizzazione all’interno dei percorsi espositivi, che ci spinge fuori da una zona di confort, oltre la quale non siamo più in grado di riconoscere i connotati estetici che solitamente ci consentono di fruire le mostre. Mi sembra come se hai deciso di spingerti fuori da questa condizione attraverso un processo curatoriale che voleva spingere l’audience verso la perdita di controllo, dei punti di riferimenti e del linguaggio (culturale) attraverso il quale siamo solitamente abituati a riconoscere e interpretare certe immagini. Questa condizione l’ho trovata molto forte personalmente.
LCV: Nel caso della mostra “The House of Dorothy” nella sede di Milano di Vincent Grange, perdersi è proprio parte fondamentale dell’opera. L’idea che la Casa di Dorothy sia difficile da trovare, che ci sia un costante camuffamento, è proprio perché deve essere un posto sicuro. Dorothy è una fuggitiva – il progetto parte da un’indagine che il Naval Investigative Service fa partire negli anni Ottanta negli Stati Uniti sulla testa di Dorothy, nella convinzione che il codice usato dalla comunità LGBTQIA+ “friend of Dorothy” fosse un riferimento a una persona reale – e la comunità ha bisogno di uno spazio protetto dove potersi incontrare. Di conseguenza, c’è sicuramente il desiderio di rompere le aspettative rispetto al luogo d’accesso, per potersi poi ricostruire all’interno di questa visita alla casa. C’è questa presenza/assenza di Dorothy, che è un po’ fantasmatica — me ne rendo conto — e questo effettivamente accade anche a Roma, anche se in modo diverso; riguarda comunque il fantasma dell’edificio, o meglio, il fantasma della famiglia che sta dentro quell’edificio.
Anche lì, infatti, è una casa — che aveva una funzione domestica, oltre che una funzione di rappresentanza del potere. Ed era proprio questo l’aspetto che più mi interessava: questa sovrapposizione tra la vita familiare e la rappresentazione del potere. La villa era stata costruita per essere alta — si dice il secondo edificio più alto di Roma dopo San Pietro (poi non si sa se sia vero!) — ma sicuramente, a livello di auto-narrazione, c’era questa visione del potere.
Quello che mi interessava lì era proprio risvegliare dei fantasmi, e forse anche sovrapporre temporalità diverse, come dicevi parlando di straniamento. Le opere in mostra, infatti, sono quasi tutte realizzate con materiali poveri, e questo contrasto mi affascinava, perché la villa invece è lussuosissima: marmi, stucchi barocchi, sembra quasi un dessert lei stessa. Oltre a questo scarto tra architettura e opere, per me era importante il fatto che, in molti casi, questi materiali “umili” fossero già stati presenti nella villa nella sua vita passata. Penso ad esempio alle cavalle di Resurrection Ranch: nella struttura originale della villa c’era una stalla, uno spazio per cavalli. E poi i pomodori (Nero Sangue, 2020/2025) di Binta Diaw, le selle (Hell Rider, 2025) di Oz Oderbolz, le sedute di vimini (Tools for Bird Hospitality, 2025) e i guanti (Neighbourhood Birdfeed, 2025) di Sergio Rojas Chaves: sono tutti elementi che abitavano in passato la villa, anche se in forma diversa. E quindi sì, in questo loro ritorno c’è sicuramente qualcosa di straniante.
Una cosa che non è scritta da nessuna parte, ad esempio, è che nella scalinata di Villa Maraini c’era una gabbia per uccelli. Questo ritorna nel lavoro di Sergio Rojas Chaves, riportando a galla elementi che erano già lì, silenziosi, ma presenti.
LB: Sì, per esempio, mentre guardavo la mostra una cosa che ho veramente apprezzato è che, quando si arrivava davanti a un’opera, ad esempio all’inizio, nel porticato, dove c’erano le sedie di vimini e i guanti di Rojas Chaves; c’era quest’idea che guardavi un oggetto, lo riconoscevi come qualcosa di esteticamente molto piacevole, e poi arrivava quella sensazione straniante. Che però ti invitava a continuare a scendere dentro la mostra. Infatti, un’altra cosa che mi è sembrata evidente all’interno dei due progetti curatoriali, in modo differente ma in qualche modo anche adiacente, era la dimensione dell’invito. Invito a soffermarsi, invito alla comunità, all’ascoltare, al dibattito, ma anche a una certa pratica critica e politica dello stare di fronte e dentro le immagini. È stato un modo per creare subito una relazione con questa nuova audience oppure era una scelta dettata dal tipo di opere con le quali hai avuto a che fare?
LCV: Direi che sono emerse entrambe le dinamiche. Da un lato, nella mostra a Roma, c’era un elemento che mi ha dato grandissima soddisfazione: vedere come la fiducia nel pubblico sia ben riposta. C’è stata tanta risposta all’invito, soprattutto quando si tratta di riflessioni critiche e politiche scomode. L’opera di Binta Diaw (Nero Sangue, 2020/2025), che chiudeva idealmente il percorso, perché è un lavoro dopo il quale è difficile vedere altro, è composta di pomodori vetrificati che rimandano allo sfruttamento dei corpi neri nei campi, e che costruiscono anche una genealogia più ampia, fino alle piantagioni coloniali. Nonostante la densità del tema e il fatto che l’installazione fosse volutamente scomoda – i pomodori decomposti per terra, pensati per marcire durante la mostra – anche alla fine di una visita guidata, quindi magari con un po’ di stanchezza, succedeva una cosa per me abbastanza inaspettata: le persone rimanevano lì. Si creava un cerchio attorno ai pomodori, nel quale le persone volevano continuare a parlare . Era il periodo del referendum sulla cittadinanza, quindi emergevano storie anche legate a chi quei pomodori li raccoglie davvero, ma che mai otterrà la cittadinanza (il titolo del lavoro fa riferimento anche allo ius sanguinis). È stato bellissimo vedere questa disponibilità collettiva ad affrontare la condizione di disagio in cui un’opera come quella ti mette, piuttosto che evitarla.
Dall’altro lato, c’è l’esperienza della House of Dorothy, dove c’è sempre una sovrapposizione tra accoglienza e storie di lotta, tra momenti quasi giocosi e narrazioni durissime di omofobia trasformate in affermazione d’identità. A un certo punto abbiamo trovato una cartolina con un messaggio affettuoso lasciata da qualcuno dentro il salotto della casa per qualcun altrə segno che lo spazio era stato vissuto, non solo visitato. È come se si fosse rotta una soglia tra comprensione e partecipazione attiva. E questo lo puoi fare solo in un posto come l’Istituto Svizzero, che è gratuito per tutte le persone, realmente aperto – un dettaglio che sembra piccolo, ma che invece è essenziale.
LB: È vero, sì, perché poi partiva sicuramente anche dalla gratuità delle mostre, certo, ma anche dal fatto che erano delle installazioni; almeno nella sede di Milano, e che ti permettevano di stare lì, di prenderti il tuo tempo, anche un po’ da solo. Mi sembrava ci fosse questa cosa. Che a un certo punto ti isolavi. Ancora perso in quello straniamento: ti ritrovavi lì, immerso, e ti permetteva di stare dentro al lavoro, senza rumore, senza distrazioni.
Un’altra cosa che voglio condividere — che era parte del lavoro di Vincent Grange— è l’idea di sorveglianza. Ricordo di essermi confrontato con un amico a riguardo, e di come questa immagine ci è rimasta molto impressa. Ancora adesso mi mette i brividi. La sedia con gli specchietti all’interno della casa. Per noi è stato un momento fortissimo. Perché da un lato ti dici “ok, è un posto sicuro”, ma poi ti rendi conto che bisogna comunque guardarsi le spalle.
In una comunità come quella che “The House of Dorothy” metteva al centro, così fragile agli occhi della politica, la sorveglianza è una riflessione importante: trovarsi dentro una struttura che rappresenta una casa — che dovrebbe essere proprio l’immagine della sicurezza, del rifugio — e poi vedere che ci sono gli specchietti retrovisori. È stato davvero emblematico.
L’ultima domanda, anzi, più che una domanda è una piccola osservazione, riguarda proprio le due architetture dell’Istituto Svizzero, quelle di Roma e Milano. Ogni volta che visito queste due sedi, mi colpisce come i due luoghi si manifestino con connotati urbani molto specifici.
Quindi mi chiedevo: come si è relazionato il processo curatoriale con la progettazione delle mostre all’interno di questi due spazi? E soprattutto: questa dimensione identitaria delle due architetture ha influito, secondo te, sul lavoro curatoriale?
LCV: Sì, sono spazi difficilissimi ma bellissimi proprio perché ti obbligano a un confronto diretto. Parlano di aspetti molto diversi delle due città, e anche di due visioni diverse della Svizzera. A Milano hai quasi la sensazione di entrare in un ufficio, ed effettivamente gli spazi dell’Istituto sono affiancati dagli uffici veri e propri, rimandandoti alla Svizzera contemporanea, a una visione stereotipata legata alla diplomazia e alle banche. A Roma c’è tutta la storia della villa, la connessione con le altre accademie internazionali e il passato ingombrante del Grand Tour.
Nella progettazione del programma a Milano avevo deciso, con la mia prima mostra, di annullare lo spazio che trovavo davvero complicato. Quando ho incontrato il lavoro di Vincent Grange ho pensato fosse perfetto per questo scopo: abbiamo costruito una casa nascosta in uno spazio che invece, con quelle vetrate, è sempre visivamente accessibile. L’abbiamo trasformato in un contenitore mentale, che non c’è più come spazio fisico, nonostante il progetto sia poi molto radicato nella città di Milano, grazie alla ricerca che abbiamo fatto e alle conversazioni con attivistə, ricercatorə e curatorə legate alla comunità queer di Milano.
A Roma invece il ragionamento era opposto: confrontarsi direttamente con la villa, e l’imponente presenza architettonica. Lə artistə sono state fondamentali in questo. Per esempio mi interessavano molto i disegni di Milva Stutz non solo per la ricerca teorica sulla mascolinità, ma perché le piante che rappresenta dialogavano perfettamente con i marmi della sala – oltre che con il giardino che si vede dalle finestre, che si trasforma così in una sorta di luogo di cruising. Quando l’ho invitata, ha deciso di produrre nuovi disegni appositamente – uno esisteva già, gli altri li ha sviluppati per la sala e per i suoi marmi. È stato interessante vedere come tuttə lə artistə abbiano accettato questa sfida di confrontarsi fisicamente con questi spazi così carichi di significato.
La prossima mostra di Roma per esempio sarà completamente diversa: Pauline Boudry e Renate Lorenz lavorano spesso sul rapporto tra White Cube e Black Box, e molti spazi saranno all’oscuro per la maggior parte del tempo. Mentre a Milano Miriam Laura Leonardi e Gabriele Garavaglia lavoreranno sullo spazio attraverso un’installazione che utilizza la vetrata in modo tale da incorporare anche il cortile, facendolo diventare parte integrante della mostra..