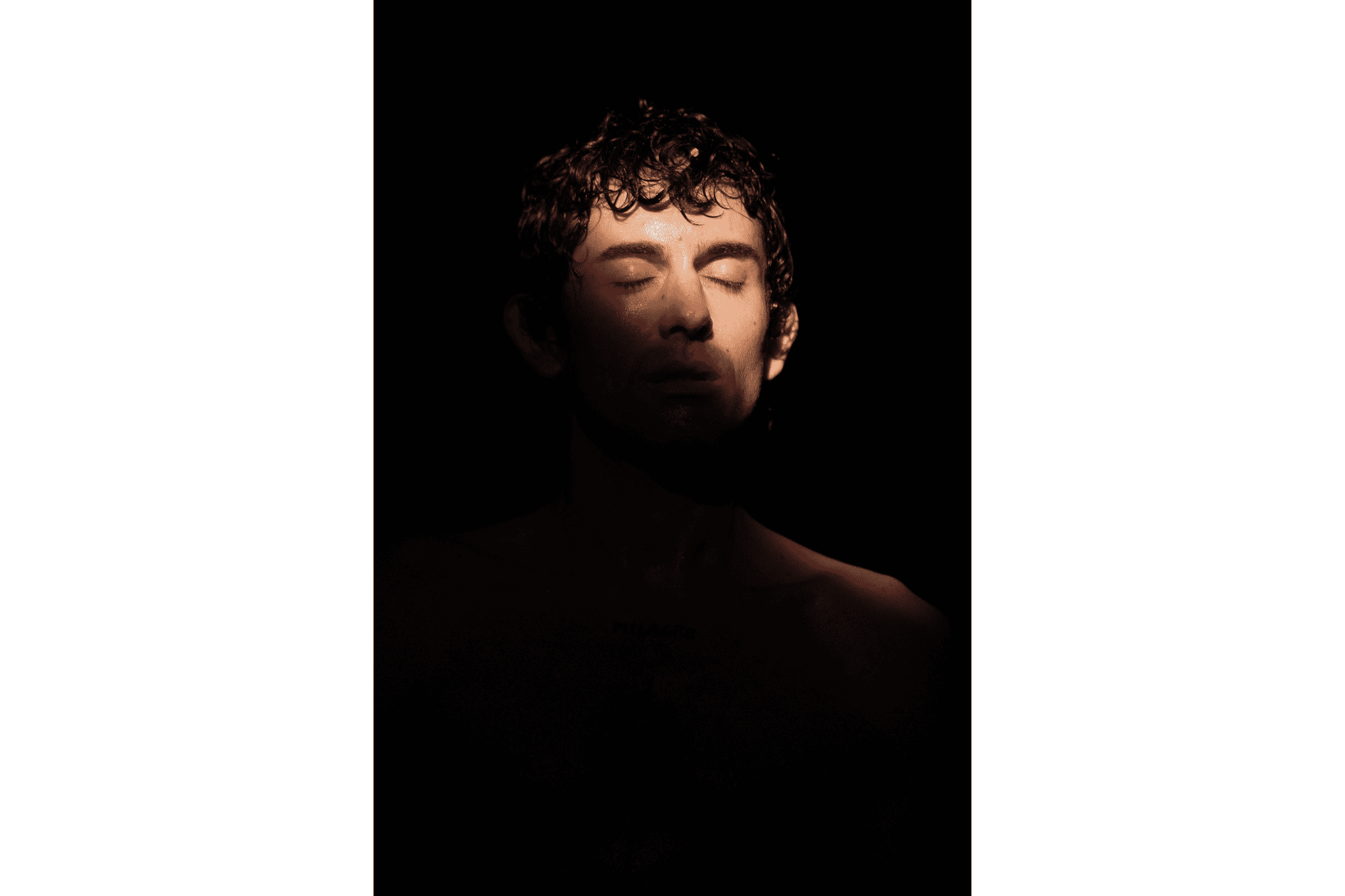Roma, 2 settembre. Per chi segue i movimenti dei festival significa una cosa sola: Short Theatre. Quest’anno la nuova direzione artistica si presenta come una costellazione anomala, capace di generare anomalie in un sistema di capi branco. Nei giorni precedenti l’apertura, hanno conversato tra loro in un clima sospeso, appena prima che le immagini – ancora immaginarie – prendessero forma o si disformassero. Una traiettoria attraverso condizioni turbolente, segno ricorrente del festival, e la scelta di muoversi in dinamiche atmosferiche piuttosto che in strutture rigide. Un’immersione a più livelli, dove le sezioni – SALON, LEOPARDO, CLASSE, CAMERA – agiscono insieme rimanendo autonome. Un attimo prima di Short.
Alberto Groja
Ilenia Caleo: Le prime cose alle quali abbiamo pensato riguardavano la dimensione dello spazio. Il desiderio non era quello di distribuire il festival in più luoghi e diffonderlo, ma di lavorare sulle intensificazioni delle presenze, in modo che modificassero lo spazio stesso. Abbiamo anche immaginato altri luoghi, non teatrali – stazioni, parcheggi – e poi è arrivato quello che sarebbe diventato il secondo spazio di Short Theatre: il Palazzo dei Congressi a EUR.
Silvia Calderoni: Cercavamo luoghi in qualche modo eccezionali. L’idea di eccezione non era solo spaziale ma anche temporale. Ci piaceva che il festival seguisse un tempo completamente disorganizzato, che fosse costantemente rimanipolato, boicottato, allargato, dilatato.
Michele Di Stefano: Abbiamo deciso fin dall’inizio – in modo un po’ istintivo – di restare a La Pelanda, di scendere in profondità in questo luogo, pur sapendo che l’incertezza era alta – ricordate lo spettro dei cantieri che ancora si aggira. Per controbilanciare questa decisione ‘stanziale’, abbiamo immaginato un trasloco immaginario: siamo andate a vedere luoghi assurdamente attraenti come il parcheggio di Villa Borghese, la stazione Tiburtina… no spoiler! La scelta di restare qui era motivata anche dal desiderio di confermare un gesto di abitudine legato alla rentrée, un tempo e un luogo riconoscibili per le comunità – La Pelanda – ma con un’idea di proiezione verso l’esterno.
Silvia Bottiroli: Anche a La Pelanda abbiamo fatto dei pensieri di scompaginamento dell’ordine degli spazi. Ci siamo immaginate di aprire tutte le porte, di renderla completamente attraversabile. Non tutto è stato o sarà possibile, ma abbiamo lavorato molto sulla Galleria, sulla sua conformazione lunga, che invita all’attraversamento e offre un affaccio su altri spazi. Abbiamo pensato poi a come disarticolare la cadenza degli appuntamenti, a sostituirla con presenze più lunghe e a scompaginare tempi e spazi interni anche rispetto alla natura degli oggetti. Spettacoli, saperi e altre forme popolano il programma fuori da ogni gerarchia: non sono gli spazi a definire la natura di qualcosa, né gli orari a dettarne l’importanza. Volevamo ricreare un disordine in un luogo noto e riaccendere piccole aree esterne che non sono mai state utilizzate, abbandonate da anni in questo cantiere perenne. Per noi era importante che l’intensità dello stare qui non seguisse solo percorsi già noti, ma aprisse nuove modalità di abitare e muoversi nel luogo.
SC: In un certo momento, abbiamo ritenuto necessario non organizzare l’immaginazione, scegliendo invece di lavorare nello stesso modo in cui i corpi, rispetto all’immaginazione, lavorano in sala prove. Tentando di individuare un andamento comune per le varie immaginazioni, come fossero tutte insieme un organismo condiviso, un fare collettivo non imposto da una griglia di organizzazione superiore. Questa esperienza è stata particolarmente significativa per me, poiché ha richiamato il lavoro dei corpi, che si organizzano e si auto-organizzano continuamente negli spazi scenici. Le nostre quattro immaginazioni hanno lavorato in questo modo, senza seguire griglie, facendo ‘sudare’ le idee. È stato molto forte.
MDS: C’è un principio di immediatezza di cui abbiamo sentito il bisogno. Liryc Dela Cruz costruisce il proprio stare nello spazio come una processualità scomposta, con accensioni e pause, e lo stesso vale per SALON. Avere la certezza che, accanto, vi sia un lavorio che funziona come un organismo autonomo, rappresenta la misura del nostro desiderio di imprevedibilità. Si tratta della volontà di non riconoscere tutto, di non poterlo incasellare, di assumere rischi in relazione alle scelte, che fa il paio con il desiderio di non avere alcun titolo. Non voler proporre una contenutistica: sebbene spargiamo numerose informazioni, desideriamo lasciare che si ricombinino autonomamente. È una voglia di turbolenza, di atmosfere, climi o ambienti…
IC: Ci siamo messe in una posizione di rifiuto verso l’idea di assegnare titoli o temi rigidi ai lavori artistici – non si è trattato solo di un posizionamento, ma di un processo costante di decostruzione e di continua messa in discussione di questo assetto. L’obiettivo era liberare i progetti – permettendo alle artiste di confrontarsi tra loro e di incontrare il pubblico senza filtri o ‘impacchettamenti’ preventivi. Non siamo le uniche a percorrere questa strada – per noi, però, non è stato semplicemente un punto di partenza: è stata una pratica continua di attenzione a non reintrodurre rigidità sotto altre forme. In questo contesto, la dimensione ambientale e atmosferica è diventata un’immagine guida – un modo per ritrovarci e restare immerse in quel processo creativo.
SB: Questa scelta ha coinvolto tutto il gruppo di lavoro e si traduce anche nel modo in cui il festival si racconta, nel non tentare di dare leggibilità ai lavori, ai discorsi, ai progetti o alle posizioni, ma piuttosto di favorire ambienti, esperienze, incontri – cercare di creare condizioni in cui i lavori possano incontrarsi tra loro. Riascoltandoci ora, mi sembra che stiano accadendo cose magiche e inaspettate – immaginari che si sono trasferiti, contaminazioni sottili che non erano facili da prevedere. Penso per esempio a Lyric, il cui lavoro affronta questioni meteorologiche: avevamo intuito la questione dei monsoni, ma ora la turbolenza è diventata centrale nel modo in cui sta abitando La Pelanda. Non era del tutto atteso – è come se ci fosse stato un contagio strano, difficile dire da dove sia partito, ma che si è propagato. Mi sembra importante ribadire questo passaggio rispetto al desiderio che abbiamo: riconoscere l’unicità di ciascun lavoro – ma al contempo dare valore e respiro agli spazi tra i lavori – al modo in cui si intersecano o si mettono reciprocamente in vibrazione, alle traiettorie con cui le persone li attraversano, li congiungono, li mescolano. Più che chiedere a un lavoro di essere preimpacchettato – di sostenere un discorso o di portare una posizione identitaria, culturale o artistica – cerchiamo di metterlo in un divenire, inserirlo in uno spazio selvatico e un po’ incontrollabile.
IC: Per me, ciò di cui stiamo parlando si raccoglie molto nel processo che abbiamo fatto con Noura Tafeche e in quello che ne è emerso. Noura stata una delle prime artiste con cui abbiamo iniziato a lavorare, è un’artista italo-palestinese con base a Milano, alla quale abbiamo chiesto di costruire e inventare la narrazione visiva del festival. Non stiamo parlando della grafica – piuttosto di un’opera, un processo artistico. Non la cornice grafica del festival ma un altro tipo di lavoro, che abbiamo pensato anche come una sorta di residenza, un tempo lungo, che rompe il frame temporale: una presenza che inizia molto prima e poi si manifesta, appare. Le abbiamo fornito un cumulo di parole – molte legate alla folla, al popolamento, all’affollamento, ai corpi ibridi, ma anche alle turbolenze e alle dimensioni atmosferiche. Lei ha preso queste suggestioni e ha lavorato prelevando immagini dalla rete, componendo poi una tavola della quale man mano condivideva frammenti, figurine, pezzi separati. Un lavoro che ricorda molto la pittura fiamminga o boschiana – un’allegoria senza senso univoco, ma con la giusta disposizione degli elementi. Un animale feroce che tocca un fiore appassito, una faccina intristita che manda bacetti, un mondo che vomita fiori, un drone in fiamme accanto a una figurina incendiaria – il tutto disposto senza un’indicazione di lettura, lasciando all’occhio libertà di muoversi. Non è un’immagine sintetica – è un’immagine-universo, un’immagine-mondo. La tavola scioglie la traccia del programma invece di riassumerla: ogni elemento influenza e modifica ciò che lo circonda – in latino si potrebbe dire ‘affetta’ – creando un gioco di relazioni, di contatti, di movimenti nell’aria intorno alle cose. Liryc Dela Cruz e Noura Tafeche – così come le altre artiste con cui abbiamo parlato – tutte hanno tradotto, a modo loro, le suggestioni che stavamo offrendo, contribuendo a costruire una presenza viva e interconnessa.
MDS: Stavo pensando alla ‘tecnologia’ boschiana di cui parla Ilenia: un assemblaggio che crea la moltitudine, con queste figure scontornate che sembrano fuggire dal contesto. È come se la definizione della figura producesse in realtà una nostalgia dello sfondo, del contesto. Una figura isolata, definita, ci ricorda la folla indistinta da cui proviene e ci illude in una sensazione di sintesi. Credo che anche noi, portando le nostre singole – quasi specialistiche – individualità, le abbiamo subito scontornate, allagate e ampliate, alla ricerca di questo sfondo possibile. C’è di sicuro un desiderio di fare spazio, e di costruire quello spazio a partire dall’atteggiamento e dall’attitudine dei corpi, anche del corpo singolo. LEOPARDO, per esempio, oltre a una dichiarazione di immediatezza, contiene anche questo desiderio e questa intenzione ambientale: la figura non si presenta semplicemente nel suo disegno, ma genera continuamente una possibilità di accesso, fa spazio. Idealmente, ogni elemento dell’insieme genera uno spazio di attraversamento proprio perché è accanto a tutte le altre cose. Desideravamo che fosse sempre visibile un lavorio in corso durante il festival e sentivamo la stessa necessità tra di noi. Così a volte si lanciavano nel gruppo idee molto complesse, nella certezza che sarebbero comunque passate in una centrifuga non organizzata che ne avrebbe sciolto le acutezze, in favore di una sfocatura carica di potenziale, perché non ‘accompagnata’. Questo ci ha sorpreso e interessato molto ed è stato un modo intuitivo di procedere fin dall’inizio.
IC: Tornando a quanto dicevamo sul lavorare insieme, quel ‘pre’ da cui siamo partite – che poi abbiamo superato – ha dato origine a questa raccolta di immagini. Andavamo a vedere alcuni spazi insieme, li osservavamo e discutevamo, e altri invece li raccontavamo a Silvia (che non vive a Roma), trasferendo emotivamente e affettivamente le nostre esperienze, non solo descrivendo gli spazi per come sono, ma anche per come li percepiamo, stratificati nelle nostre esperienze, nei nostri vissuti e nelle nostre relazioni. Facevamo foto e pratiche di scrittura in tempi non sincronici: qualcuno scriveva di notte, e quei fogli venivano letti magari giorni dopo. Anche se questo processo non ha prodotto un testo definitivo – anzi, siamo state estremamente asciutte – il nostro lavoro è stato un vero percorso di scrittura continua: non tanto per creare un testo, quanto come pratica, come traccia dei corpi e delle esperienze. Appunti su cui riscrivevamo continuamente.
SB: È stato anche un continuo tornare sulle cose. Ripensando alla sfocatura, mi rendo conto che allo stesso tempo, in quel processo, sono emerse presenze molto definite, delle quali a un certo punto non potevamo più fare a meno: incontri, innamoramenti, proiezioni su lavori possibili, immagini singole. Ascoltando questa costellazione di corpi, intensissima e stupenda, ho avuto la sensazione che racchiudesse qualcosa di essenziale. Alcune immagini, da cui non siamo riuscite a staccarci, forse non appariranno in modo nitido nei giorni del festival, ma dentro quella sfocatura e su quello sfondo sono emerse con ancora più forza. A volte non si trattava della totalità di uno spettacolo, ma di un’immagine soltanto: un dettaglio, un riferimento, o persino un’immagine che, parlando con le artiste, quel lavoro ci ha evocato.
MDS: È un fatto molto preciso: allargare la visione e sfocarla ti permette di cogliere dettagli che altrimenti non individueresti. Ci siamo divertite molto a esercitare una certa vaghezza, per fare in modo poi di attrarre la nitidezza. È vero che alcune di queste chiarezze non siamo riuscite a esprimerle, per limiti economici o logistici, ma anche in questa difficoltà, nella reazione alle circostanze, abbiamo trovato nuove fonti di interesse e di ricchezza. C’è poi un punto di vista strategico, che guarda a un orizzonte più ampio, già proiettato oltre quest’anno, e c’è un esercizio tattico, molto leggero sul presente, che è stato bello condividere momento per momento.
SC: Quel che dici – allargare la visione e sfocare – credo ci sia stato suggerito anche dal secondo spazio del festival. L’ultimo weekend, infatti, abbiamo deciso di emigrare: lasciare La Pelanda e spostarci tutte a EUR. Qualsiasi cosa immaginiamo lì – lo spazio essendo così grande, eccezionale, eccessivo, eccedente, e maestoso, a tratti persino insopportabile alla visione – è costretta a essere sempre un frammento di qualcosa di molto più ampio. Ed essere parte di un frammento dà una grande libertà alla visione, perché ti permette di andare altrove. Per questo, dal punto di vista della sovrastruttura, abbiamo alleggerito tantissimo: niente tribune, niente quinte. Anche dal punto di vista illuminotecnico, la scelta è stata leggerissima, proprio per lasciare la possibilità di avere uno sguardo libero. Anche di perdersi coi corpi. Chissà, magari qualcuno del pubblico, invece di andare a vedere uno spettacolo, sceglierà di sdraiarsi e stare nel silenzio di una delle stanze. Mi sembra che questo abbia molto a che fare anche con il discorso sulla tavola di immagini di Noura: come se la stessa idea ritornasse, in forme diverse.
IC: È architettonicamente interessante andare al Palazzo dei Congressi perché è lo spazio stesso ad andare contro tutto: è un’architettura concepita per escludere i corpi. Nella sua progettazione totalitaria e fascista non c’è bisogno dei corpi: l’edificio a se stesso. Andarci è compiere un contro-movimento. Ma è anche il segno del fallimento di quel progetto: un quartiere fallito, palazzi semivuoti e abbandonati, plafoniere magnificenti che funzionano a intermittenza. Tra quel progetto di visione totalitaria e questo fallimento, che possibilità c’è? Non lo sappiamo veramente, no? Però andarci è anche per noi un gesto estremo: come può un corpo, nella sua dimensione assolutamente transitoria, carnale, di passaggio, aleatoria, modificare anche solo per un attimo una struttura storica e monumentale? Poi non rimarrà traccia di questo nostro passaggio, ed è così che accade. Per questo sono curiosa: come si disporranno i corpi in volumi tanto grandi? Come si disporranno i corpi degli spettatori e delle spettatrici?
MDS: Stavo pensando che, da un lato, quella volumetria, quelle superfici di marmo, ma soprattutto quella vuotezza e quella cassa di risonanza estrema – in qualche modo (forse quando hanno progettato questi spazi non era chiaro) – sono come un canto della sirena per il corpo. Cioè, qualcosa di molto attraente. Anche quella struttura sul terrazzo, un teatro di marmo iper-irregimentato che sembra un cimitero di guerra, per me è come se fosse un reticolo che possa fare da supporto alla crescita scomposta dell’edera. Prova a dare delle direzioni, delle ortogonalità, ma in realtà favorisce un brulichio. La mia è una rilettura: la funzione originale suppongo fosse un’altra. Sento che quel posto ci può offrire condizioni interessanti per la convocazione dei corpi, ed è paradossale che accada per me nello stesso modo di La Pelanda, anche se le temperature dei due spazi sono completamente diverse. La Pelanda è evidentemente l’interno di un tram all’ora di punta: tutto sembra vicino, prossimo, affollato, una cosa sta sull’altra, ed è proprio questo che ci piace. È come se lì, all’EUR, riuscissimo a uscire da quel labirinto e ad aprirci a un’atmosfera più complessa. Ma alla fine, sono entrambi spazi con lo stesso obiettivo: creare prossimità fra i corpi.
SB: In qualche modo, Palazzo dei Congressi è un invito a scontornare anche gli spettacoli. Penso ad alcuni lavori che saranno in spazi vuoti, senza strutture dedicate, senza una scatola nera, mentre altri si inseriranno nello spazio in modo parziale. Il lavoro diventerà, in parte, trasparente rispetto a ciò che rimane visibile, penso ai foyers, e poi a tutta l’idea di LEOPARDO, che invita singoli corpi di performer ad uscire dallo spettacolo. In questo modo il festival lavora su una soglia: da un lato protegge e presenta dei lavori performativi specifici, dall’altro intercetta la creazione fuori dalla produttività, libera i movimenti dalla coreografia di uno spettacolo. Si tratta di sperimentare, di scontornare i corpi in scena o di fare inviti che, da un lato, ci sembrano quasi folli qui, in uno spazio così ampio e complesso, e dall’altro mostrano come il festival possa rimettere in tensione qualcosa che già si percepiva negli inviti fatti a La Pelanda. È quella soglia tra l’oggetto performativo – un incontro denso, importante e unico, che va salvaguardato – e tutto ciò che si dilata attorno. Quello sdoppiamento che, a La Pelanda, avviene soprattutto grazie alla prossimità, a Palazzo dei Congressi lo immagino ancora di più nella possibilità di incontrare scene singole o immagini che nascono da questo doppio livello, lavoro e spazio (che per lo sguardo non è mai neutro).
MDS: Al Palazzo dei Congressi affrontiamo anche un problema specifico: l’esposizione del corpo. La forzatura è letterale: siamo nel quartiere dell’Esposizione Universale di Roma. Così abbiamo scelto di esporre il corpo alle intemperie, prendendoci qualche piacevole rischio.
IC: Altre cose non forzate né sottolineate ma coincidenti: pensiamo ad un incontro previsto in CLASSE dal festival – Roberto Esposito e la macchina metafisica del fascismo – e al fatto che alla fine accadrà proprio lì, in questo momento storico in cui l’estrema destra sta riconsolidando quei sistemi, riposizionandoli e rimuovendoli. E noi ci siamo ritrovate esattamente in quel punto. Non lo so: per me sarà bello vedere noi, insieme a tutte e tutti, a tutti i corpi che attraverseranno quello spazio per 48 ore, in quel luogo, proprio dentro, come un alveare di api nella testa della statua del Monumento.
MDS: E la cosa bella è che il viaggio è senza ritorno: traslochiamo completamente in quello spazio nelle ultime 48 ore del festival, e finiamo lì con quest’idea di apertura, di estuario, di lancio nel vuoto, si spera.
SB: Ed è anche il luogo in cui stiamo di più su quella soglia tra dentro e fuori, sullo spazio pubblico, anche rispetto alle politiche di destra odierne, e a tutta la questione della criminalizzazione del creare turbolenza in uno spazio pubblico. È proprio lì che si generare una piccola intemperie, in qualche modo programmata. C’è anche la questione di come stare nella città di Roma: da un lato, come dicevamo all’inizio, cercando di creare densità anche in luoghi altri e inattesi; dall’altro, interrogandoci su come evitare di chiuderci in luoghi sicuri. Ma anche: come stare sulla soglia dello spazio pubblico, intercettando anche chi non sceglie di accedere ad uno spazio teatrale e inciampa nelle immagini che il festival crea. E questa soglia, che il festival creerà anche fuori dal Palazzo, nello spiazzo antistante, nel luogo della PIOGGIA, è una delle immagini che ci accompagnano negli ultimi giorni.
MDS: C’è una certa reticenza a descrivere quel che avverrà in PIOGGIA, perché non vogliamo che venga definita. È uno di quei momenti in cui c’è molto poco di previsto o preconfezionato. C’è il desiderio che questi corpi vengano in contatto diretto con le forze della natura, con le forze dello sguardo. C’è una sensazione – di cui parlavamo prima – di solitudine feconda, dove tutte le figure si succedono solitarie, una solitudine che evoca collettività. C’è un desiderio di corruzione, di dissolvenza della figura. Forse una delle cose che stiamo facendo – e continueremo a fare – è un esercizio alchemico sui perimetri, sui confini delle cose. Ripenso anche ai momenti in cui abbiamo provato a mettere ordine, con tutti i tentativi di cartellonistica ad uso interno o di avere un ufficio più canonico… tutte queste intenzioni di ortogonalità andate un po’ al macero.
SC: Sì, e soprattutto con PIOGGIA sta succedendo molto: stiamo cercando di resistere a tutto ciò che potrebbe essere un po’ rassicurante per noi. È come se cercassimo di rimanere sbilanciati. Con ‘rassicurante’ intendo, per esempio, descrivere esattamente cosa succederà, o fare una scrittura precisa. Ci sono molte cose che potrebbero metterci in una condizione meno destabilizzante. Invece, resistiamo a questa tentazione di semplificazione, dove non si tratta più di lasciare le cose al caso o al caos, quanto di assumersi la responsabilità della tridimensionalità di un’atmosfera. Che, disordinata, resiste alla bidimensionalità della cornice.
IC: Per me, c’è anche una relazione con la città. PIOGGIA è una relazione con Roma che diserta l’ingiunzione dei bandi o del lessico dell’organizzazione culturale. C’è una dimensione affettiva e relazionale. A Roma una presenza molto forte è la presenza del cinema – non solo quello delle sale, ma il cinema quando lo si fa. Partivamo dall’idea di guardare al set cinematografico non con lo sguardo del cinema ma con il nostro, coreografico e performativo. Lo guardiamo come qualcosa che vale in sé, non solo per il frammento che produce nell’opera cinematografica, ma come momento di performance in cui tecnica, artigianalità e arte si mescolano. Perché non lavorare con alcuni reparti del cinema? Lì c’è qualcosa di intensivo, radicato nei saperi delle maestranze, simile a ciò che abbiamo trovato nei laboratori di scenografia o di costumi del Teatro dell’Opera, col quale abbiamo avviato una collaborazione. Sembrano mondi lontani dal lavoro della scena contemporanea, ma in realtà non lo sono: sono saperi profondi e specifici, non addomesticati e ancora un po’ selvatici. Per me, guardare dentro a questi processi è potentissimo, e crea un legame con la città che non è meccanico o didascalico.