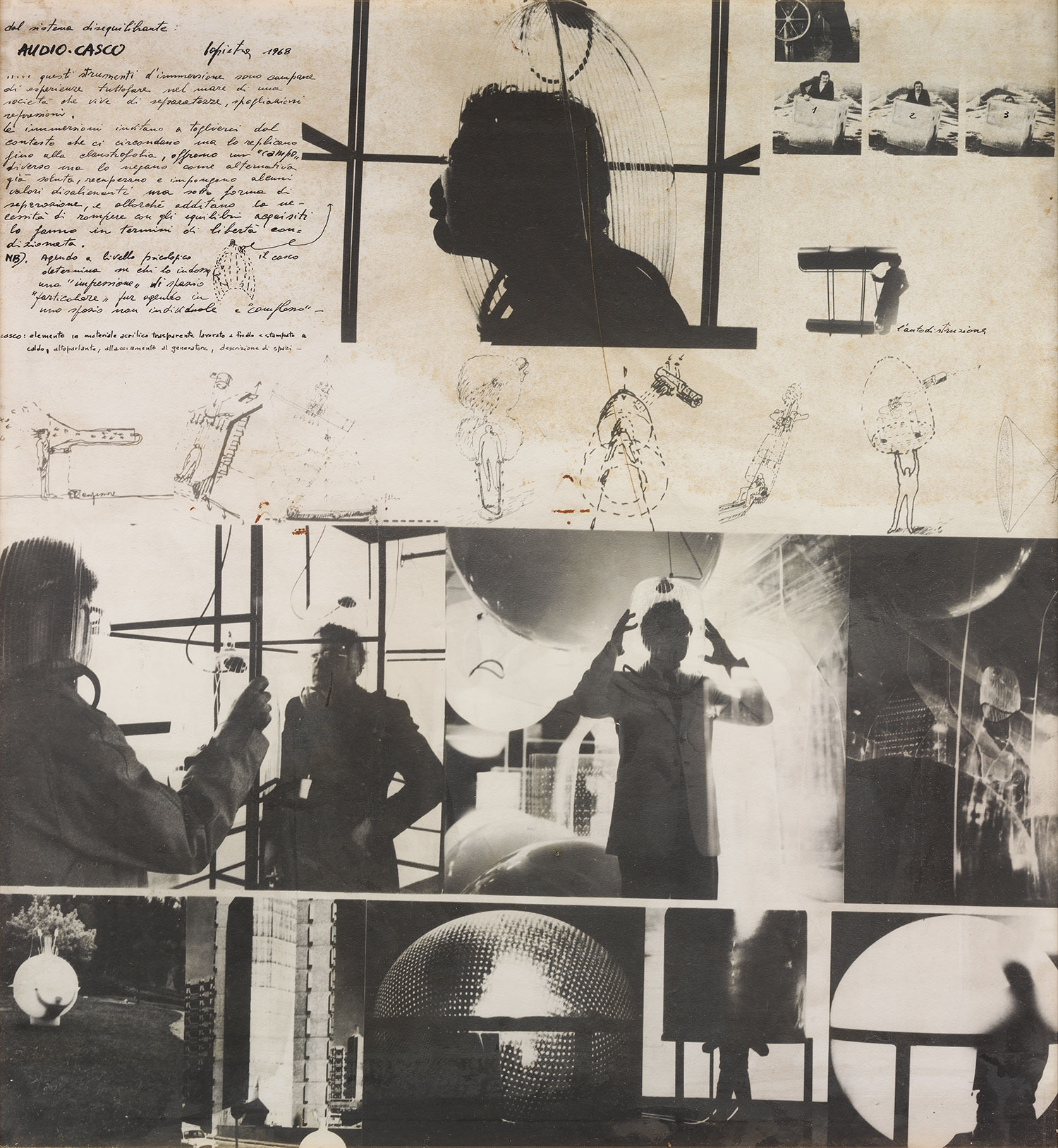“Cicala” è una rubrica bimestrale a cura di Manuela Pacella dedicata alla peculiarità dell’identità romana, tra dilatazioni temporali ed epifanici incontri con l’arte contemporanea. Mostre, opere e artisti sono raccontati in forma breve e derivata e la cicala diviene, con il suo ‘canto’ innamorato, metafora del desiderio di tornare a vibrare interiormente.

Dimensioni variabili: 170 x 150 x 30 cm circa.
Sette linoleografie su tessuti: cinque 157 x 50 cm e due 236 x 50 cm. Courtesy l’artista e la galleria
Debole, stanca, disillusa. Come la cicala che qualche giorno fa, in un angolo tipicamente romano, accanto agli archi delle mura Gianicolensi, emetteva un canto strozzato. Dall’alto di un folto pino mi osservava, tra motocicli elettrici lasciati alla rinfusa, in una pausa consueta tra un caffè e l’inizio di un altro pomeriggio. Studiava quella porzione di città e i passanti che procedevano barcollanti, cercando di non inciampare e al contempo di non essere presi di sorpresa da una macchina.
Al terzo tentativo la cicala ha cominciato a cantare con sicurezza, scuotendomi dal flusso di pensieri annoiati, rendendomi partecipe della meraviglia.
Mi sono chiesta quando fosse stata l’ultima volta che il mio corpo ha reagito in maniera spontanea e improvvisa, vibrando interiormente, emettendo senza preavviso un flusso emotivo tale da lasciarmi senza fiato. E quando una tale reazione è stata procurata da un incontro inaspettato con un’opera d’arte. Non è accaduto molto tempo fa, e questo rassicura. Troppo spesso rimproveriamo i nostri giudizi affilati sul mondo come unicamente dettati da un tempo che avanza, dalle molte vite vissute che pensiamo ci abbiano indurite. Non è così. Non solo lo dimostra il risveglio globale dal torpore endemico in cui eravamo avvolte. Lo rivelano anche dettagli quotidiani che hanno il potere di strappare un sorriso, e a Roma, se si è all’erta, ne accadono di continuo. A me ad esempio, per farmi avanzare nella giornata con un guizzo di vitalità ritrovata, basta poter assistere a brevi scambi tra pensionati attorno ai tavolini in plastica di un bar che si credeva oramai inghiottito dalla gentrificazione del quartiere di turno. Camminare immersa in pensieri sulle cose da fare e di colpo sentire la frenata di una macchina dal cui finestrino fuoriesce una testa che urla “Aó…” e seguire il mittente di quel saluto che risponde: “A catenacciooo….!” mi ricorda il motivo per cui non tento più di lasciare questa città.
Non c’è alcuna differenza tra questa scena così romana e un’altra, molto padana, descritta assai bene da Roberto Longhi: “… i pioppi tra le case, domestici; fra porte ed androni le galline che beccano nell’ombra fresca; nell’alto le luci ultime che toccano le fronde degli alberi, ungono la bocca della cella campanaria”1. Lo storico dell’arte si riferisce allo sfondo sulla destra della Madonna del Latte di Bergognone (1485) conservata alla Pinacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo. Lo specifico dettaglio di questo quadro, con le galline e, subito sopra, l’arco e tutto un gremire di tempo e vita mi ha procurato non molto tempo fa una reazione quasi inspiegabile. Delle lacrime sono uscite dai miei occhi, senza preavviso. Appena ne ho preso coscienza ho provato a nascondere il mio volto all’addetta di sala, unica presente, quasi ne provassi vergogna. Per giustificare quella commozione ho ricominciato a guardare cercando appigli storico-artistici a quella reazione: lo stile della pennellata, la fuga prospettica che mi ha trascinata in quello spazio-tempo. Ma era ed è più semplice. Sono i dettagli della vita di ogni giorno, che ci pungono talmente in profondità da farci riconnettere all’incanto e aderire nuovamente a ciò che davvero conta.
Come la cicala voglio tornare a vibrare per restituirvi in questo breve spazio testuale scorci di realtà e di corpi che all’unisono tornano a cantare, di coscienze che si risvegliano e scoprono che la solitudine in cui si era intrappolate per troppe torride estati è passata. Esattamente come è accaduto lo scorso primo ottobre, quando l’apertura di un nuovo spazio espositivo ci ha fatto scoprire una di quelle strade chiuse romane ancora colme di artigianalità e comunità ben lungi dall’essere scomparse. Si tratta di Cantadora (dal castigliano “cantastorie” ma anche in riferimento diretto a Candida Mara, portatrice della memoria collettiva), fondata da Enrico Palmieri e Flavia Prestininzi che hanno scelto di cominciare la stagione portando in città il collettivo indonesiano Taring Padi che in una prima fresca serata autunnale ci ha cullati con musica e canto, attraverso una versione contemporanea del Wayang Beber, un’antica forma teatrale indonesiana, le cui parole esortative finali mai sono state più pertinenti:
“Sorgete, lavoratori dell’arte e della cultura,
muovetevi insieme al popolo oppresso
per incontrare l’alba rossa e luminosa,
unitevi tutti, distruggete i falsi valori culturali…”