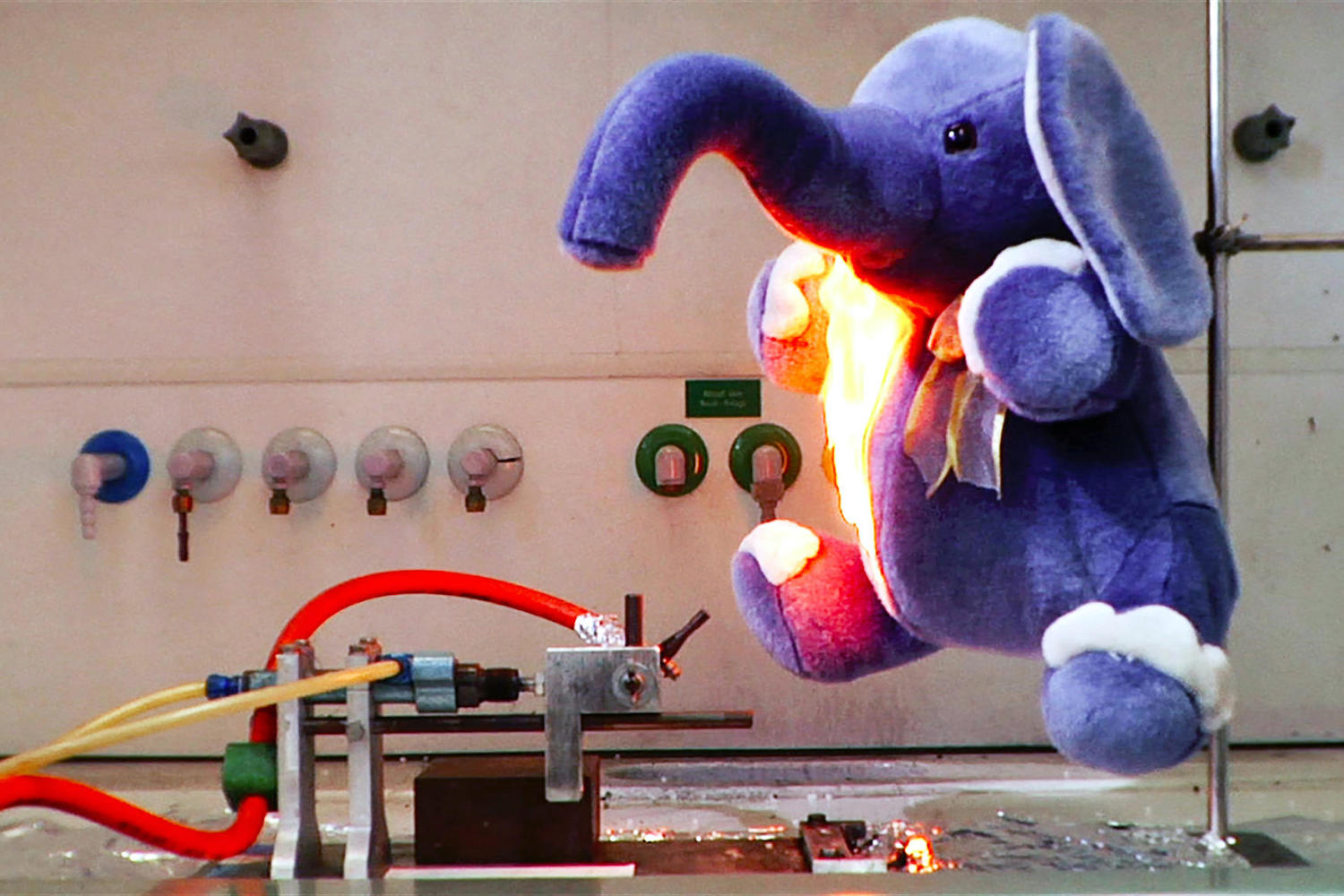Quando sono uscito di casa per andare da radar, mi sono mosso a piedi. Venti minuti per attraversare tre città diverse: prima quella cementificata dei palazzi e delle strade, poi quella familiare e affettuosa al cortile interno del condominio in Via Plinio 11 e infine, sotto il livello urbano, quella rarefatta della galleria, con la mostra “Città, città” di Ludovica Carbotta.
Lo spazio qui è diviso. In realtà le città sono due: parti di un intero che non c’è più, «versioni diverse delle stesse cose» come scrive Carbotta nel testo che accompagna la mostra, che aspettano ferme senza riuscire a vedere le loro gemelle sfasate qualche metro più in là, oltre le pareti in legno che dividono la stanza. Come vizio di consequenzialità, si potrebbero immaginare queste due città come momenti temporali diversi e collegati da una qualche causa: un prima e un dopo, una storia da raccontare. E invece anche camminandoci attraverso, all’inizio, è come se si insinuasse la constatazione di una paradossale convivenza spazio-temporale, scenario di una strana, provocante, solitudine. Come quella del romanzo di China Miéville, La città e la città (2009) – che ha inizialmente ispirato Carbotta per questo progetto – ambientato nelle immaginarie città-stato di Besźel e UI Qoma, divise e alienate l’una dall’altra a causa di un ignoto evento di separazione, chiamato nel libro “Frattura”.
C’è un punto, nello spazio di radar, in cui si può tuttavia passare dall’altra parte: un’apertura non condizionata dalle due pareti divisorie, chiamate entrambe Città, città (blocco temporaneo) dove lo sguardo può fare da messaggero ideale tra le due aree, posandosi su entrambe e vedendo come esse siano accomunate da una stessa progettualità e tensione. Sostare in questa frattura, e quindi, accogliere nel movimento di qua e di là lo sfaso delle cose, non fa altro che confermare quanto “Città, città” è una mostra in cui il corpo conta tanto. Stando fisicamente in questo punto infatti, si perde la percezione di dove finisce una e dove inizia l’altra, lasciandomi pensare al fatto che nel titolo della mostra le due città siano divise non da un punto ma da una virgola, come una intermittenza in una frase che naturalmente continua e si espande altrove.
Ma di che città si tratta? Nelle due aree si incontrano, specularmente, sei (tre + tre) buste di lino con dentro quelli che possono sembrare calcinacci o pezzi irregolari di un qualche muro o struttura — Città, città (macerie) (2025) – due (uno + uno) calchi in resina di una ruota di bicicletta su cui si innestano altri pezzi di legno come possibilità di una futura impalcatura – Constructoras de mondo muy parecidos al nuestro (ruota verticale) (2025) e Città, città (ruota) (2025) – e due (una + una) carriole piene di altri cocci rotti, che come le macerie dentro le buste di lino non sono dei ready-made, poiché si tratta di sculture di ceramica, acciaio e gomma di pneumatico – Città, città (carriola) (2025) e Città, città (carriola quattrocchi) (2025).
L’allestimento rivela un cantiere più che una città, o forse le due definizioni si sovrappongono, come a voler materializzare nello spazio di radar tutte quelle possibilità residuali che la forma della città può assumere, diventando ogni volta una “versione diversa della stessa cosa”.
Carbotta scolpisce dei cocci rotti, assembla impalcature molecolari, fermandosi appena prima di raggiungere una qualsiasi immagine cementificata – letteralmente e metaforicamente – del corpo urbano. È una città finzionale, simbolica e presa “contropelo” – per citare Georges Didi-Huberman quando parla della storiografia di Walter Benjamin – nella sua trama di possibilità, latenze e intermittenze, configurando un’esperienza site-specific e portando poi all’estremo assoluto questa definizione, slegando la città da qualsiasi contesto specifico (cementificato) e considerandola invece come immagine dialettica: la capillare intuizione di una progettualità.
C’è molta ‘prendibilità’ nelle opere di Carbotta: le buste di macerie sono pronte per essere prese e portate via; i manici delle carriole invitano allo spostamento, i calchi delle ruote di bicicletta e le strutture in legno lasciano immaginare possibili sviluppi costruttivi, nuove rimesse in moto del cantiere; i manifesti sulle pareti temporanee potrebbero essere staccati, integrati, modificati. Si stratta di avvisi di manifestazioni, proteste e lotte diverse e comunque legate, ai lati opposti del blocco temporaneo al centro dello spazio. Non si vedono ma condividono l’urgenza di un agire, seppur in contesti diversi, per ribaltare collettivamente la solitudine urbana e decostruirne il carattere inevitabile di destino. I residui di “Città, città” lasciano intuire questa possibilità generale, aprendo la strada a una pratica di militanza minima, sottile e affettiva, che opera tanto nell’immaginazione quanto nella prassi quotidiana in nome di una rinnovata tattilità del corpo urbano, ora sfrangiato in un corpo di possibilità.
Come a ritornare all’intelligenza tattile dell’infanzia – terribilmente libera di distruggere e ricostruire i cocci simbolici del suo mondo sconosciuto – la “Città, città” di Ludovica Carbotta si può simbolicamente toccare, plasmare, e da essa essere cambiati, in un gioco reciproco di sfioramenti e sovversioni. La base del divisorio in legno è realizzata con un calco in resina blu: ricorda il mare o una roccia aliena irregolare, che conserva le impronte di una piccola mano, alcune escrescenze quasi organiche, e il disegno di una barchetta che fluttua nel blu – un’immagine molto potente che indica la possibilità di un andare. Queste sono le tracce che sorreggono la “Frattura” e sottilmente la demitizzano, sottolineandone il carattere temporaneo e modificabile.
Tra le due città non c’è quindi un prima e un dopo, ma ogni coccio si incontra in un presente intensificato e morbido, in cui poter progettare nella rarefazione della città stessa. Persa la propria sintassi, appena prima di indurirsi, “Città, città” si rivela un ammasso di atomi in movimento, in cui, riprendendo le parole dell’artista: «La solitudine diventa moltitudine, una moltitudine di sguardi individuali uniti nelle stesse battaglie».