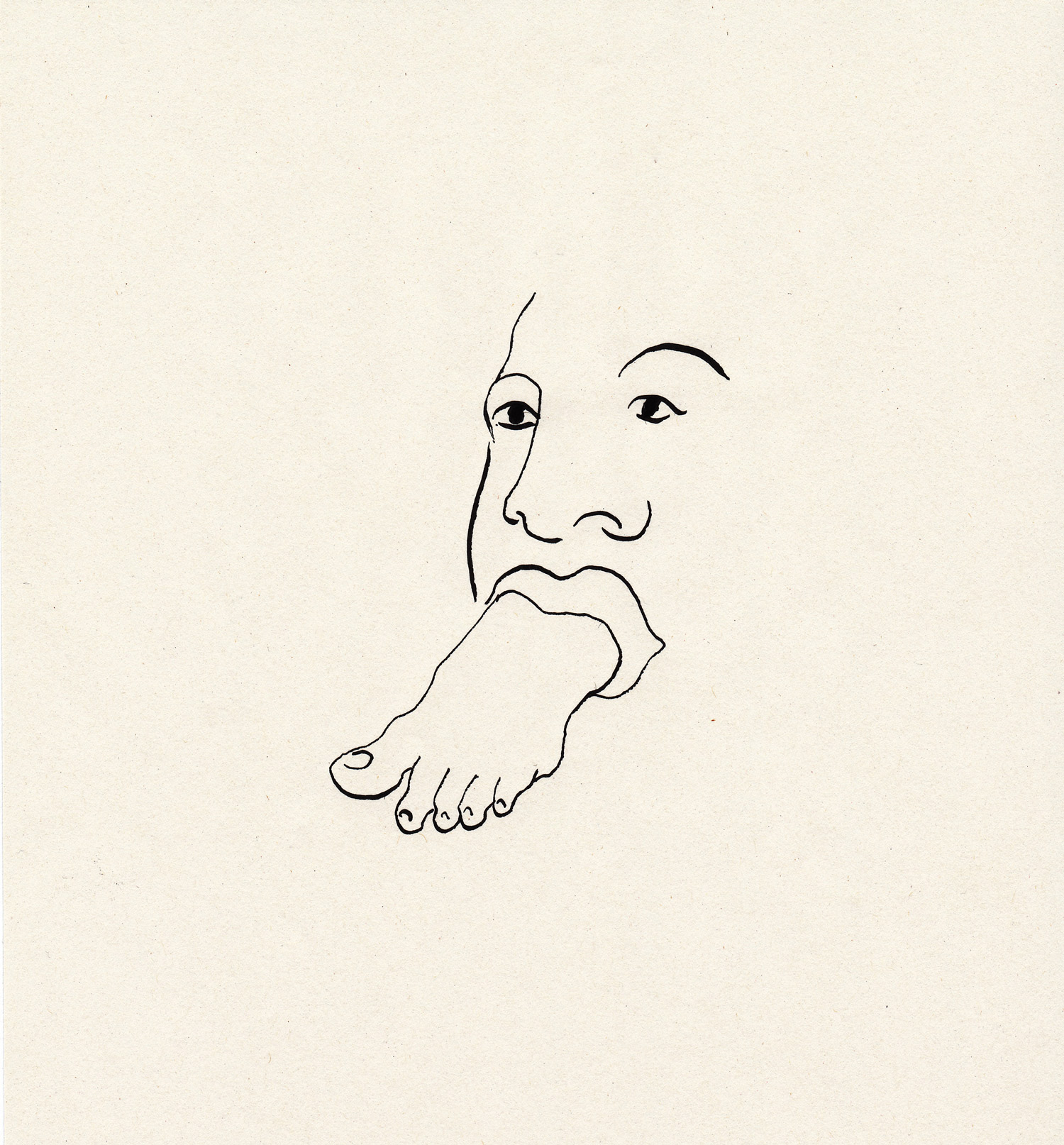Commentando il ruolo dell’Altro nella poetica di Samuel Beckett, il filosofo francese Alain Badiou afferma che “l’essere-due s’inscrive nel regime dei molti, nella stramba molteplicità degli animali umani. Sempre attento a ricondurre la proliferazione dei particolari a qualche tratto essenziale, Beckett dedica alcuni suoi testi a proiettare, sullo sfondo dell’essere umano, l’affaccendarsi dell’umanità plurale, catalogandone gli atteggiamenti e redigendo il repertorio delle sue funzioni. Quei testi sono delle commedie umane in cui la diversità delle figure sociali e soggettive è costituita dall’inventario, che si vuole esaustivo, di tutto ciò che l’esistenza contempla come possibilità concreta. Ma nel contempo sono anche delle divine commedie, perché la volontà di procedere alla catalogazione completa di azioni e situazioni […] presuppone un luogo immutabile, separato dalla realtà empirica […]. Come se, per accertarsi che la prosa prenda definitivamente possesso della pluralità umana, sia necessario fondare una sorta di eternità, un laboratorio separato da cui si possano osservare in modo atemporale gli animali oggetto di studio” (Beckett. L’inestinguibile desiderio, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2008, pp. 28-29, sott. mia).
Si potrebbe proseguire il ragionamento di Badiou, fino a sostenere che il “laboratorio separato” dal quale si possono osservare gli animali umani coincide con i media contemporanei, fotografia, cinema e video. Ma anche così, la sovrapposizione non sarebbe completa, o non sarebbe esplicativa, se prima non si precisasse come mai l’arte contemporanea ha sentito l’esigenza di impiegare esattamente questi media come strumenti linguistici sentendoli ad essa adeguati. Tale spiegazione proviene ancora dal modo con cui Badiou conduce la sua analisi su Beckett, che va, per sua esplicita ammissione, contro le interpretazioni più accettate, che tendono a vedere nello scrittore irlandese un cantore della crisi esistenziale dell’uomo. Al contrario, sostiene il filosofo, Beckett è un rigoroso scandagliatore dell’ontologia, dove la poesia assurge a un valore di analisi trascendentale delle condizioni di parola e di consistenza del soggetto. Di più, il discorso si allarga, secondo Badiou, a intendere tutta l’arte nel suo senso di contemporaneità, in quanto indagine sul punto di partenza dell’essere, che coincide non con la ricerca di una verità ineffabile sotto le apparenze, ma con la collocazione precisa dell’insieme vuoto Ø; non con la mistica dell’Uno, ma con l’identificazione esatta del “vuoto che separa l’Uno dall’Uno” (p. 48; cfr. anche A. Badiou, L’essere e l’evento, Il Nuovo Melangolo, Genova, 1995). In tal senso, il segreto dell’arte contemporanea coincide con il motto di Mallarmé: “Nulla avrà luogo fuorché il luogo”, ripreso dal verso beckettiano in Peggio tutta: “Il vuoto non può andarsene”.
E questo vuoto, lungi dall’esser un semplice “nulla”, è esattamente il vuoto colto dall’apparato mediale quando smette di essere ricoperto dalle apparenze, quando l’obiettivo fotografico scatta restando tappato, quando la pellicola cinematografica si brucia, o quando la videocamera riprende “niente” — come succede in Video Corridor di Bruce Nauman (un lieu mallarmeiano e beckettiano se mai ve n’è uno) prima che uno spettatore ci metta piede.
Da qui occorre partire per una lettura corretta dell’opera di Barbara Probst. In maniera molto evidente, le sue foto forniscono delle rappresentazioni “molteplici”, dato che si tratta sempre non di singole immagini (magari ingrandite a dismisura, come nella retorica tipica di certa fotografia odierna), ma di raggruppamenti di fotografie che sembrano contenere un qualche rimando l’una all’altra, destinato però a rimanere incerto e indecidibile. In secondo luogo, in linea con le parole di Badiou, la “stramba molteplicità” dei soggetti umani non solo viene catalogata in questi ritratti fotografici, ma proprio le foto come tali ostentano ciò che rappresentano (una ragazza in bianco e nero, poi a colori, poi qualcuno che la fotografa di spalle ecc.) come un doppiofondo, dietro cui scorgiamo l’emergere stesso del medium fotografico. La fotografia è ciò che viene esibito come un “laboratorio separato e atemporale”, la marcatura di un insieme vuoto: non siamo davanti a “delle fotografie”, ma al “fotografico” come tale, come struttura trascendentale prima che estetica e mediale.
Il primo punto da stabilire è dunque che Probst impiega la fotografia con la grande sicurezza di sapere cos’è: non un semplice linguaggio, ma un “marcatore” che indica il rapporto tra essere e linguaggio; non un semplice medium tecnologico, ma un luogo trascendentale entro cui i soggetti contemporanei mediano con se stessi; uno strumento adeguato alla modernità (in questo senso nato dalla tecnica moderna) tramite il quale è possibile perimetrare esattamente i contorni del nostro Dasein, del nostro effettivo esserci nel mondo.
Il secondo gesto compiuto da Probst a partire da questo, tuttavia, non è meno importante. Se si analizzano le sue opere fotografiche, sempre complesse e multiformi, si capisce chiaramente che le diverse angolazioni da cui vengono realizzate le immagini colgono non solo gli stessi soggetti, osservati da punti di vista differenti, ma lo fanno nello stesso istante. Contrariamente a quanto siamo abituati — cioè fotografare un soggetto da un unico punto di vista, o vedere fotografati degli oggetti dal punto di vista unico e irripetibile dell’“occhio del fotografo” (retorica dell’immagine fotografica che ha tanto giovato al reportage come abilità di “cogliere l’attimo irripetibile”) — qui lo stesso attimo si sfalda in tante facce istantanee, coestensive nel tempo e contemporanee nello spazio.
Servendosi di un sistema di sincronizzazione radio, Probst attiva contemporaneamente diverse macchine fotografiche puntate verso lo stesso evento o soggetto da varie angolazioni e distanze. L’obiettivo della macchina fotografica coglie una realtà diversa per ogni punto di vista, eppure ogni evento e ogni soggetto si rivela essere sempre lo stesso, nella sua stessa intrinseca molteplicità. La presenza nell’immagine dello stesso apparato fotografico (sotto forma di macchina fotografica che, così, entra a far parte di ciò che la foto rappresenta) è un ulteriore chiarimento di questa scelta radicale di esibire non “delle fotografie” ma “il fotografico”, il processo mediale nella sua essenza. D’altra parte, questa esibizione della distanza del medium da se stesso implica una “dis-identificazione” del soggetto fotografato da se stesso. Il processo ostensivo, per cui il fotografico è al tempo stesso esibito e perciò spostato rispetto a se stesso (come nel metacinema, quando vediamo in campo la macchina da presa), non riguarda solo l’arte fotografica o l’arte in generale: tocca radicalmente l’identità ontologica dei soggetti che, come in una specie di sdoppiamento beckettiano, sono se stessi solo nello sfaldarsi delle loro immagini, e insieme non sono mai dove li vediamo — esprimono l’impossibilità della loro stessa presenza.

Che qui Probst non stia limitandosi a un semplice virtuosismo, ma stia toccando temi come il dominio delle apparenze, il disagio sociale, il problema dell’identità (anche di genere) del soggetto, mi pare suffragato dal fatto che tecniche simili siano riscontrabili anche nel cinema recente.
Un esempio efficace di questa “espressione dell’impossibilità” compare infatti anche in Elephant (2003) di Gus Van Sant, che fa parte, con Gerry (2002) e Last Days (2005) di una trilogia sul disagio mentale e sociale. Elephant è già di per sé tematicamente un film sulla catastrofe di senso, essendo una libera ricostruzione del massacro ad opera di due studenti avvenuto nella Colombine High School, Colorado, il 20 aprile 1999. Come è stato notato da molti critici, la scena chiave del film è quella in cui John, Elias e Michelle, tre ragazzi della scuola dove sta per avvenire il massacro, si incrociano in un corridoio. La soluzione visiva trovata da Van Sant è quella di mostrare la stessa scena tre volte di seguito dai diversi punti di vista di ciascuno dei tre ragazzi; il punto di vista soggettivo, da cui lo stesso evento oggettivo viene visto, ne deforma radicalmente il senso, rendendolo indecidibile. Quello che abbiamo è una sorta di effetto Rashōmon (diverse versioni discrepanti della stessa storia), ma ottenuto in contemporanea, con il risultato che questa inedita visione, oltre ad allungare in modo innaturale la durata della sequenza, la distrugge, perché la rende completamente falsata, innaturale. La cosa interessante, però, è anche che questa scena non raffigura solo un generico incontro tra tre adolescenti catturati nel vortice dell’incomunicabilità, ma è una scena di tre soggetti presi nell’enigma dell’immagine, e segnatamente dell’immagine fotografica — dato che uno, John, sta fotografando un altro, cioè Elias, mentre un terzo, Michelle, vuole sfuggire all’immagine. La scena di Elephant sembra quasi una anticipazione cinematografica del lavoro di Probst: intanto, perché anche nelle sue foto compaiono giovani donne, delle quali a volte è difficile dire se desiderano essere fotografate, oppure se stanno cercando di schivare la minaccia dell’essere immortalate; ma anche perché, così come la scena di Van Sant è ambientata nello spazio astratto del corridoio centrale della Columbine School, allo stesso modo le immagini di Probst hanno luogo in ambienti astratti, dove campo e controcampo (lo skyline di Manhattan e le rocce di Central Park) non collimano, non disegnano un insieme coerente.
Tra questi due esempi vi sono tuttavia alcune differenze non sottovalutabili: in Elephant quello che rende interessante la sequenza è che non si tratta di tre riprese diverse della stessa scena poi montate diversamente, ma di tre scene diverse che il regista fa recitare per tre volte di seguito per simularne la contemporaneità — mentre nel caso di Probst l’impiego dei sistemi radio serve proprio a sincronizzare, cioè a rendere con-temporaneo, ciò che è spazialmente disperso, cioè la distopia fondamentale del soggetto (cosa che invece la tecnica fotografica tradizionale basata sull’istantanea dissimula e nasconde). In questo senso, il fatto che nei controcampi del film non si veda l’apparato di ripresa, testimonia sia che le tre riprese sono state effettivamente realizzate ricostruendo la stessa scena tre volte, ma anche che Van Sant intende restare completamene all’interno del linguaggio cinematografico, evitando coscienziosamente uno slittamento metacinematografico — mentre invece Probst percorre esattamente questo salto nel “fuori campo produttivo” (Pascal Bonitzer), mettendo a nudo il “dispositivo” fotografico (come Jean-Luc Godard ne Il disprezzo o Federico Fellini in Otto e ½). Ma questo salto, lungi dall’essere una concessione al modernismo tipico delle avanguardie (si pensi al fuori campo produttivo ne L’uomo con la macchina da presa, di Dziga Vertov), è interessante proprio perché non è cinematografico, ma fotografico. Il fatto stesso che Probst usi un medium tecnologico così “vecchio” in un modo tanto nuovo, rende il suo esperimento degno di attenzione, e lo trasborda al di là delle questioni interne ai linguaggi, per collocarlo di slancio entro il dibattito più pregnante sul significato e sul ruolo dell’arte contemporanea come tale.