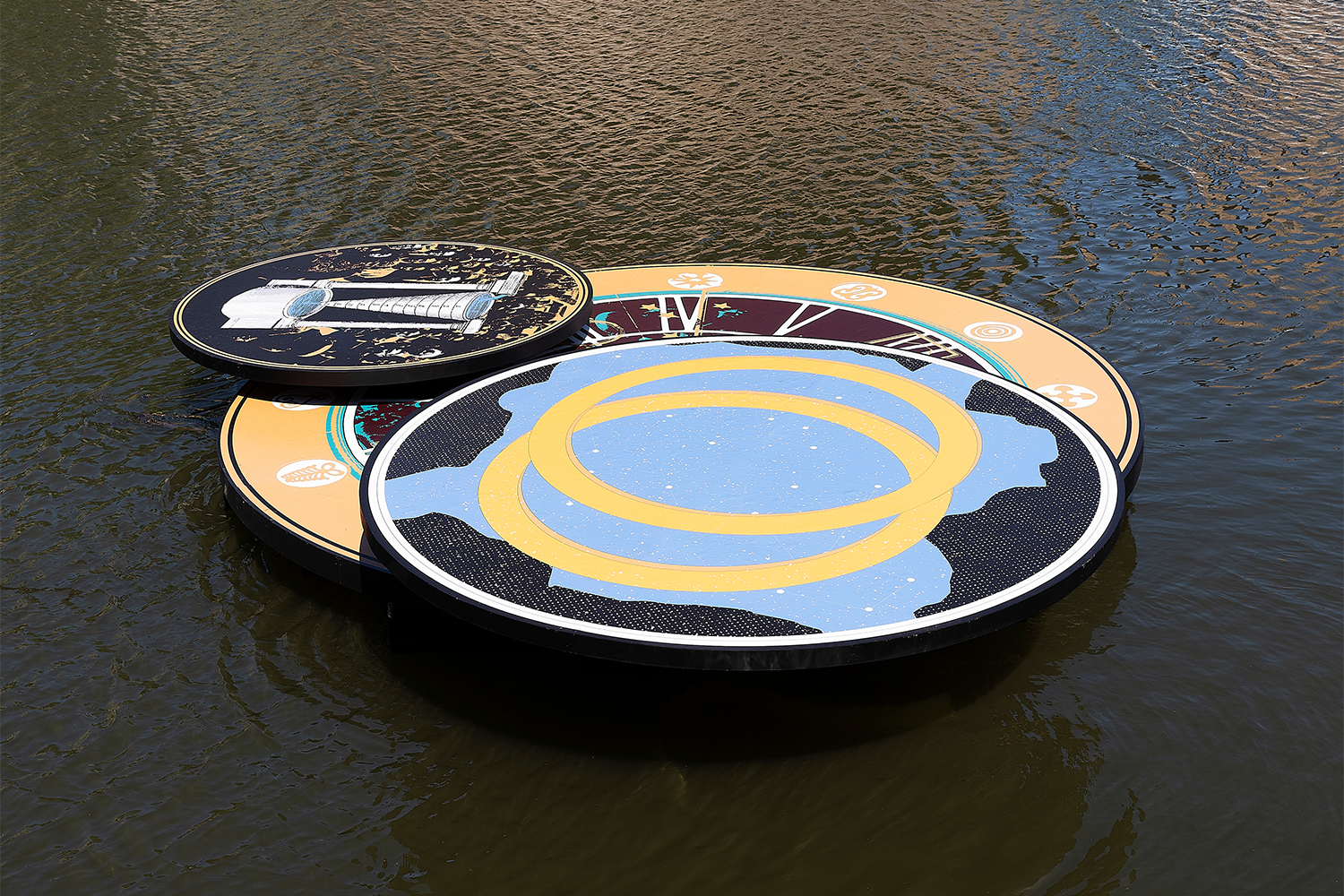La distanza tra personale e collettivo è sottile, e spesso mediata dalla pelle: una membrana di contenimento e separazione che diventa una barriera osmotica quando il confronto con l’altro avviene a livello identitario. In questo caso il corpo diventa un contenitore, e la soggettività vive un continuo e fluido travaso. Almeno così sembra essere per Claire Tabouret, che, nella sua prima antologica veneziana, “I am spacious, singing flesh”, si esercita in un complesso lavoro di immedesimazione spingendo la propria identità a migrare di dipinto in dipinto, albergando alternativamente in ciascuno dei corpi ritratti. Come suggerisce il titolo della mostra infatti – citazione della scrittrice femminista Hélène Cixoux – a Venezia Tabouret diventa “spaziosa” e utilizza la pennellata come una écriture, uno strumento che le permette di indagare il rapporto intrinseco tra corpo ed esperienza.
Immagini trovate o ricercate servono da fonti iconografiche e, riprodotte su tela, immortalano soggetti più o meno conosciuti che acquistano un’identità complessa, trasformata e talvolta inafferrabile. Ben oltre l’ammirazione che la porta a dipingere questi estranei, Tabouret colonizza i loro corpi nel tentativo di defamiliarizzare la propria esperienza. D’accordo con Cixoux, infatti, la citazione diventa un processo di continua rilocazione ed estraniazione del sé e, a tutti i livelli (storico, culturale, narrativo), permette di sentirsi meno isolati, di trovare alleati su tematiche differenti – dal rapporto con la natura a quello con l’altro, dalla maternità alla sessualità.
In questo senso la mostra si comporta come un atlante o un album personale: una collezione di figure in cui si annida l’identità dell’artista prima che anche qualcun altro voglia magicamente proiettarvi la propria. The Spell (2018), ad esempio, ritrae una giovane dal viso malinconico che, con le mani immobilizzate dietro la schiena e la bocca coperta da un velo di rossetto rosso, sembra scagliare un sortilegio o una maledizione. Ispirato alla ginnasta rumena Nadia Comaneci, il volto della donna ha lo stesso sguardo presente in alcuni autoritratti dell’artista, dimostrando che la rappresentazione e/o la comprensione dell’altro coincide con evidenti processi di negoziazione tra esperienze personali. Un approccio dialogico che informa anche il monumentale The Team (2016), in cui Tabouret dipinge la fotografia di una squadra femminile degli anni Trenta unificando metaforicamente l’identità delle giocatrici: il corpo dell’una sembra unito a quello dell’altra, anche grazie a un drappo blu che corre tridimensionale sulla tela rendendola un bassorilievo. L’immedesimazione, poi, assume le fattezze di un’inquietante operazione di camouflage nella serie L’Errante (2013), in cui lo sguardo dell’artista – sempre identico e fisso – riempie il viso di tre diversi volti ispirati ai personaggi della penna di Isabelle Eberhardt, scrittrice di origini russe famosa per la libertà con cui decostruiva le etichette sessuali di inizio Novecento ricorrendo al travestitismo. O ancora diventa una masquerade tra il sessuale e l’archetipico in La Pieuvre (2015), un grande dipinto in cui una figura femminile indossa una tuta sadomaso e, accovacciata alla base di una grande pianta tentacolare, sembra unirsi sessualmente con la natura, raggiungendo un’identità ibrida.
Questa “tribù di testimoni”, per dirla nuovamente con Cixoux, assiste e partecipa al processo di trasformazioni indagate dall’artista e si cita vicendevolmente grazie a un fitto sistema di negoziazioni iconografiche e temporali. La mostra è pertanto disseminata di oggetti devozionali e religiosi che, prelevati dalla storia dell’arte e dall’archeologia italiana, diventano ulteriori alleati per le tematiche della mostra. Due ex-voto in tufo vulcanico raffigurano le Madri di Capua (VI-III secolo a.C.) e hanno lo stesso vigore apotropaico delle immagini create dall’artista dopo la maternità; una serie di dipinti votivi prestati dal Santuario della Madonna dell’Arco (XVI-XVII secolo d.C.), invece, ritrae una barca nel mezzo di una tempesta e sembra alludere a quella sublime relazione con la natura comune a diversi dipinti in mostra. Ogni lavoro, cioè, a prescindere dal suo essere storico o contemporaneo, si relaziona all’altro con simbiotica fluidità. Si tratta della stessa attitudine richiesta allo spettatore che voglia confrontarsi con questa stratificazione identitaria e temporale. Chiunque osservi questo palinsesto è costretto a ricalibrare la propria individualità adattando il proprio corpo allo spazio e alle figure che incontra. Per riconoscere le rime tra i lavori di Tabouret, la “pelle” deve diventare “spaziosa” come quella dell’artista.