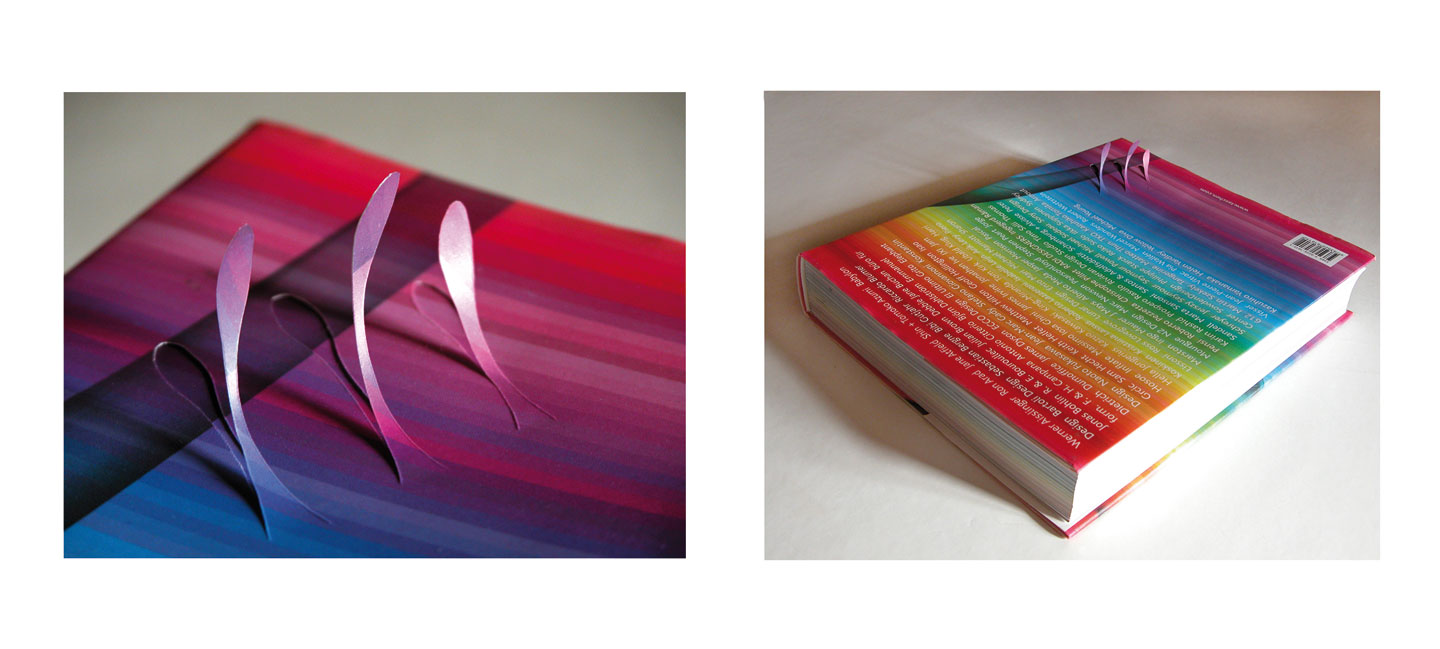Complice la sua natura macroscopica, con un numero sproporzionato di artisti distribuiti in oltre venti spazi espositivi e una ricca gamma di argomenti che va dallo scientifico all’ambientalista al politico, Documenta 13 è secondo alcuni priva di quella visione autoritaria e monocratica che ha caratterizzato molte delle edizioni precedenti. Se la varietà concettuale e formale vanno considerate come un espediente per poter includere tutto quello che si desidera, allora in questo senso non c’è dubbio che Documenta 13 rientra nella categoria. Tuttavia, l’approccio curatoriale di Carolyn Christov-Bakargiev, che come spesso accade si fonda sull’esplorazione e conseguente rappresentazione della contraddizione in quanto idea, ha l’indiscutibile merito di non chiudersi davanti a nessuna possibilità, dimostrando oltretutto un rispetto per gli artisti solitamente assente in rassegne mastodontiche di questo tipo. Le zone grigie sono per antonomasia larghe e scomode, e se occasionalmente ingarbugliano fino al totale smarrimento, d’altro canto lasciano aperta la possibilità di interpretare e discutere, due cose non da poco conto per un evento concepito come momento di riflessione sullo stato dell’arte in un arco temporale che dura un decennio.
Il Fridericianum Museum, tradizionalmente il centro della mostra, si distingue per il suo minimalismo, e serve più che altro come biglietto da visita/manuale di istruzioni per quello che segue. Il pianterreno è incentrato sul concetto di assenza, con il vento di Ryan Gander ad accompagnare gli spettatori per l’edificio ricordando al tempo stesso la precarietà delle cose, lo splendido inno di Ceal Floyer al fallimento e alla caparbietà, e una sentita lettera di Kai Althoff in cui giustifica le motivazioni che lo hanno spinto a rinunciare a partecipare. La serie di sculture in ferro di Julio González, riproposte esattamente nella stessa maniera in cui le aveva esposte Arnold Bode nel 1959, introducono una nota storica, mentre al piano superiore gli arazzi di Hannah Ryggen sul colonialismo africano lanciano i primi segnali di terremoto politico. Le due cose si fondono forse nella sala sovrastante, con il film/indagine di Mario Garcia Torres sull’esatta locazione del One Hotel aperto da Alighiero Boetti a Kabul, che per quanto pedante e infarcito di commenti superflui sul significato della fotografia e dell’arte, schiude per lo meno una finestra sull’universo di un artista che per primo aveva individuato nello stato più occidentale del subcontinente asiatico una meta d’ispirazione. L’immancabile mappa di Boetti stesso è per una volta esposta con più ragione del solito — si tratta infatti di un lavoro pensato e in seguito ritirato da Documenta 5 nel 1972, come testimonia anche la corrispondenza tra l’artista e il curatore Harald Szeemann per i pochi visitatori che sanno leggere l’italiano.
L’Afghanistan è stato al centro del dibattito fin dal primo giorno, con i giornalisti e qualche osservatore interessato scatenati sia alla conferenza stampa d’apertura che al seminario organizzato dai curatori in collaborazione con Dora Garcia alla Ständenhaus. La maggior parte delle critiche, per lo più imperniate su accuse di opportunismo, convenienza o falsità, superate le scintille del momento, sono apparse piuttosto banali. Carolyn Christov-Bakargiev e il suo team dopo tutto hanno passato più di tre anni a lavorare su questo concetto, con diversi viaggi in Afghanistan e lunghe tavole rotonde con esponenti locali e internazionali in un momento storico in cui il dibattito culturale è un’ancora intellettuale nella società afgana, ed è stupido pensare che ogni punto di vista non sia stato pensato e analizzato a fondo prima di intraprendere questa avventura. La sezione di mostra riservata all’Afghanistan nella Elisabeth Krankenhaus ha l’effetto a doppio taglio di rinforzare sia identità che isolamento, ma è un aspetto che può facilmente essere convertito in un vantaggio, soprattutto se visto come metafora per l’attuale situazione del paese. Come prevedibile, la qualità è discontinua, ma ha tre autentici punti di forza nella poetica video proiezione di Lida Abdul, nella serie di quadri basati su vecchie foto di famiglia di Jeanno Gaussi e nei documentari e film d’archivio degli anni Settanta.
Analogamente, le tematiche eco-biologiche che dominano l’Ottoneum penalizzano gli sforzi individuali degli artisti, anche se la denuncia di Maria Thereza Alves sul disastro ambientale del Lago Chalco in Messico e la libreria ottagonale composta da volumi in legno di Mark Dion finiscono con il distinguersi in virtù del loro valore intrinseco. Nella vicina Documenta Halle si assiste invece a un altro tipo di contrasto. Se l’installazione di motori di Thomas Bayrle riporta in primo piano una figura fino a qualche tempo fa ingiustamente relegata a un ruolo comprimario, i disegni di Gustav Metzger, recuperati nella sua soffitta dopo decenni passati a raccogliere polvere, fanno poco per giustificare questo scoop, incuneandosi nella tradizione avviata da Alex Katz e Louise Bourgeois su come la longevità possa divenire un fattore determinante per valutare il lavoro di un artista.
Come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, il vero divertimento consiste più nelle varie tappe che nel risultato finale. Aggirandosi per Kassel si trovano autentiche gemme, come per esempio la dark room popolata dal coro di danzatori di Tino Sehgal, la resurrezione dell’Hugenottenhaus attuata da Theaster Gates con tanto di performance musicali e diversi momenti di vita conviviale, i collage e i quadri di Francis Alÿs (che rimandano brillantemente al suo film in programma a Kabul a settembre), gli splendidi disegni delle montagne afgane di Tacita Dean, le biblioteche distrutte di Matias Faldbakken, l’irruzione architettonica di Renata Lucas in un grande magazzino e i jukebox programmati con canzoni pacifiste di Susan Hiller sparsi per diversi bar e ristoranti della città.
La Hauptbahnhof ha i suoi momenti di punta con l’installazione sonora di Susan Philipsz sui binari (una serie di prove per strumenti ad arco che hanno la stupefacente capacità di nobilitare anche il più desolante degli scenari), la monumentale scultura di relitti industriali di Lara Favaretto, l’eccellente film Muster (Ruster) (2012) di Clemens von Wedemeyer e The Refusal of Time (2012) di William Kentridge, un intervento spaziale talmente teatrale e attraente da far scordare l’eccessivo manierismo che a volte pervade il suo lavoro.
Se molti dei nomi in mostra non risultano familiari come artisti è perché non lo sono. Il risultato di queste “infiltrazioni”, anche se concettualmente e antropologicamente valido, è spesso inutilmente intricato se non addirittura difficile da inquadrare. È un fenomeno che si manifesta in particolare nell’Orangerie, dove l’architettura rivaleggia con l’arte in mostra fino a divorare i contributi di David Link e Konrad Zuse. La proiezione di Jeronimo Voss nel planetario è un’occasione magistralmente sprecata, e solo il film The Most Electrified Town in Finland (2012) di Mika Taanila e la veduta binoculare dell’orologio di Anri Sala nel parco adiacente si salvano in quella che si può generalmente considerare la parte più debole della mostra.
Il Karlsaue Park è invece il luogo dove anche la resistenza fisica degli appassionati a prova di bomba viene messa a dura prova. Il modello chalet adottato (o imposto) alla maggior parte degli artisti finisce con il diventare monotono anche in un contesto così liberatorio. Tra le cose migliori ci sono il film Continuity (2012) di Omer Fast (un resoconto intenso e a tratti inquietante sul processo di aggiustamento di un soldato di ritorno dal fronte), il giardino/abitazione di Garet Moore (in cui l’artista risiede dalla primavera dell’anno scorso), il ripido sentiero sonoro di Natascha Sadr Haghighian, la fragile architettura indoor di Thea Djordjadze, il sanatorio per disagi urbani di Pedro Reyes, la scultura di Giuseppe Penone, finalmente nel suo elemento naturale dopo anni di mostre troppo rifinite, i trofei di caccia di Fiona Hall e soprattutto la tenda di Robin Kahn’s West, un’oasi di istruzione e relax concentrata sui soprusi subiti dalla popolazione del Sahara Occidentale dopo anni di occupazione marocchina e complicità (o cecità) internazionale.
In una rassegna di queste dimensioni, è praticamente impossibile non costruire un percorso narrativo individuale. La cerimonia d’apertura al Kongress Palais è stata innaffiata da bottiglie di succo di mela prodotte da Jimmie Durham. Dopo una lunga camminata, collocato discretamente tra i cespugli all’uscita del parco dall’altra parte della città, spunta un melo trapiantato dall’artista direttamente dall’Arkansas, quasi un promemoria a ricordare che secoli di civilizzazione, conflitti, lotte, rivoluzioni culturali, evoluzioni tecnologiche e cambiamenti geografici sono comunque poca cosa di fronte al più elementare fenomeno naturale. Forse il lavoro più adatto per tirare le conclusioni sul senso di questa edizione di Documenta è il parco sculture creato da Adrian Villar Rojas nel Weinbergterrassen. Se si lascia via libera alla propria curiosità, oltre che a un moderato istinto per infrangere le regole, e si scavalca il primo pezzo che blocca la scala all’entrata, si spalanca un universo di meraviglie che invita all’esplorazione e alla contemplazione. Documenta 13 non è certamente una mostra facile da assimilare, ma garantisce indubbiamente ricche soddisfazioni a chi è disposto ad accettare la sfida.