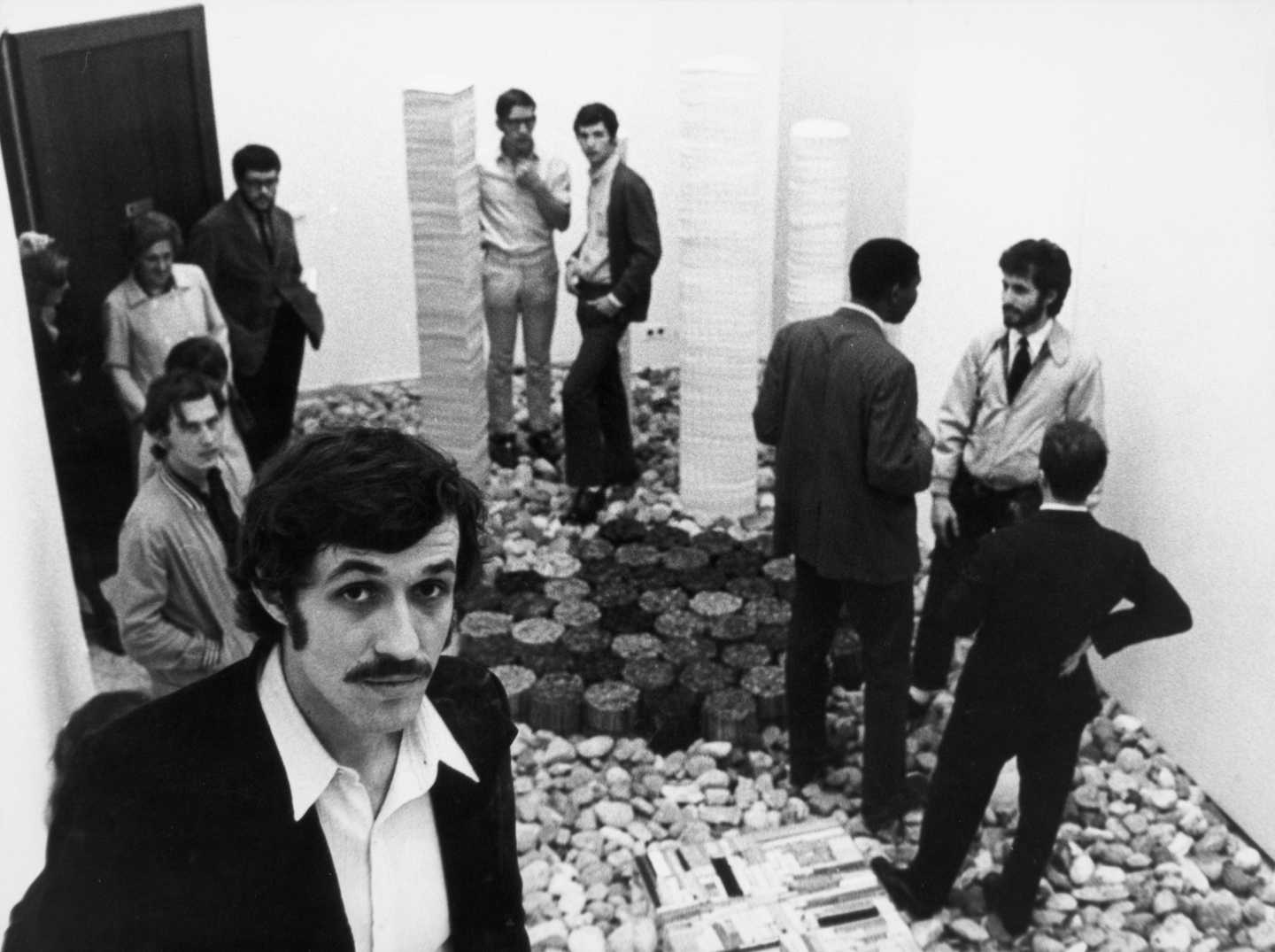Umberta Genta: Nelle sue fotografie, la presenza dei bambini non sembra mai casuale. Com’era lei, da bambino, e che infanzia ha avuto?
Ferdinando Scianna: In effetti ho fotografato moltissimo i bambini, sin da subito, potrei dire. Vi ho persino dedicato un libro, Mondo bambino, che contiene cento immagini scattate in oltre quarant’anni in ventidue paesi dove il mio mestiere mi ha portato. Penso sia difficilissimo fotografare i bambini. Troppo spesso si indulge alla mielosità dei compleanni e delle corse sul bagnasciuga, o se ne ricavano immagini ricattatorie sulla sofferenza, che è tanta, cui sono sottoposti troppo spesso i bambini. Io penso che i bambini non sono diversi da noi e che anche loro ci osservano, offrendoci uno specchio spesso severo che ci rimanda di noi stessi immagini di cui raramente possiamo essere fieri. Da bambino credo di essere stato come tutti i bambini, molto felice tutto sommato, e aperto a costruire la mia immagine del mondo in una realtà magnifica e contraddittoria. Violenta anche, molto spesso.
UG: Come descriverebbe la Bagheria in cui è cresciuto a chi non ci è mai stato? Dalla sua autobiografia, Autoritratto di un fotografo, trapela che il rapporto che ha con il suo paese natale è assai complesso. La Sicilia è l’origine della sua avventura di fotografo, la terra dove ha scattato le prime fotografie e ha prodotto immagini iconiche. Ma è anche la terra da cui “si scappa a gambe levate”… Come racconterebbe questo rapporto con il suo luogo di nascita?
FS: Magnifica e contraddittoria, appunto. Un paesone ancora agricolo, di forte intensità comunitaria. Illuminato dal sole, dal mare, dal profumo della zagara e dei gelsomini, ma anche immerso in forti contraddizioni sociali e umane. Molto condizionato dalla miseria dei molti e dall’esperienza della violenza mafiosa. Un luogo dell’anima. Più che un microcosmo un cosmo, dal quale non si può che fuggire a gambe levate e che quando ne sei fuggito ti lascia dentro una lacerazione inguaribile. E la necessità del racconto.
UG: La sua personalità e il lavoro di fotografo l’hanno portata a vivere a Milano, poi a Parigi, e a viaggiare il mondo. Si è mai sentito senza radici? Qual è il posto che considera la sua “casa”?
FS: In Sicilia, a Bagheria, ho vissuto fino ai ventidue anni. I giochi erano fatti. Dovunque poi abbia vissuto sono sempre rimasto siciliano. Quelle rimangono le mie inestirpabili e irrecuperabili radici. Ma mi sono sentito, e ancora mi ci sento, milanese a Milano. Stendhal se lo è fatto scrivere sulla tomba di essere milanese. Certo, nonostante i dieci anni di fervida permanenza non mi sono sentito parigino a Parigi. Ma nonostante l’origine culturale contadina credo di essere diventato un animale urbano.
UG: Lei racconta di essersi opposto al condizionamento della sua famiglia — che la voleva medico, o ingegnere — per inseguire il suo destino; e sostiene di essere diventato per se stesso il personaggio che aveva immaginato. Ma allora i sogni, le proiezioni che facciamo di noi stessi, i cosiddetti “castelli dorati”, servono a qualcosa?
FS: Io sono convinto che la fuga sia la chiave interpretativa della mia vita, forse anche del mio lavoro. Certo, si fugge sempre verso il “castello dorato” della propria infanzia. Poi, magari uno riesce soltanto a costruire e abitare una casa più o meno sgangherata; ma se dentro non rimane almeno un poco del profumo di quel castello la vita diventerebbe insopportabile.

UG: Le feste religiose in Sicilia e i temi sacri rappresentano una parte sostanziale della sua produzione fotografica, specialmente agli albori della sua carriera. Cosa desidera trasmettere immortalando queste manifestazioni? Nella sua vita personale, che valore dà alla religione?
FS: Non credo che la mia passione per i riti abbia come componente fondamentale la religione. Mi interessano tutti i riti nei quali gli uomini celebrano la propria identità collettiva. Forse perché la Sicilia è un luogo di uomini isole, che hanno molta difficoltà a sentirsi parte di una società. Cittadini di una polis. Forse è l’aspirazione a questa appartenenza che mi fa appassionare alle ritualità umane. Nella mia vita personale, educato a una religiosità formale, quello che mi rimane è, credo, un forte sentimento religioso della vita. Ma di una religione totale, non metafisica: spinoziana, diciamo.
UG: Nei suoi anni parigini lei è diventato un fotogiornalista nel vero senso della parola perché, oltre a fotografare, ha iniziato a scrivere gli articoli che accompagnavano i suoi servizi fotografici. La scrittura, la parola, sembrano essenziali alle immagini che crea. Che tipo di legame hanno con la fotografia questi elementi?
FS: Per me la fotografia è stata uno strumento di racconto, e di memoria. In questo senso determinante è stata l’influenza che su di me ha avuto l’incontro con Leonardo Sciascia. Ho sempre pensato e sempre di più lo penso che la fotografia sia in un certo modo una forma di letteratura. Tanto di più adesso che cerco di mescolare i due linguaggi.
UG: Sfogliando la sua autobiografia mi ha colpito leggere che quando la chiamano “artista”, lei si sente quasi insultato. È vero che “artista” è un termine a volte abusato ed erroneamente utilizzato per descrivere la personalità dell’individuo, più che l’opera che egli crea; ma forse chi lo attribuisce a lei si riferisce essenzialmente ai valori estetici e compositivi che la sua fotografia trasmette, che trascendono dalla semplice documentazione di un fatto. Ma non so se riesco a convincerla… Quindi, cosa c’è di non artistico nelle sue fotografie?
FS: Forse all’origine di questa idiosincrasia, che molti prendono per una posa, c’è proprio la mia idea della fotografia come narrazione, documento, memoria. La divinizzazione “artistica” della fotografia, faccenda recente, peraltro, mi sembra che avvenga all’insegna della rinuncia a questa sua natura storico-culturale. Adesso si fanno, si guardano, si scambiano le fotografie come se si trattasse di immagini e basta. La fotografia viene annessa alla pittura. Mi sembra una falsificazione storica, ma soprattutto un errore culturale. In definitiva, la pittura esisteva da molto tempo prima della fotografia. In che cosa sarebbe consistita allora la sua straordinaria novità culturale? Forse bisogna riferirsi ancora a quel senso religioso della vita. Anche la pittura, del resto, l’arte in genere, sembra essere diventata mera produzione di immagini simboliche ad alto valore di scambio. Al punto da non sapere più che cosa sia l’arte. Allora a che pro essere orgogliosi di essere definiti artisti? Io voglio credere che un briciolo di quel senso religioso senza il quale secondo me non c’è arte si fosse rifugiato da oltre un secolo nella felicemente negletta fotografia. I valori estetici e compositivi, lei dice? E ci mancherebbe altro. Una vecchietta formidabile raccontatrice di storie popolari una volta disse a Antonino Uccello, il grande antropologo, che andava a registrarne i racconti che: Lu cuntu è niente, tutto è come lo porti. A dire il vero non sono d’accordo nemmeno con la contrapposizione della vecchietta. La mia formula è: Lu cuntu è come lo porti. Senza cuntu, insomma, non c’è niente. Se le cose stanno così, va bene, mi ha convinto.

UG: Ha mai provato disagio di fronte a uno dei suoi scatti?
FS: Guardi, io ho scattato sicuramente molto più che un milione di fotografie. Oltre il novantanove per cento sono delle porcherie. Frequentare il lavoro che hai fatto significa affrontare ogni giorno il disagio dello spettacolo della propria mediocrità.
UG: Tra le campagne pubblicitarie che ha scattato negli anni Ottanta, quelle di Dolce e Gabbana segnano indubbiamente una svolta nella storia della fotografia di moda. Lavorerebbe ancora con un disegnatore di moda?
FS: Secondo me il giudizio è fortemente esagerato. Quel lavoro, che considero un buon lavoro, come tutti è il frutto del caso e della necessità. Una mistura di autenticità autobiografica, di misterioso incontro felice con una modella, la digestione di forme culturali, soprattutto cinematografiche e letterarie.
UG: Lei è entrato a Magnum nel 1982; un processo che ha richiesto impegno, tempo, dedizione. Ritiene che Magnum rappresenti un obbiettivo fondamentale per un fotogiornalista esordiente? Oggi chi fa il suo mestiere necessita di una struttura alle spalle?
FS: Magnum è stato un mito per almeno quattro generazioni di fotografi, per essere precisi di fotogiornalisti. Lo è stato anche per me, e anche per me è stata importante. Mi dicono che rimane un mito ancora per molti. Spero che abbiano ragione, per loro e per Magnum.
UG: Cosa le ha regalato la fotografia?
FS: Una vita meravigliosa.
UG: Lasciando da parte il suo talento innato, fino a che punto ha contato nel suo percorso di fotografo il lottare per costruirsi comunque “un mestiere”?
FS: Il talento, non parliamo del rarissimo genio, è, a parere mio, frutto misterioso del caso. È merito tuo se nasci con il corpo di Marilyn Monroe, la voce di Fischer-Dieskau, invece che racchia o afono? Dipende da che cosa poi riesci a farne di quel talento. E quello passa inevitabilmente per il mestiere e per il suo ostinato apprendimento.

UG: Alla Fondazione Capri, il Festival della Fotografia quest’anno ha esposto una serie di suoi scatti ambientati sull’isola. Rispetto alla Sicilia, cosa le ha dato quest’isola?
FS: Entrambe sono isole, certo. Ma quanto diverse. Non fosse che per la dimensione, il ruolo storico. Le accomuna la bellezza, certo, e quella dimensione terra mare così importante per la mia sensibilità. Capri è stata per me un incontro. La Sicilia un destino.
UG: Ha un “rimprovero” da fare ai fotografi di giovane generazione?
FS: Sempre lo stesso, di scambiare la fotografia per lo scopo del farne e non per il mezzo per raccontare le cose del mondo, quelle che ami, che odi, te stesso.
UG: A prescindere dal parere critico, qual è il marchio di originalità che lei attribuisce alle sue opere?
FS: Non ho la più pallida idea su questa presunta originalità delle mie fotografie. Se la conoscessi la praticherei sempre. Ma non la conosco. L’originalità è sempre negli occhi di chi guarda.