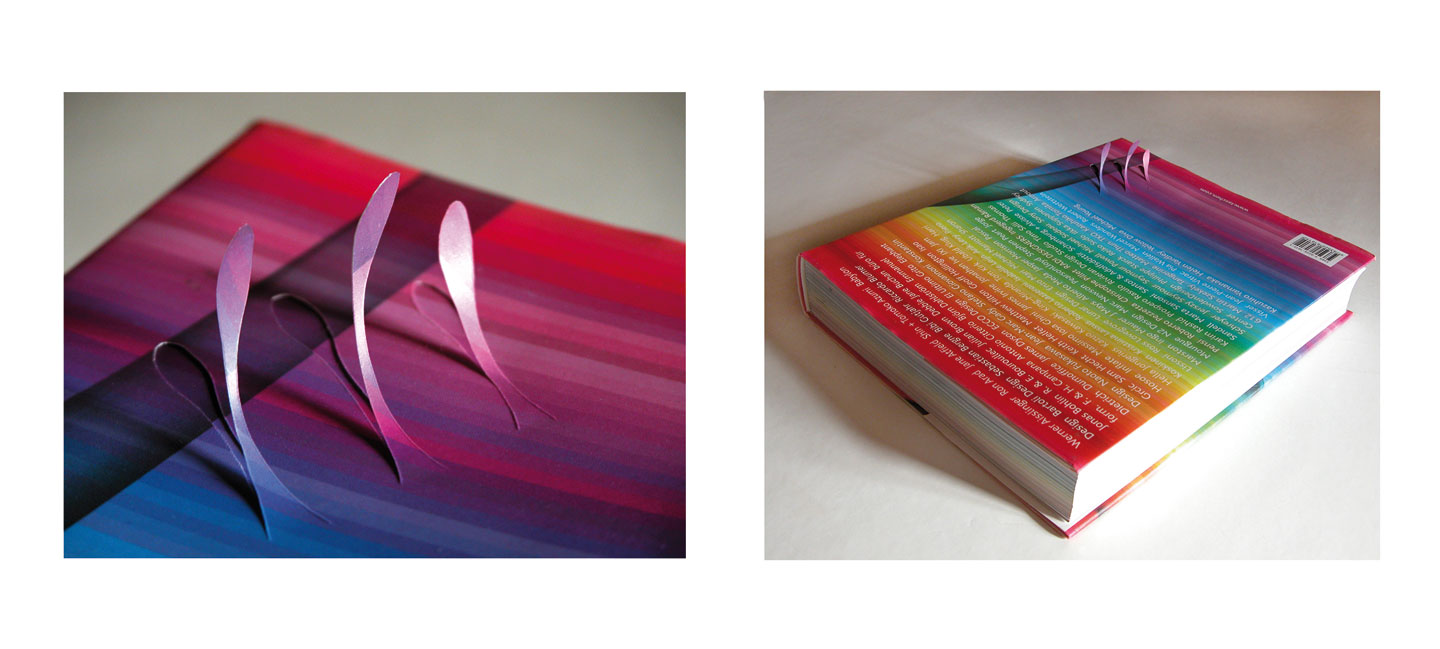Che rapporto c’è fra gli oggetti e le storie che rappresentano? Diciamo che un oggetto racconta una storia, ma è una metonimia o una menzogna: siamo noi a raccontarla, cercando testimoni in cose mute che parlano al nostro posto perché le facciamo parlare noi. Alcuni degli artisti emergenti più interessanti in Italia si stanno occupando in diversi modi della questione, indagando il rapporto fra una narrazione ampia e ramificata e degli oggetti che necessariamente non possono che alludere o simboleggiare una piccola parte di essa. È il caso, per esempio, di Alek O. per quanto riguarda la biografia — un fatto intimo, personale — o in senso opposto di Francesco Arena per la storia, che è pubblica e condivisa. In una dimensione intermedia di questa scala, sulla misura del gruppo o della piccola collettività, si colloca la ricerca di Giulio Delvè, artista nato a Napoli nel 1984 e residente da qualche anno a Berlino.La scultura di Giulio Delvè prende spesso le mosse da oggetti trovati, e in seguito ricreati, o smontati e riallestiti. Questi oggetti provengono da cornici di gruppo molto specifiche, sono legati a rituali identificanti o a narrazioni condivise. Queste narrazioni sono, in ultima analisi, l’oggetto della ricerca di Delvé: che tenta da una parte di raccoglierle e ri-raccontarle, come Calvino con le Fiabe italiane; dall’altra di mettere in luce ciò che rivelano della comunità che le ha inventate.

And if a double-decker bus crashes into us (2008-2009), per esempio, si concentra sulla “tradizione” delle coppie di innamorati di chiudere un lucchetto con il proprio nome in certi luoghi pubblici — tradizione preesistente ma ascesa a un’incredibile popolarità grazie a una serie di romanzi per adolescenti. Un video e alcune fotografie documentano l’atto faticosamente iconoclasta di spezzare le catene che reggevano centinaia di quei lucchetti, su un belvedere napoletano; il materiale così ottenuto viene presentato come un monticello semiregolare di ferraglia. Ma è una ferraglia che parla: singolarmente, delle coppie che l’hanno pian piano accresciuta, suggellando l’unicità della propria unione nel conformismo ripetitivo di un rito di gruppo; collettivamente, di una comunità che ha mutuato un rito tanto simbolico da un’opera di fiction scadente.
In modo simile, Speakeasy (2011) fa parte di una serie di sculture che ricreano delle strutture idrauliche improvvisate per ubriacarsi a una festa il più in fretta possibile. A metà strada fra la consuetudine valdostana della grolla, il bicchiere collettivo, e il filone goliardico della sfida alcolica, questi apparecchi sono composti di svariate bottiglie che, mediante un sistema di tubi, imbuti e snodi, convergono nella bocca di uno o più bevitori, che sono costretti a ingoiare per mancanza di modi di fermare il flusso. Anche in questo caso, il modo d’uso è implicito nell’oggetto, la cui funzione è chiara a chiunque lo veda anche se non ne ha mai fatto uso. Il racconto di quel genere di festa è già tutto lì — il tipo di persone che vi partecipa, ciò che vi cercano, tutta una serie di accadimenti più o meno minuti che si possono figurare all’istante, a prima vista: chi si inginocchia per bere meglio, chi si scosta per prendere fiato inzuppandosi i capelli di una brodaglia di succhi e rum, e intorno i cori, gli sfottò e gli incoraggiamenti di chi guarda la sfida.

In questo senso, le sculture di Delvè narrano una dimensione di gruppo: vuoi perché il loro uso è necessariamente dipendente da un’azione collettiva che allo spettatore raccontano, come in quest’ultimo caso; vuoi perché il loro valore simbolico è tale unicamente in quanto una comunità specifica vi si riconosce, come nel caso dei lucchetti. Una comunità, certo, si definisce tanto per ciò che ne accomuna i membri quanto per ciò che esclude gli estranei. Lookout (2011) è una serie di paletti coloratissimi e improvvisati, che gli abitanti di alcune zone di Napoli hanno piantato abusivamente, in secchielli di cemento nella strada immediatamente di fronte ai propri appartamenti, per reclamarne la superficie. Gli oggetti alla vista sono incongrui, chiaramente segnali di autorità eppure troppo raffazzonati e personali perché tale autorità sia quella impersonale dello Stato; ma tale incongruità, pur essendo il segnale di una “storia” alle spalle, non permette a chi non conosca questa usanza di comprendere gli oggetti. Rendono evidente di avere molto da dire: ma sono muti.
Questi tre lavori costituiscono una sorta di progressione o di mappatura dei modi in cui un oggetto può rapportarsi a una storia. I lucchetti si riferiscono a un codice noto (ma che una generazione fa, per esempio, non lo sarebbe stato), e quindi rievocano la propria storia. Il congegno per bere rende esplicita la propria funzione benché questa fosse prima ignota, e in questo senso crea una storia. I paletti di Lookout si limitano invece ad alludere a una narrazione che però necessita di altro (le parole dell’artista, un comunicato) per essere compresa. Scegliendo di esporli così, fra l’altro, Delvè trasferisce sul piano semiologico l’effetto di esclusione e di recinto che i paletti esercitavano prima di essere trasformati in opera d’arte dal dispositivo dell’objet trouvé.

Tuttavia la nozione di objet trouvé confonde o intorbida le acque, perché più che trovati questi oggetti sono scelti: per come rappresentano la propria storia, o meglio, per come si rapportano, in quanto parti, a un tutto che implicano e che li contiene. Non sono neppure sempre trovati, tecnicamente: Azione meccanica (di una roccia effusiva su un solido amorfo), 2012, è una scultura composta da un sampietrino avvolto dai frammenti di una vetrina nell’istante in cui viene infranta. L’oggetto non è mai esistito in quanto tale, è una sorta di fermo-immagine fisico: eppure, come simbolo, riassume in sé una miriade di immagini e significati: la manifestazione di strada nella città italiana, il rapporto teso con la polizia, i “black block”, chiunque siano, il momento impercettibile in cui la tensione tracima nello scontro, i fumogeni, le auto in fiamme. Conosciamo quelle immagini, e moltissime altre, e frasi e date e suoni e persino odori: e tutte si riassumono in un oggetto muto, che non ha accenni a fatti precisi, ed è il fermo-immagine dell’azione meccanica di una roccia effusiva su un solido amorfo.
Scrivendo della pratica di Giulio Delvè, l’artista Luca Francesconi l’ha accostata all’antropologia malinowskiana, che vede il ricercatore come agente infiltrato, che penetra in una tribù facendosene accettare per studiarla dall’interno. L’accostamento è calzante nella misura in cui, in effetti, Delvè si concentra sulle narrazioni di gruppo, sulle simbologie condivise, sui riti collettivi — proprio ciò che fa l’antropologo embedded teorizzato da Malinowski. Ma — e qui l’analogia smette di reggere — Delvè non è un antropologo: non è interessato essenzialmente alla completezza e fedeltà del racconto, perché una parte fondamentale della forza della sua opera è nel rapporto, di allusione, di metafora, di simbolo, fra l’oggetto e la sua storia. La procedura dell’antropologo è analitica, quella di Delvè sintetica: e consiste nella scelta della parte che potrà rappresentare il tutto, nella determinazione del punto in cui le linee di significato si incrociano, nel reperimento, in un’anatomia narrativa sempre diversa, della posizione del cuore.
Che rapporto c’è fra gli oggetti e le storie che rappresentano? Un rapporto incomprensibile e parziale, il più delle volte. Altre volte invece no.