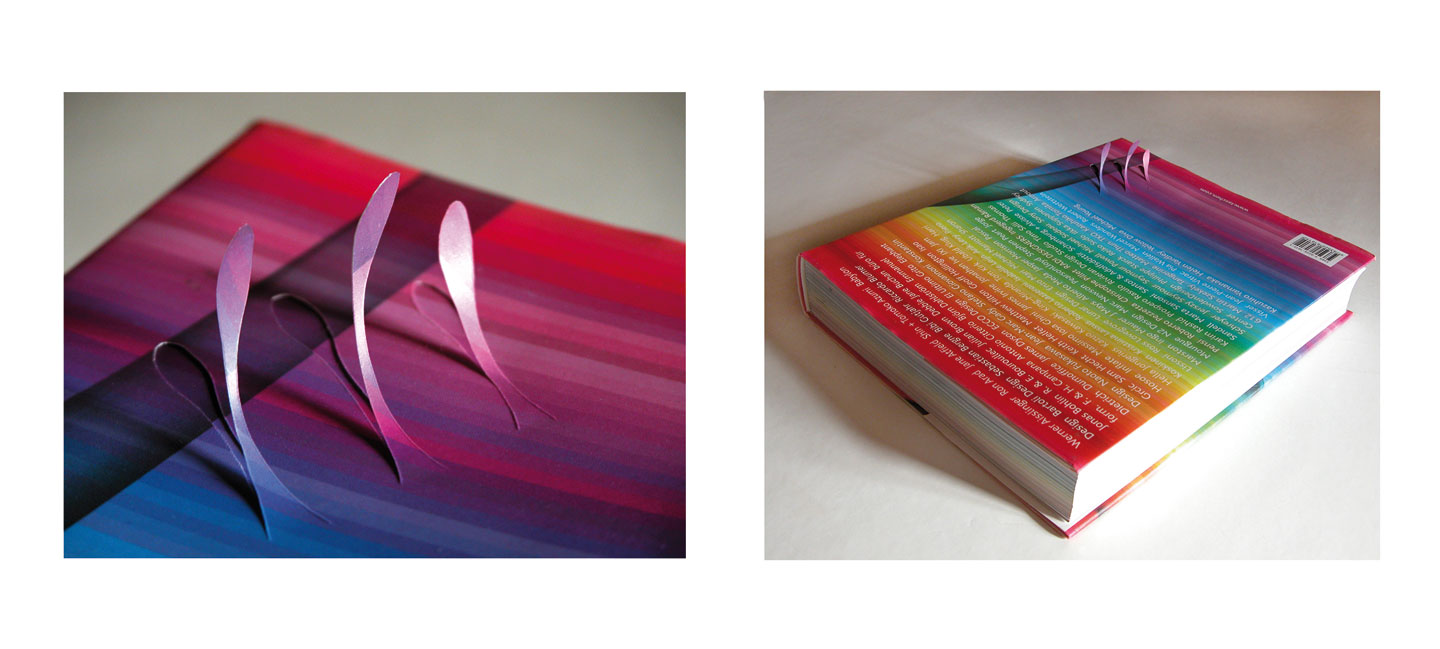Vi invio una mia impressione sulla mostra, e qualche riflessione in rapporto ad altre biennali e grandi mostre dei nostri tempi. Documenta 13 vuole essere Documenta, Biennale di Venezia, di Istanbul, di Berlino e Skulptur Projekte di Münster tutt’insieme. Ciò che è più interessante è proprio la sua espansione elefantiaca. Si estende dal Fridericianum all’Ottoneum, dalla Documenta Halle alla Neue Galerie, dai bunker alla stazione, e quando credi di essere ormai arrivato in fondo scopri che invade la città tra Konigstrasse e Friedrichstrasse, dai cinema agli alberghi, ai negozi, agli appartamenti. Se, al terzo giorno, davvero stanco, vai a cercare un po’ di riposo all’Orangerie e al parco, dove eri solito sedere al ristorante osservando da lontano qualche rara installazione sul prato, resterai deluso, non puoi fermarti. Ti accorgi che questa Documenta nel parco reinventa i padiglioni, come a Venezia, e poi le sculture nell’open space, come a Münster, e ti impone di andare fino in fondo in una sorta di caccia al tesoro (sono due chilometri ma che diventano quattro zigzagando da un lato all’altro). Davvero se non hai le gambe buone e allenate non ce la puoi fare. Senza poi parlare di Kabul e Alessandria e il Cairo e Banff, città in cui Documenta avrà delle appendici. Insomma, è una mostra megalomaniaca. Preciso che megalomaniaco è usato qui in modo descrittivo, senza intenti negativi. L’elefantiasi continua nelle varie sedi, dove molti artisti non si accontentano di presentare un’opera — che so, un’installazione, un video — ma realizzano mostre intere. Theaster Gates occupa letteralmente tre o quattro piani di un edificio con gruppi musicali che ci vivranno dentro per tutto il tempo. Lara Favaretto ha scaricato alla Hauptbahnof un intero parco di rottami.
Kader Attia mette in scena decine di scaffalature con sculture, oggetti, proiezioni e fotografie di uomini mutilati al volto. Lungo tutto il percorso della Documenta Halle, Gustav Metzger espone — anzi nasconde sotto bacheche ricoperte di teli — decine e decine di disegni della sua prima fase artistica. Yan Lei assiepa centinaia di dipinti che si inerpicano sui muri e si affastellano in strutture per la conservazione da magazzino. Paul Chan copre le pareti con altrettanti dipinti, ma di piccole dimensioni, realizzati con vecchie copertine di libri. E l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Sul piano artistico non voglio entrare, ci sono cose ottime, e altre meno interessanti. Ma questo vale per tutte le mostre. Ora, a freddo, mi pare persino migliore di tante altre grandi esposizioni. Ma ciò che ne fa una mostra speciale è la dimensione, che dice molto dell’aspirazione della curatrice. Mi piace mettere a confronto Documenta 13 e la 7ma Biennale di Berlino, perché su due fronti diversi cercano di rispondere alla stessa domanda: serve alla società un’arte confinata nei musei, nelle gallerie e nelle fiere? Serve all’umanità un’arte che funziona principalmente secondo i meccanismi del mercato e non coinvolge la vita di tutte le persone? La risposta, da parte di entrambi i curatori, Carolyn Christov-Bakargiev e Artur Żmijewski, è no, non serve, non è sufficiente. Ma la strada per risolvere il problema è opposta. Carolyn è l’ultima utopista di un mondo artisticizzato, paladina della fiducia, o forse solo della speranza — la stessa che fu dei futuristi e delle avanguardie — in un’arte che invada il mondo, che si estenda negli oggetti, nelle strade, nelle case, e persino nei comportamenti delle persone. È una posizione ambiziosa, in qualche modo ammirevole. Solo che l’arte di cui la curatrice parla è quella che conosciamo, che vediamo nelle fiere e nei musei, e sappiamo essere valida perlopiù per un’élite. La reazione del pubblico, per buona parte delle opere esposte, è l’incomprensione. Frutto di progetti artistici individuali, fatica a coinvolgere un fascia più larga di persone. Dall’altra parte, Artur, scettico polacco abituato a provocazioni e a domande critiche, vede ormai l’arte che conosciamo come un involucro svuotato di contenuto, una crisalide senza la farfalla. E dunque va a cercare possibili risposte altrove, fuori dai musei e dalle fiere: tra i palestinesi che hanno prodotto la grande Chiave del ritorno, tra i cattolicili radicali sostenitori del Cristo di Swiebodzin, tra gli Indignados e gli Occupy Wall Street. Cerca un’arte, o comunque una manifestazione di energia, che sia già nel mondo, che emerga da bisogni e urgenze profonde di gruppi e comunità. Probabilmente la soluzione finale non sta in nessuna delle due proposte, ma ciò che è importante è che si cominci a porre il problema in modo più largo, che si senta il bisogno di ripensare alla funzione dell’arte per l’umanità. Ahimé, Giancarlo, temo che dobbiamo metterci in cammino.