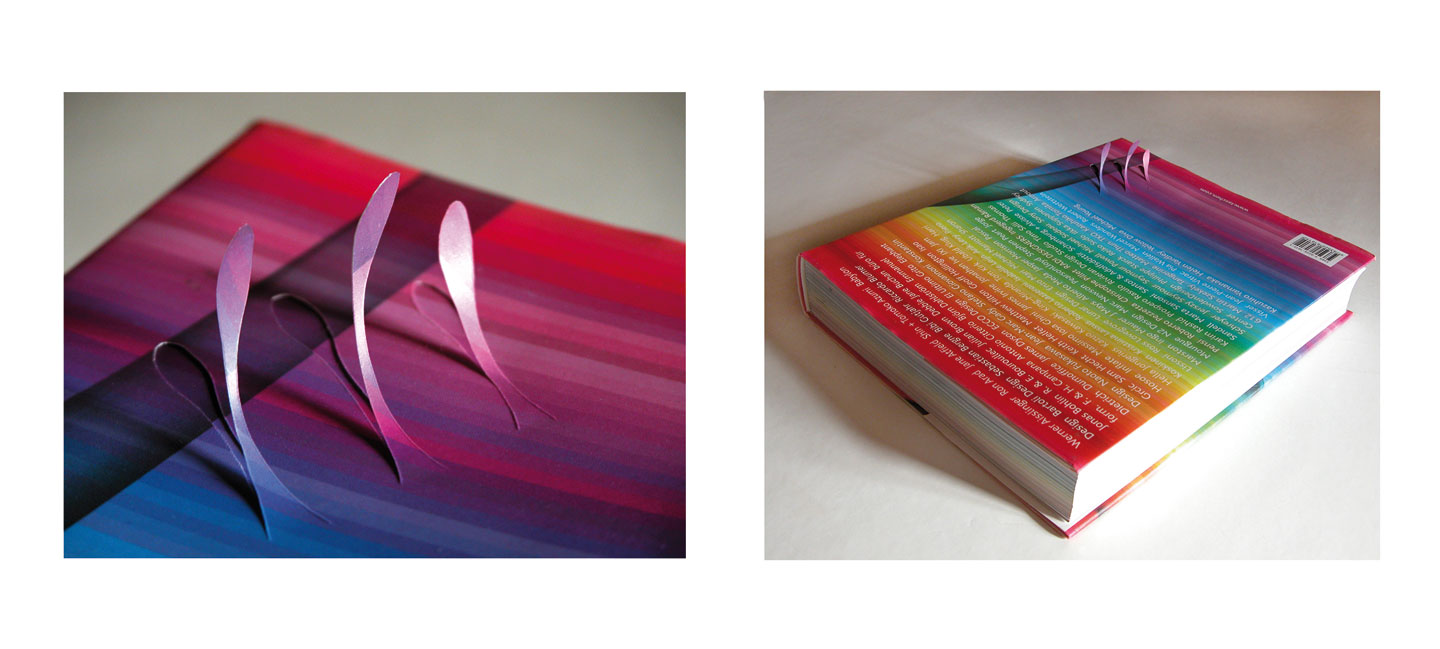Vincitrice del Premio Italia e del Premio Michelangelo nel 2010, presente contemporaneamente a Manifesta e a Documenta, Rossella Biscotti è la giovane artista italiana più lanciata internazionalmente in questo momento. Vale la pena osservare come sta affrontando questa fase di interesse per il suo lavoro, confrontando alcune opere recenti. Ciò che ha sempre caratterizzato il percorso di Rossella Biscotti è lo spostamento minimo dalla realtà, la volontà di aderire il più possibile a fatti oggettivi, registrabili con tecnologie impersonali. È un po’ come se l’artista facesse dei prelievi, sondasse il terreno, rilevasse le tracce vicine all’oggetto di indagine per averne la forma più aderente al reale. Quando addirittura non trasporta in mostra l’oggetto stesso, tanto da far sorgere il dubbio su quale sia — o se addirittura ci sia — lo scarto artistico. Le Teste in Oggetto, per esempio, del 2009, era un purissimo ready made, la semplice traslazione di cinque grandi busti del Duce e del Re d’Italia dai sotterranei dell’EUR alla sede della Nomas Foundation a Roma. La presentazione finale, con le grandi teste appoggiate su pallet a dichiarare una sorta di demonumentalizzazione, non diceva molto della loro storia e del percorso svolto per produrre il lavoro. Una performance finale, una lecture dell’artista, raccontava l’origine delle teste, realizzate nel 1942 per essere poste all’ingresso dell’Esposizione Universale — poi cancellata per la guerra — e dunque mai esposte prima, e i rapporti tra l’artista e gli uffici dell’EUR per ottenere il prestito delle sculture, evocando un alone molto complesso di sensi. I lavori di Rossella Biscotti sono generalmente così: una lunga indagine d’archivio, corrispondenze e trattative per ottenere permessi, documenti, oggetti, e una presentazione finale che riduce il lungo percorso all’essenziale, al minimo, spesso evocando anche formalmente l’arte minimale o comunque le geometrie moderniste. In altri termini si potrebbe parlare di editing: la raccolta di informazioni, la loro selezione e postproduzione. Del resto il riferimento alla metodologia cinematografica è un aspetto costante del lavoro dell’artista, che ha il tempo alla sua base: il tempo della storia, dell’archivio di fatti e vicende da cui parte, e il tempo finale del lavoro editato, che il più delle volte conserva una parte performativa o comunque processuale. Ma spesso il punto di partenza è anche un luogo fisico, che può essere un’architettura storica, una fabbrica Olivetti o il muro di cinta del lager di Bolzano. Si instaura così una relazione, un dialogo, tra lo spazio oggetto della ricerca e quello finale, la sala espositiva dove il lavoro si materializza. Tra questi due tempi e questi due spazi, si colloca il lavoro artistico di Rossella Biscotti, un altro tempo, vissuto direttamente, il tempo dell’esperienza personale, attraverso cui l’artista produce l’opera partecipando, talvolta manualmente, alla realizzazione degli oggetti o delle attività. Un tempo esperienziale che si perde, in gran parte si cancella, nella post-produzione finale, ma la cui esistenza non manifesta crea un alone di senso, di valore: un’esperienza che sta al pubblico riattivare.

È il caso del lavoro di Documenta, ultimo in ordine di esposizione, ma primo di quelli a cui ci riferiamo essendo l’opera realizzata inizialmente per il Maxxi nel 2010: Il Processo. Come è noto l’artista ha cercato di riportare alla luce alcuni aspetti del processo del 7 aprile, che vide coinvolti i leader di Autonomia Operaia, un’ottantina di persone da Toni Negri a Paolo Pozzi. Si trattò di una delle più grandi azioni giudiziarie basata solo sul sospetto e sulla congettura in un paese democratico, una reazione dello stato nei confronti del laboratorio sovversivo di cui l’Italia era stata teatro negli anni Settanta. Una zona rimossa della storia italiana, che in qualche modo l’artista vuole preservare, anche perché l’aula bunker del Foro Italico, che ospitò le varie sedute del processo segnando quell’epoca nell’immaginario collettivo, sarebbe stata presto smantellata. A Roma, il concetto dell’esposizione era la creazione di un rapporto tra i due luoghi, trasferendo l’aula nel museo e viceversa. Nel Maxxi venivano esposti alcuni calchi in cemento armato di porzioni della sala, mentre l’aula diveniva teatro di un’azione: una visita da parte di alcuni ex imputati e altre persone implicate nel processo, insieme al pubblico. Una visita senz’altro densa di energia per chi aveva passato molti dei suoi giorni in quel luogo. A Kassel, nel primo piano della Neue Galerie, l’artista mette in mostra ancora alcuni calchi: le gabbie degli imputati, le scale d’accesso, il pavimento sotto la poltrona del giudice. Ma al centro dell’operazione c’è un traduttore simultaneo con cuffia e microfono che traduce in inglese o in tedesco parte del dibattimento registrato da Radio Radicale, già presente fin dalla prima esposizione, ma ora editato dall’artista in una sequenza di sei ore. Le porzioni reali dell’aula — i calchi — e le parole degli imputati tradotte, traslate, sono attivate dalla presenza del pubblico dell’esposizione, che le esperisce, riportando la storia al presente, non più fatto astratto, ma forma viva, un po’ come la memoria individuale in qualche modo riconduce sempre a un presente personale i fatti del passato.

Se da Kassel ci spostiamo in Olanda, a Middelburg, nel centro d’arte De Vleeshal diretto da Lorenzo Benedetti, troviamo un altro lavoro di Rossella Biscotti: L’Isola. Anche questo ha a che fare con una prigione, quella di Santo Stefano, un’isola a circa due chilometri dalla costa di Ventotene, dove nel 1793 venne costruito il primo carcere per la detenzione a vita, di forma semicircolare, su immagine del Teatro San Carlo di Napoli, realizzato in modo da tenere sempre sotto osservazione il detenuto secondo il modello del panopticon. Struttura regolare, con tre piani di 33 celle per un totale di 99, ognuna di 4,5 x 4,2 metri, ha visto tra i suoi detenuti anche molte celebri figure politiche, da Luigi Settembrini a Gaetano Bresci, a Sandro Pertini. In questo caso l’artista è entrata nell’edificio, la cui funzione di carcere è terminata negli anni Sessanta, e con dei larghi fogli di piombo ha raccolto le forme del pavimento di alcuni spazi: le piccole celle, alcuni passaggi, corridoi. Il piombo, con l’uso del martello, ha impresso su di sé le tracce del luogo, come una sorta di frottage che raccoglie i segni di ogni piega della pietra. La mostra presenta una serie di sagome geometriche disposte a terra nella sala dell’ex mercato, sede del centro d’arte, che il pubblico può esperire, attraversare. Si forma una mappa fittizia che echeggia, riporta al presente la prigione lontana. È un po’ come tradurre nello spazio del museo, rovesciandolo, il senso di prigionia del carcere dell’isola: lì il condannato aveva solo pochi metri quadri da calpestare, qui, nella mostra, il pubblico può girare intorno alla dimensione riprodotta della cella, muovendosi tra gli spazi lasciati liberi dalle forme disposte sul pavimento. Un video, su un piccolo schermo, ancora una volta accenna al lungo processo di realizzazione del lavoro, dall’arrivo nell’isola con i materiali per produrre i calchi, all’incontro di gruppi di persone presso un cimitero di morti senza nome, una sorta di pellegrinaggio che manifesta quanto l’esperienza dell’artista sia ancora la parte più ampia dell’opera.
Scendendo verso Genk, in Limburg, provincia a nord del Belgio, nel palazzo del Waterschei, il grande edificio minerario che ospita Manifesta 9, troviamo l’ultima delle opere realizzate da Rossella Biscotti in ordine di tempo. Si tratta, a dire il vero, di due lavori, ma che rappresentano l’uno il contraltare dell’altro. Il primo, A Conductor, è la semplice produzione di fili di rame utilizzati per illuminare la mostra. Il secondo, Title One: the Tasks of the Community, è composto da una serie di forme geometriche regolari in piombo, per lo più lastre, di varie dimensioni, collocate sul pavimento. Il primo lavoro è felicissimo nella sua semplicità: la smaterializzazione completa dell’arte, la sua definizione come energia pura, raggiungendo di fatto l’aspirazione di Yves Klein. Il secondo fa invece i conti con l’eterna difficoltà di traduzione di un processo in un’immagine formale, e pare collocarsi, a prima vista, a metà tra Carl Andre e l’Arte Povera. Del resto il piombo è una materia inerte, pesante, opaca, che proprio per questo fornisce riparo e protezione, ma anche consiste, oppone resistenza, attrito.

L’origine dei due lavori, come sempre, è molto complessa, e si basa su una ricerca documentaria. I primi passi per la creazione dell’Europa, almeno agli albori, nel dopoguerra, sono stati i trattati per l’energia, a partire da quello celebre della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio del 1951. Tra questi ce n’è anche uno del 1957 sull’energia nucleare, poi non entrato tra i regolamenti europei. Il caso vuole che la Lituania, così come altri paesi dell’ex blocco sovietico, nel momento in cui ha fatto ingresso nell’Unione Europea, abbia dovuto avviare lo smantellamento di centrali nucleari obsolete. L’artista ha partecipato a due aste successive, dove ha acquistato delle quantità di rame e di piombo provenienti dalla centrale decomissariata di Ignalina. Sono il rame e il piombo con cui ha prodotto i due lavori. Il meccanismo di produzione può sembrare sterile, freddo, tanto che le forme e i numeri delle piastrelle del secondo lavoro sono determinate dai capitoli del Trattato europeo sull’energia nucleare, così come il titolo è preso direttamente dall’articolo 1 del trattato stesso. Il pubblico, però, non percepisce la logica deduttiva alla base dell’opera, né la relazione con il lucore del paesaggio di Vilnius che quel metallo, con una parte di argento, attivava quando è stato esposto la prima volta nel Centro per l’Arte Contemporanea della capitale lituana. Ma questa parte c’è, esiste, e piano piano si impone pur nella sua inintellegibilità.
La volontà di far discendere da un’ipotesi astratta l’intero lavoro riduce la dimensione personale. Ma è proprio in questo diaframma sottile tra porzione di realtà, documento, traduzione, in questo campo apparentemente arido e inespressivo, che si inserisce, si fa strada ed emerge l’ambiguità artistica. È in questo spazio che si colloca il lungo lavoro di editing compiuto dall’artista: le scelte, i tagli, gli accostamenti. Un lavoro che non si vede, ma che lascia traspirare la sua presenza, suggerendo al tempo stesso la dimensione vasta della ricerca e la qualità dei suoi risultati. Emergono inoltre le scelte tematiche, le connessioni tra le parti, le analogie, la persistenza dei temi, che ricorrono da opera a opera: la prigione, la centrale atomica, l’investigazione (che è sempre un po’ un’indagine poliziesca), l’interrogatorio, la deposizione (che non è poi troppo lontana dall’intervista). In questi temi, e nell’apparente semplicità del loro trattamento, sta la dimensione artistica di Rossella Biscotti, che dice molto anche dei nostri tempi: tempi che si svolgono per lo più in superficie, all’apparenza unicamente avvitati sul presente, ma il cui senso, a ben guardare, è dato da una stratificazione di storie. Per questo ha senso che qualcuno a volte cerchi di districarle, ne porti alcune alla luce, e identificandole ci dica qualcosa sul nostro tempo e, chissà, forse anche sul domani.