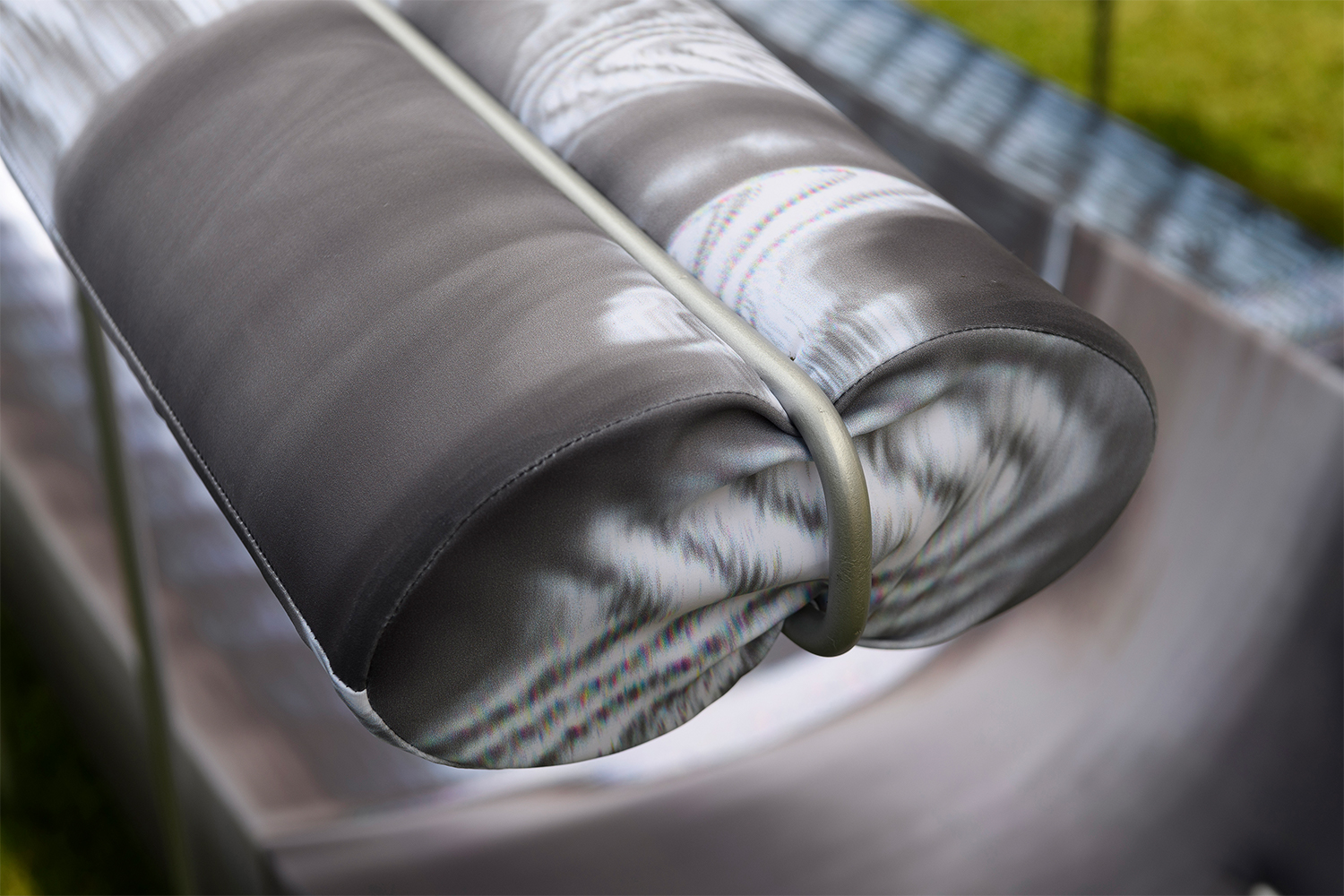Ancor più della fotografia, forse è il cinema il medium della morte. La pellicola fotografica fissata in un’emulsione chimica, in grado di catturare solo un certo tipo di luce, evoca la stasi finale del tempo e del corpo. Il mezzo filmico, al contrario, in modo senz’altro più esasperato e forse crudele, offre una visione del movimento e della possibilità di riportare a nuova vita, che va oltre l’immobilità della morte, seppure momentaneamente. La linea di confine tra un memoriale e uno zombie è labile, e anche se quest’ultimo è abietto, sono entrambi un prodotto dell’amore. L’amore cerca di prolungare, l’amore aspira a isolare da un film un fermo immagine che parli a ogni cosa, subito. L’amore è anche il medium di Steve McQueen, ogni suo fotogramma è vita, anche se l’artista non cerca mai di separare l’istante atteso dalla narrazione attesa.
Non aveva tutti i torti il defunto Okwui Enwezor quando paragonò i film di McQueen agli interventi concettuali di Felix Gonzalez- Torres. Alla stregua dei migliori storici, entrambi permettono al tempo, nella sua totalità, di esistere simultaneamente, e nulla può essere cristallizzato in una statua. E se vi sono rocce nella mostra di McQueen, sono due entità di marmo illuminate da riflettori nell’installazione scultorea Moonlight (2016), con le parole “New York New York” stampate sulle loro labbra di pietra. Sono pronte a esibirsi per noi, ma solo se scelgono di farlo.
Perché l’amore può essere contrario alla performance se quest’ultima è il prodotto di una vergogna, di una violenza, di una tradizione perniciosa, dell’applicazione di un pigmento, o se il movimento è di fatto una migrazione forzata. L’omonima installazione video a due canali Sunshine State (2022) attinge il suo materiale dal grottesco, ma ancora venerato, film The Jazz Singer (1927), anch’esso foriero di morte per l’era del cinema muto. È quasi impossibile riconoscere la natura al tempo stesso problematica e storicamente significativa di un artefatto culturale senza finire per somigliare a quei fidanzati che si sentono sempre in dovere di difendere Woody Allen.
Piuttosto che abbracciare una politica di difesa, potremmo invece partire dal fatto incontrovertibile che McQueen ama il cinema, la televisione, e l’arte in generale, pienamente consapevole delle ardue complessità di una cultura visiva che è sempre stata investita istericamente dal razzismo. E questo amore per il cinema ha sempre rappresentato per McQueen lo strumento per dare voce e immagine a coloro che sono morti, nel caso specifico a suo padre. McQueen racconta attraverso una voce fuori campo una storia che suo padre gli aveva tramandato: un episodio di violenza razzista (i dettagli dell’aggressione sono rivelati meglio nel film) accaduto in Florida, il cosiddetto “Sunshine State”. Intanto, Al Jolson si cosparge la faccia di sughero bruciato, cotto al sole. Nell’universo di McQueen, dove il film va avanti e indietro e il positivo e il negativo si invertono, quel trucco cancella il volto di Jolson, anche se annuncia falsamente la presenza e la resistenza della bianchezza. La bianchezza, invulnerabile per così tanto tempo, si rivela quale burlesque amatoriale.
Al di sopra di un sole cocente che ricorda l’appellativo della Florida, non da tutti sperimentato allo stesso modo, McQueen sussurra “splendi su di me sunshine state, splendi su di me”, divenendo nel processo un poeta, come in realtà è sempre stato. Man mano che il video scorre, il racconto di suo padre, così come il volto di Jolson e la storia, svaniscono progressivamente e vengono messi a tacere ancora una volta, divenendo il collage poetico di una performance dadaista. Eppure, nonostante l’imitazione dell’arte e il suo contrario, la vita di fronte all’immanenza della morte non è una performance. E la morte è l’ultimo confinamento in un singolo medium, che è anche quello che ingiustamente chiediamo a tanti artisti. Il più grande atto d’amore è permettere alla luce del sole, che per sua natura può scaldare piacevolmente o bruciare crudelmente, di scaturire dalle opere di McQueen o in egual misura di posarsi su di esse.
E in verità, in “Sunshine State” tutte, attraverso i media e il tempo, risplendono.