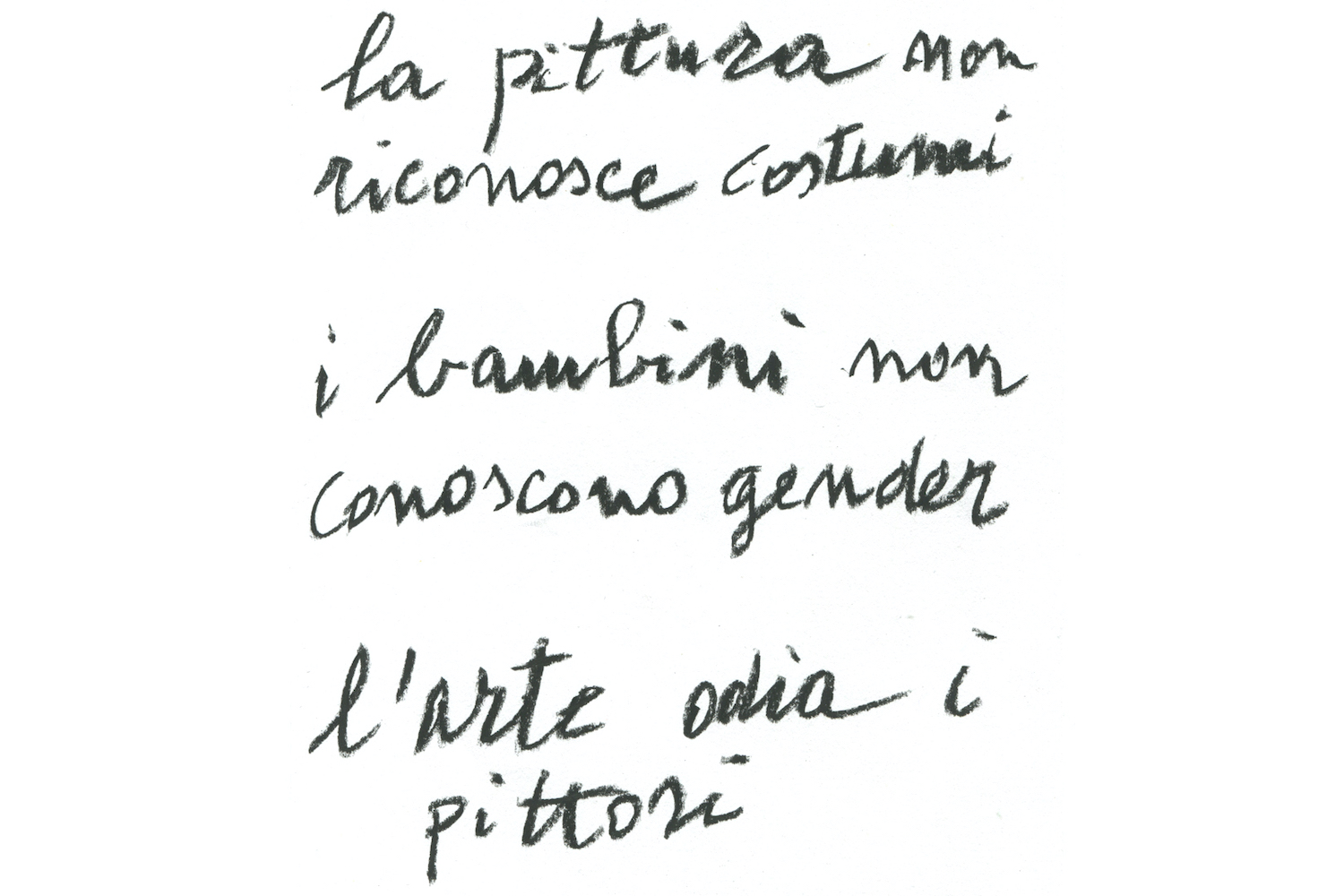Dalla sua ultima mostra collettiva al Museo di Arte Contemporanea di Termoli (MACTE), “Ersilia. Praticare l’altrove” a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, con Beatrice Celli abbiamo riflettuto sul potere immaginifico della città e su cosa significhi collocarsi nel mondo contemporaneo, sia per noi stesse che per le nostre rispettive pratiche culturali. Abbiamo esplorato la sua poetica che integra riti e simboli, rafforzando una forma di “restanza” artistica. Il filo conduttore di questa conversazione è il desiderio di “re-incantare il mondo”, come proposto dall’intellettuale, scrittrice e attivista femminista Silvia Federici, per creare nuovi legami con il tempo, con gli altri e con la memoria collettiva, cercando di recuperare ciò che rischia di essere dimenticato o messo a tacere a causa delle forze disgreganti della crisi passate e presenti. In definitiva, questo dialogo “situato” è un tentativo di riannodare i fili della nostra storia collettiva, consapevoli che la conoscenza non è mai neutrale o universale, ma sempre collocata in contesti specifici e influenzata da molteplici fattori socio-culturali, storici e personali.
Roberta Garieri: Vorrei iniziare questo dialogo partendo dalla tua ultima mostra al MACTE “Ersilia. Praticare l’altrove”. Puoi raccontarmi come hai lavorato e quali sinergie si sono articolate tra spazi reali e immaginari?
Beatrice Celli: La mostra al MACTE è nata dalla serie di podcast intitolata Ersilia, ispirata a una delle città invisibili di Italo Calvino. Insieme alle due curatrici, Alice Labor e Ginevra Ludovici, ho creato il podcast Il Palazzo delle superstizioni, un universo spirituale e organico capace di accogliere una molteplicità di credenze. Immaginando una comunità con un senso della realtà elastico, è stata un’occasione per scolpire con l’immaginazione diversi rituali e oggetti di culto.
Per la mostra, abbiamo riproposto La Festa Macabracadabra, un’installazione che ho realizzato nel 2018. Si tratta di una festa di paese inventata, dove i vari elementi sono caratterizzati da una certa violenza che si svela nei dettagli, integrandosi nei colori e nell’atmosfera carnascialesca. Come d’abitudine, ho utilizzato materiali “vivi”, modesti o un po’ usurati, accettando che possano scomparire, come nel caso del popolo di bambole ispirate a un dolce pasquale della mia regione, creando un sincretismo tra l’estetica degli ex-voto e le bambole voodoo. Le prime sette bambole che ho realizzato in pasta di sale sono state rosicchiate dai parassiti. Per “Praticare l’altrove”, ne ho realizzate altre cinque. Mi interessa il gioco di sguardi che queste presenze inquietanti possono creare nello spazio; è lo spettatore che alla fine viene osservato da loro e non il contrario. Il MACTE, con la sua forma circolare, ricorda una piazza, un luogo ideale per evocare scambi, soste e nuovi valori comuni. Abbiamo concepito l’installazione come una narrazione, un percorso da scoprire gradualmente. Dapprima si percepisce l’odore dell’incenso, poi si attraversa una foresta di campane mostruose, e infine si scopre lo strano dialogo fra le varie entità e spiriti che accolgono lo spettatore, facendolo sentire parte di una coreografia. Nonostante gli elementi familiari, soprattutto per chi viene dal Sud, questa festa di paese a tratti inquietante e grottesca rimane infine misteriosa. Ci si chiede: cosa stiamo richiamando con il suono delle campane? Cosa trasporta la Carovana? Cosa stanno sognando le palpebre dorate di Santa Lucia?
RG: La tua opera è ricca di simbolismi e riferimenti a rituali e tradizioni. Come scegli i simboli e gli elementi che inserisci nelle tue installazioni? Penso per esempio all’opera Sorella carovana (2019); quali esperienze o influenze personali l’hanno ispirata?
BC: Direi che sono più i simboli e gli elementi che scelgono me. Sorella Carovana viene da un sogno in cui una carriola si trasformava in carovana. Mi piaceva molto l’idea di integrare due simboli quasi contrastanti: uno legato alla terra e alla fatica, l’altro al nomadismo e all’immaginazione. Il contenuto è nascosto. Le figure vengono dal mio immaginario personale, sono spiriti e entità che convoco attraverso il disegno automatico, li ho poi ricamati sulla carovana e li ho arricchiti con gioielli, gingilli, piccoli regali, amuleti e semi. Ogni volta che la espongo, c’è qualcosa che scompare, lasciando il posto a qualcos’altro.
Nelle opere S. Antonio e il maiale e S. Lucia, ho voluto dare spazio all’immaginario pagano-popolare legato ai due santi. Luigi Lombardi Satriani parla di cattolicesimo folklorico, dove comportamenti arcaici di devozione contrastano con l’universalità del cattolicesimo ufficiale. Non fanno eccezione le celebrazioni legate a S. Antonio Abate. Mi ricordo che quando ero piccola, ero molto attirata, quasi spaventata, dalla scultura del maiale che era associata a S. Antonio nella chiesa del mio paese; mi dissero che rappresentava il demonio. La pelle del maiale era utilizzata per curare “il fuoco di S. Antonio”, cioè l’herpes zoster, e da qui la volontà popolare ha associato l’animale al santo. Durante le inaugurazioni, la mia scultura viene attivata inserendo l’incenso della chiesa, introducendo un elemento olfattivo nell’installazione. Santa Lucia, invece, inizialmente non faceva parte della festa Macabracadabra, l’ho realizzata nel 2017. Il piatto di ceramica è di mia nonna, forse della fine del XIX secolo. Santa Lucia è venerata come la protettrice della vista per una simbolica connessione tra il suo nome e la luce; per rafforzare questa associazione, al MACTE è stata esposta quasi come una sorta di astro. In realtà, non si tratta di occhi, ma di palpebre, quindi un invito a connettersi con altre dimensioni rispetto a quella visibile.
RG: Quali sono le potenziali implicazioni sociali, culturali ed economiche di esplorare e immaginare insieme futuri alternativi per la città reale, prendendo spunto dalla narrazione di Ersilia? E che ruolo assume la pratica artistica in tutto questo a tuo avviso?
BC: La mostra “Praticare l’altrove” rivendica la valenza politica dell’immaginazione e la sua capacità di trasformare la realtà. Tutte le opere degli artisti in mostra mi hanno fatto riflettere sulla molteplicità delle voci che abitano uno spazio e sui legami profondi tra comunità, storia locale e visioni alternative. A Termoli, ho scoperto la leggenda de “A cambäne de Santa Catarine” (La campana di Santa Caterina). Pare che si possano sentire i rintocchi di una campana nei giorni di tempesta e che si tratti del pesante bottino di guerra dei Turchi, che nel 1556 li fece naufragare. Per una strana coincidenza, c’erano delle campane anche nella mia installazione. Ho immaginato delle campane stregate, dalle forme ibride e ambigue, in risposta alla conquista dello spazio-tempo delle campane della Chiesa. Nel podcast avevo anche menzionato la consuetudine di Ersilia di costruire un nuovo campanile ogni anno, secondo la visione che veniva in sogno a una persona diversa.
Nel paese si convive con rovine e luoghi impregnati di leggenda, poesia e storie. La pianificazione urbana tende ad adottare schemi rigidi e uniformi, spesso dettati da visioni dall’alto o dalla speculazione immobiliare, finalizzati a ottimizzare la funzionalità degli spazi. Mi immagino una città che promuova più spontaneità e autonomia dal basso. Nei centri non urbanizzati si vive una maggiore porosità fra spazi domestici e pubblici. I vicoli dei paesi sono come le mensole di una credenza collettiva, su cui si accumulano le “cianfrusaglie” invisibili della vita che si è svolta lì. Ti rigiro la domanda: pensando a Ersilia, cosa ti viene in mente rispetto alle città reali, soprattutto in relazione ai luoghi del Sud Italia in cui siamo cresciute?
RG: Il racconto di Ersilia mi porta a riflettere sulla fluidità del concetto di permanenza, specialmente nelle regioni meridionali come le nostre. Il tema del radicamento e dello sradicamento è una realtà vissuta quotidianamente, distante dall’essere un cliché, ma piuttosto una testimonianza tangibile della nostra esistenza. Tutto questo mi porta a riflettere anche sul lavoro di Maria Lai e la sua opera Legarsi alla montagna (1981), in cui un nastro azzurro lungo 27 km diventa il simbolo di una connessione profonda tra la comunità e il proprio territorio. Questa forma di legame con il territorio, così viscerale e tangibile, diventa un modo per preservare e valorizzare le radici culturali e la memoria collettiva di una comunità. Pare che alcuni giorni dopo l’evento, nella rubrica d’informazione Cronache italiane, supplemento del telegiornale quotidiano, la televisione nazionale abbia riportato la notizia come una festa di paese particolare, per la quale erano tornati ad Ulassai anche i lavoratori emigrati. La festa, conosciuta come Il nastro di Ulassai, ha attirato l’attenzione dei media nazionali per il suo significato e la partecipazione delle persone che, nonostante l’emigrazione, conservano un legame profondo con la propria comunità d’origine.
RG: Nel corso delle nostre conversazioni, abbiamo spesso richiamato il concetto di “situarsi”. Potresti spiegarmi cosa significa per te? Personalmente, interpreto questo termine come il processo attraverso il quale un individuo si colloca non solo fisicamente nello spazio, ma anche emotivamente, eticamente e simbolicamente. Il situarsi implica una sorta di forza intrinseca che ci guida nel rimanere fedeli alle nostre convinzioni, alla nostra visione del mondo e al nostro modo di agire. Vorrei approfondire questo concetto in relazione alla tua pratica artistica e al modo in cui influenza il tuo lavoro.
BC: Inizio con un situarsi concreto: quello geografico. Come abruzzese, nella mia pratica sottolineo la continuità con un’eredità matriarcale di saperi artigianali, riti e superstizioni, che emerge fortemente nel mio lavoro, come se non fossi sola a crearlo. È una micro-storia del Sud Italia, occultata sia per proteggerne il mistero, sia per difendersi dallo scetticismo del pensiero tecnico-scientifico, dal Cristianesimo, dalle posizioni anti-meridionaliste, ma anche perché si tratta di una storia al femminile, quindi poco valorizzata. Ancora oggi, quando ne parlo con gli anziani del mio paese c’è sempre il timore di essere etichettati come ignoranti o arretrati. Al contrario, cerco di riattivare questi “resti di mondi incantati”. Come artista penso anche a una dimensione etica e umana del “situarsi”. La cultura mistico-popolare è costituita da risposte a quella che De Martino considera una “crisi della presenza”, uno stato di alienazione così forte che la creazione di un altro piano di realtà, quello magico, diventa l’unica soluzione. Se si osserva aldilà delle forme colorate e dei racconti immaginifici, il folklore contiene i drammi, le crisi e i traumi di una comunità che cerca di resistere alla violenza di una cultura dominante, ai terremoti, agli abbandoni, alla corruzione e alle emigrazioni. Per me, situarsi coincide con il senso di appartenenza che va oltre la geografia, rappresentando il sentire comune di chi ha attraversato le stesse difficoltà. È necessaria molta sensibilità quando si entra in contatto con le memorie vive legate a questi vissuti di vulnerabilità.
Parlando invece del quotidiano oggi mi situo di più in questo andirivieni fra Marsiglia e Castelli, un punto di osservazione privilegiato, che mi ha permesso di comprendere certi meccanismi di dominazione interiorizzati. I piccoli paesi sono criticati per la loro staticità, soprattutto da chi li abita che richiede di continuo più servizi, a volte più per i turisti che per loro stessi. Eppure, è proprio grazie a un certo lassismo, i vari “malfunzionamenti”, il dolce far niente che hanno potuto preservare la loro diversità, resistendo all’appiattimento di un progresso omologante.
Dopo il COVID, sono diventati i rifugi per chi cerca pace, contatto con la “natura” e tradizioni, ma queste narrazioni turistiche sono davvero banali e ancora peggio, condizionano lo sguardo degli abitanti sul loro stesso paese. Dopo il terremoto, si proponeva di nascondere i danni per non spaventare i turisti, creando una frattura tra ciò che è presentabile e ciò che non lo è. Questi mondi incantati di cui prima, sono in realtà legati a doppio filo con il senso di impotenza, il disordine e l’isolamento. Il mio paese, con tutta la sua irrequietezza, rimane per me un punto di riferimento solido, confortante, così come le montagne che lo circondano. C’è qualcosa che resiste, un altrove metafisico che sembra immobile ma che è lo specchio perfetto dei mutamenti del mio sguardo. Sto maturando sempre di più la consapevolezza che partire non è stata solo una scelta. E di partenze e rientri ne abbiamo parlato spesso e mi sembra che queste geografie caratterizzino il “nostro situarsi” fra l’Italia e la Francia. Tu come vivi questi attraversamenti continui?
RG: Per me, la consapevolezza del “da dove vengo” è giunta in un secondo momento. Sono convinta che sia stato proprio grazie a queste traiettorie, ai ritorni e alle partenze che ho compiuto tra i diversi Sud – dell’Italia, della Francia e del Cile – insieme alle mie ricerche, riflessioni e soprattutto alle continue decostruzioni e decentramenti, che ho potuto sviluppare una consapevolezza più chiara del mio Sud di provenienza, la Calabria, a cui sento di appartenere, sebbene non completamente. Concetti come origine e radice mi risultano scomodi, poiché ho sempre cercato di sfumarli e sradicarli, anche se riconosco che hanno rappresentato un punto di partenza importante che ha dato senso e stabilità al mio percorso umano e intellettuale. In qualche modo, le esperienze vissute in questi Sud mi hanno permesso di osservare la Calabria con una nuova consapevolezza dei rapporti di potere e dominio che permeano non solo la vita nel Sud, ma anche l’Italia nel suo complesso, in modo quasi invisibile e inconscio. Questa dinamica, poco studiata e analizzata, potrebbe svelare aspetti nascosti che dimostrerebbero altre modalità di esistenza nel mondo, non solo in termini di stili di vita, ma anche di credenze, concezioni del tempo, dello spazio, delle stagioni, della natura e delle relazioni. Studiosi e artisti, come te, hanno iniziato a esplorare queste asimmetrie interne all’Italia legate in un certo senso al progresso che, a sua volta, è strettamente legato alla modernità coloniale, come sottolineano molti teorici del pensiero latinoamericano. Secondo questi studiosi, ciò che inizialmente si presentava come un nuovo ordine mondiale si è trasformato in un potere globale che persiste ancora oggi, seppur sotto forme diverse. Tuttavia, è rimasto ancorato alla stessa matrice di potere, rendendo incompiuto il progetto decoloniale. Faccio riferimento a questo perché è un ambito di riferimento per le mie ricerche; questo pensiero ha accompagnato la mia riflessione sul fatto che anche in Italia si vivono le medesime asimmetrie. Spesso siamo portati a osservare i danni che questa corsa ha causato in altri Sud, oggi riferiti come “sud globale”. Tuttavia, credo che dovremmo imparare a guardare più vicino a noi e riconoscere come queste disuguaglianze, pur diverse rispetto a quelle delle società postcoloniali, influenzano anche il nostro paese. Anche in Italia, vediamo gli effetti delle disparità economiche e sociali, delle migrazioni interne ed esterne, e della marginalizzazione di certe regioni e culture. Questi squilibri sono spesso meno evidenti, e certamente meno violenti, rispetto a quelle dei contesti postcoloniali, ma non meno significativi. Riflettere su queste realtà ci porta a confrontarci con la nostra storia e le nostre sfide contemporanee, riconoscendo che le dinamiche globali di potere e resistenza hanno delle ripercussioni locali in altri sud resi invisibili, in parte anche dalle mode culturali. Questo ci impone di adottare uno sguardo critico verso le nostre strutture, e di esplorare come possiamo affrontare le ingiustizie e le disuguaglianze che persistono. Forse è un invito a seguire il poeta Édouard Glissant: “Agisci nel tuo luogo, pensa con il mondo”.
Osservo inoltre nel tuo lavoro una profonda sensibilità verso la cura, la conservazione, l’archiviazione di storie spesso trascurate dalle narrazioni ufficiali. Vorrei capire meglio qual è il tuo legame con i concetti di memoria e amnesia culturale e come li integri nel tuo processo creativo.
BC: Mi piace molto la visione di nostalgia positiva di Vito Teti, caratterizzata da un certo tipo di malinconia di fronte alle rovine, agli abbandoni e alle macerie del Sud Italia. Mi piace recuperare tutte quelle storie che hanno a che fare con l’idea di un passato diverso. La storia ufficiale non ci restituisce il vissuto degli oppressi, dei marginali, il quotidiano di tutte quelle figure legate ai ruoli di cura, che raccontano altro rispetto ai giochi di potere del colonialismo e dell’imperialismo economico.
Penso, per esempio, alle curatrici della mia regione, le magare, la cui memoria è stata completamente occultata, nonostante abbiano aiutato molte persone. Fino a qualche anno fa si faceva ricorso alle loro conoscenze, mentre adesso ci si vergogna di loro, additate come frutto dell’ignoranza popolare o, peggio, jettatrici, pazze o truffatrici. Ma allora come mai così tanti si rivolgevano a loro?
Per concludere, nel Sud Italia si possono incontrare remoti resti di memorie vive, testimonianza di un modo magico di stare al mondo. Queste ci ricordano che fino a 50 anni fa non avevamo bisogno di produrre spazzatura per sopravvivere; ci ricordano i valori dell’interdipendenza con il vivente, il senso di comunità e il quotidiano impregnato di incanto. Come artista, mi pongo in continuità con tali tradizioni che, per altro, sono da sempre in evoluzione e rinegoziazione costante. Sarebbe bello liberarle dal patriarcato, dal nazionalismo e da tutte le posizioni identitarie, con la loro inevitabile dose di violenza, e restituirle alla flessibilità della creazione, trovando un giusto equilibrio tra senso di appartenenza e apertura all’altro.