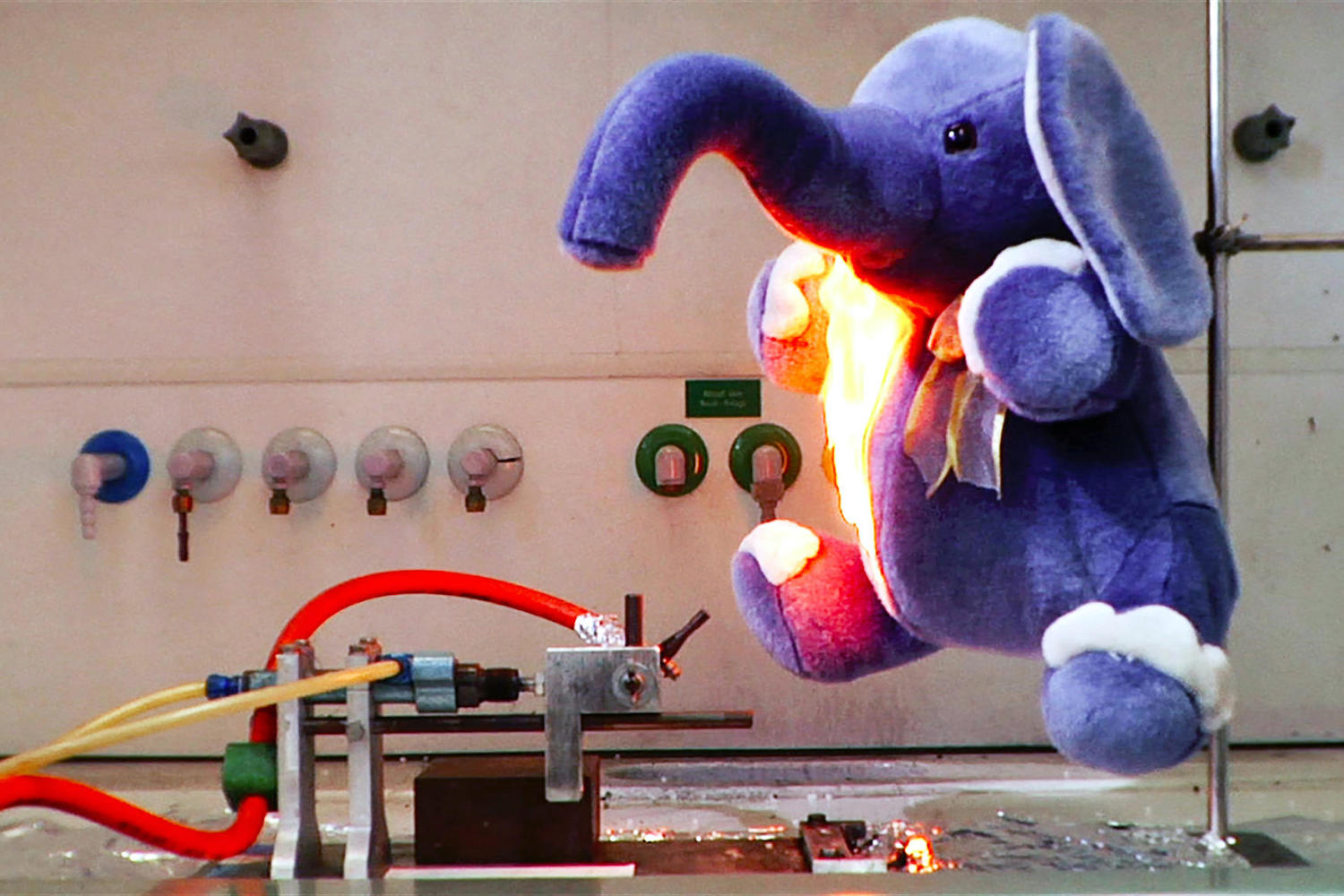In “STEADYSTATE”, il tempo non scorre: attarda, si ripete, e poi svanisce. La mostra collettiva da Zero… a Milano, curata insieme a Neue Alte Brücke di Francoforte e Matt Williams, si inspira alla teoria dello stato stazionario, in inglese nota come steady state theory of the expanding universe. Elaborata intorno gli anni cinquanta del Novecento come alternativa al modello del Big Bang, questa teoria si riferisce a un cosmo senza origine né fine, in costante espansione ma in equilibrio permanente. Contro le narrazioni dominanti fondate da un inizio e una rottura, “STEADYSTATE” propone un mondo in cui la creazione è continua, la materia colma i vuoti e il cambiamento si manifesta come una trasformazione silenziosa e ininterrotta.
La mostra, che riunisce diciassette artisti internazionali, si configura come una riflessione sul tempo, non più inteso come contenitore neutro, ma condizione attiva in grado di modellare percezione, esperienza e identità. In questa prospettiva, sembrano risuonare in “STEADYSTATE” le teorie sul tempo elaborate da Martin Heidegger ne Il concetto di tempo (1992) ed Essere e tempo (1927); secondo Heidegger, il tempo non è qualcosa che attraversiamo, ma l’orizzonte stesso della nostra esistenza. Ossessionati dall’inizio e la fine delle cose, “STEADYSTATE” ci pone di fronte a uno stato di sospensione destabilizzante, nel quale la condizione stazionaria stessa annulla ogni struttura narrativa, divenendo da una parte una visione inquietante, e dall’altra liberatoria.
Questa sospensione trova una delle sue espressioni più efficaci in active because it leaks (2022) di Cally Spooner, una performance temporale che, costituendosi per intervalli – il ritmo della prova, della fatica, della cura del corpo attraverso lo spazio espositivo – non giunge mai a una forma compiuta. I performer agiscono come presenze intermittenti, fantasmagoriche, generando piccole rotture nel flusso del tempo. Spooner cancella la distinzione tra produzione e manutenzione dell’opera, tra evento e durata: ciò che rimane è un lento trascinarsi nel tempo, una perdita progressiva di senso e attenzione.
Non lontano, Scanner (2023) di Mariia Andreeva propone una forma diversa di vigilanza, tecnologica ma sensibile all’instabilità dello sguardo. Un occhio meccanico ruota incessantemente nello spazio superiore della galleria, coinvolgendo pubblico e ambiente in un circuito di osservazione reciproca. Chi guarda chi? E attraverso quale dispositivo? La freddezza della macchina contrasta il ritmo più corporeo del lavoro di active because it leaks, ma entrambe le opere condividono l’idea che il tempo non sia un fattore esterno, ma al contrario che ci attraversa, ci contiene.
La tensione tra corpo e controllo, presenza e cancellazione percorre tutta la mostra. I due lavori di Eva Gold la esplorano in modo intimo e stratificato. Al piano superiore, il divano vintage di You were disgusting and that’s why I followed you (2024) diventa palcoscenico per una poesia parlata che evoca memorie domestiche e residui intergenerazionali: “Right at the very beginning when you caught my eye, I had the uncanny sense that I was making eye contact with my own reflection”1. Al piano inferiore, 24 Hours (Residual Heat) (2025) si affida a un’installazione minimale: una striscia LED con la scritta “24 Hours” posta sopra il livello dello sguardo replica il ciclo luminoso di una giornata, riorganizzando impercettibilmente il nostro orologio interno. Gold non rappresenta il tempo, ma lo fa infiltrare, trasformando la galleria in un organismo circadiano.
Il tempo, per Nat Faulkner, si manifesta invece attraverso processi chimici lenti e irreversibili. Una finestra in plexiglass riempita di liquido per sviluppo fotografico – Untitled (Iodine) (2025) –, attraversa letteralmente la parete della galleria, fino a macchiare il pavimento. L’opera porta ancora oltre la metafora corporea; evoca la pelle, i fluidi, la disgregazione. Qui il tempo non è durata, ma corrosione, una forza che erode materia, memoria e spazio.
In questa prospettiva entropica, l’archivio compulsivo di Hirst Ademeit si rivela meno come paranoia ossessiva e più come cosmologia alternativa. 3497 (02.10.1998) (1998) è una delle migliaia di polaroid annotate quotidianamente per provare l’esistenza di quelli che l’artista definiva “Cold Rays”. Queste immagini costruiscono un universo a sé: un rituale documentario senza scopo né fine, una resistenza silenziosa all’oblio che, come lo stato stazionario, non raggiunge mai un climax, ma persiste.
A rompere questa continuità, Surgery (2024) di Ghislaine Leung interviene con un gesto chirurgico e concettuale. L’opera, in due versioni distribuite su entrambi i piani della galleria, consiste nella rimozione precisa dell’1% dell’architettura, avvolta in plastica bianca industriale. Un gesto che richiama tanto l’Institutional Critique quanto la biografia dell’artista – in particolare la sua isterectomia. Leung non aggiunge, sottrae: mette a nudo il corpo dell’istituzione, i meccanismi che strutturano la nostra percezione di spazio e tempo.
Infine, The Dome (2024) di Yvo Cho si apre come un’improvvisa visione verso l’alto. Un drone sorvola la cattedrale di Colonia in un video girato senza autorizzazione, tracciando lo spazio sacro con precisione e grazia inquietante. Il movimento è ipnotico, quasi ultraterreno: il drone diventa spirito, penetra l’architettura come in un atto di devozione. La colonna sonora amplifica questa immersione – non siamo più a terra.
“STEADYSTATE” non offre ne risposte né conclusioni. Propone un’arte della persistenza, del ritardo, della mutazione continua. Una cosmologia dove tutto è già in trasformazione. Come il tempo heideggeriano, non punta in avanti né indietro, ma si espande sempre più verso l’esterno, attirandoci in frequenze sovrapposte, dove il significato non si fissa mai, ma ritorna.