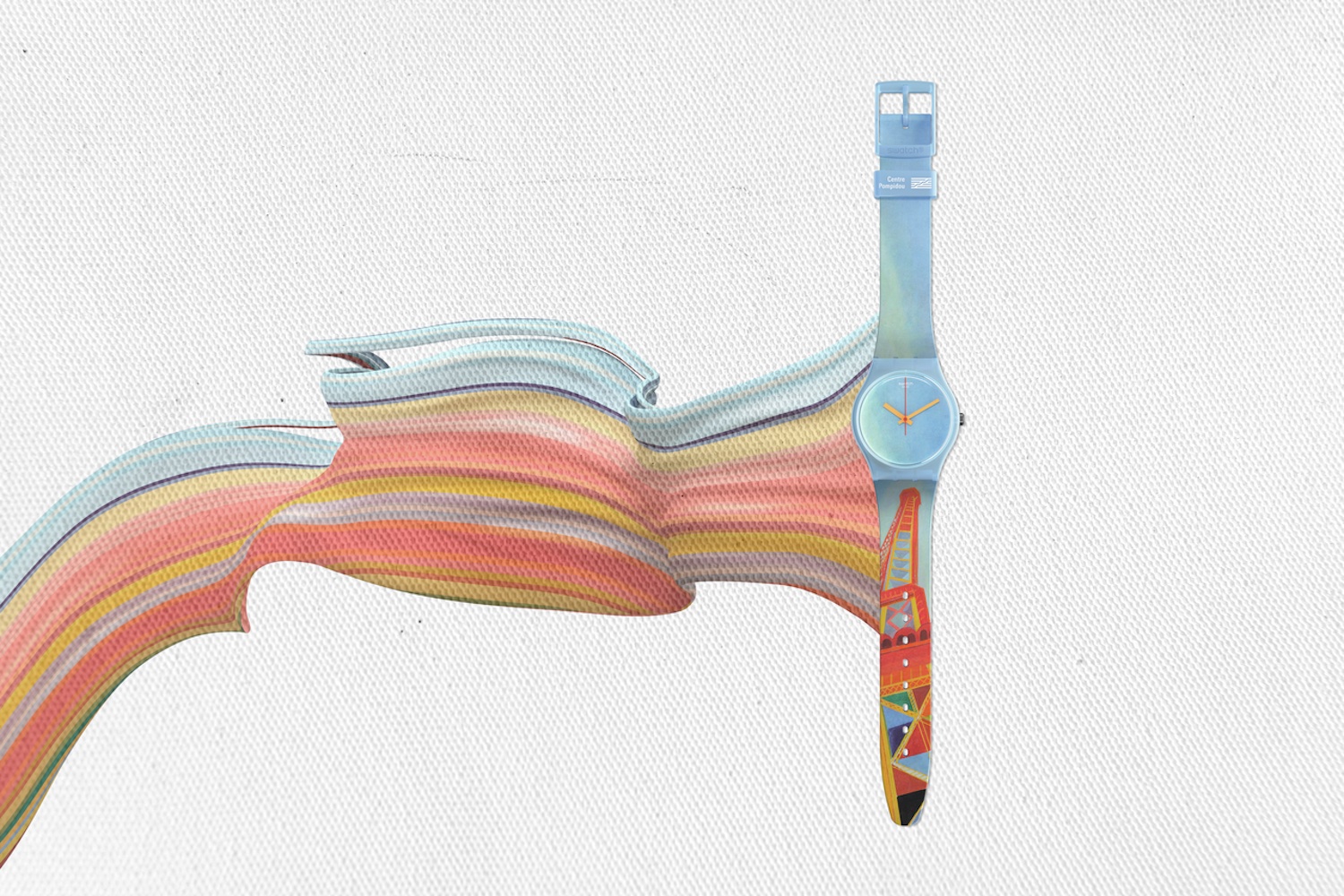La pratica di Valentina De Zanche si articola tra testo, installazione, scultura e suono, in una dimensione performativa e profondamente introspettiva. In occasione della mostra “Noise of Time” presso Milliony Arlekina a Milano inaugurata il 18 settembre 2025, l’artista ha costruito un ambiente in cui lo spazio espositivo diventa partitura, il testo prende corpo in oggetti simbolici (la sella, l’alfiere), e la scrittura si trasforma in suono. Il risultato è una costellazione di opere in cui il tempo non scorre, ma si inceppa, si moltiplica, ritorna come rumore, come loop, come domanda irrisolta. Questa conversazione si muove tra i diversi layer del progetto: il testo originale, le sculture, la tela dipinta, la pubblicazione e un sound piece disponibile solo in mostra. Un’indagine sul tempo, sulla percezione, sulla vulnerabilità e sul caos, che riflette la necessità, oggi sempre più urgente, di orientarsi nel rumore della contemporaneità.
Greta Pasini: La mostra che hai pensato per Milliony Arlekina presenta un livello di stratificazione importante: l’installazione a pavimento, la grande tela, le due sculture, una pubblicazione e un sound piece. Hai saputo intrecciare la tua ricerca all’identità della galleria, un luogo multiforme aperto al cambiamento continuo, che sfrutta il dispositivo di una grande vetrata. Come spesso avviene nel tuo lavoro, tutto inizia da un testo…
Valentina De Zanche: Sì, tutto nasce dal testo Noise of Time (2025), una sorta di stream of consciousness tra una voce narrante e due protagonisti: l’alfiere (And the bishop goes ziiiiink, 2025) e il cavallo (But then the knight comes, the knight comes, 2025) che, nella mia opera, perde la sua animalità estetica sintetizzandosi in una sella. Ho scritto Noise of Time (2025) con un andamento ritmato, capace di restituire una componente fondamentale del gioco: l’attesa e lo scambio di turno tra i giocatori. In qualche modo l’alfiere e la sella rappresentano anche un dualismo maschile-femminile che riflette sia strutture sociali che dinamiche individuali. L’alfiere è elemento di forza e agilità, ma si interroga sull’efficacia del proprio agire mostrando vulnerabilità, insicurezza e bisogno di controllo. Il suono che produce è meccanico e tagliente: ziiinkkkk… ziiiinkkk… Lo si immagina tagliare la diagonale con decisione, per poi fermarsi e guardare scettico alle proprie mosse. Grazie a questi due personaggi, che in mostra diventano sculture argentate, parlo del mio modo di vivere il tempo: una scansione percepita come ricerca continua, radicata nel bisogno inconscio di trovarle un senso. A questa ricerca si intrecciano vari temi che alimentano la mia pratica: l’esistenzialismo, la politica, l’ambientalismo, il ricordo emotivo, ma anche gli obblighi lavorativi e sociali. Con la mostra da Milliony Arlekina ho contestualizzato queste due figure antitetiche come reduci da una lunga partita: appaiono congelate dopo un’analisi introspettiva dei reciproci ruoli in società e dei concetti di tempo e spazio come dimensioni essenziali.
GP: Nel tuo lavoro, elementi iconografici come la sella (sospesi tra funzione e simbolo) sembrano caricarsi di significati che travalicano quella tradizionale. Se l’alfiere evoca una forma di verticalità, di strategia maschile, la sella (con la sua natura ibrida, a metà tra il corpo animale e il controllo umano) appare come un dispositivo ambivalente: luogo di costrizione, ma anche di rituale. Mi raccontavi di come proprio nella sella si concentrino elementi di castrazione della femminilità, ma nella tua scultura le staffe infiocchettate sembrano quasi sabotare quel linguaggio di dominio, rendendolo performativo, forse addirittura affettivo. In questa prospettiva, la sella diventa non solo oggetto ma anche voce, narratrice di un’identità in tensione tra l’infanzia e la rivolta, tra la docilità e l’insubordinazione. E quindi ti chiedo, può la sella, così come la rappresenti, essere letta come un archetipo femminile in atto di metamorfosi? Un luogo in cui la disciplina si trasforma in gesto magico, e il corpo, prima domato, diventa agente di disordine?
VDZ: Sì, la sella è centrale nel mio lavoro, proprio perché si colloca simbolicamente a metà strada tra l’anatomia animale e quella umana. È un oggetto funzionale, ma anche profondamente ambiguo: serve al controllo, alla dominazione, ma porta con sé una carica quasi rituale. Nel testo che accompagna l’opera, la sella è descritta come spontanea, istintiva, eppure giudicata. C’è un senso di costrizione che si riflette nella frase “Knees up, knees up!”, un gesto che è insieme comando e ribellione. Questa sella incarna una femminilità in rivolta, radicata nell’imprevedibilità e nell’animalità. Nella seconda parte del testo, il tono cambia: la voce della sella diventa cantilena, quasi una nenia. L’ho immaginata come una figura esoterica, una sorta di sciamana o strega, che attraverso un rituale magico cerca di liberarsi da una sofferenza. In questo senso, la sella non è solo uno strumento di dominazione: diventa anche un mezzo di trasformazione. È un simbolo ambivalente, che racconta sia la costrizione che la possibilità di emancipazione. E sì, in questo riconosco qualcosa di me, della mia storia, e di un certo modo femminile, forse anche infantile, di resistere alla rigidità imposta.
GP: Alfiere e sella si materializzano nelle sculture in mostra. Sono due, come i colori che si alternano sulla scacchiera del pavimento e sulla tela dipinta: bianco e nero. Un dualismo che, come accennavamo, ritroviamo anche nel ritmo del testo che hai scritto. A un certo punto, la voce narrante recita: «By peeling back the layers of meaning, a rich subtext is revealed. By tearing up the layers of sound a fandom world is created.» È la stessa frase che compare dipinta, con carattere graziato, al centro di un sipario tratteggiato, in cima alla grande tela Layers of meanings, layers of sound. Sotto, cinque riquadri simili a vignette di un fumetto si susseguono in una composizione che alterna proporzioni e direzioni: i primi due più piccoli, disposti in modo speculare agli ultimi, mentre al centro campeggia un pannello più grande. In quest’opera, come nel resto della mostra, le parole guidano lo sguardo e l’ascolto, invitandoci a “sollevare il velo di Maya” per entrare in una dimensione percettiva diversa, in cui spazio, tempo e suono si fondono. E proprio su questo: spazio, tempo e suono parlano di te… o parlano anche di noi?
VDZ: Spazio, tempo e suono parlano certamente di me, ma anche di noi. Il suono, in particolare, è una costante nella mia pratica artistica: mi riporta all’adolescenza, a quel legame viscerale con la musica che da allora accompagna il mio modo di creare. È un richiamo profondo alla tensione, al turbamento — legato ai ricordi di quel periodo. La musica è parte integrante della mia produzione, non solo come ispirazione ma come linguaggio emotivo. Nella tela ho rappresentato due volti di pupazzi che ammiccano: uno si sovrappone a un orologio da torneo per le partite di scacchi, l’altro richiama i cerchi del Camelot Wheel, una mappa armonica usata nella produzione musicale. Al centro, due figure caricaturali (un uomo e una donna ) affiancano un grande simbolo dello Yin e Yang: per me incarnano il Caos e la percezione soggettiva, elementi che ogni individuo porta con sé. L’intera scena è avvolta da una frase: «Should I doubt the reliability of the senses? Yet they can deceive me. Still astonished of how all can be arranged vividly through random access.» Con un’estetica volutamente infantile, quasi naïf, affronto in questa opera interrogativi profondi, anche esistenziali. È come se il testo fosse il copione di tutta la mostra: una narrazione visiva e scritta che si sviluppa tra le opere. Lo stile del disegno e del tratto è una forma di ritorno all’origine: alla fase primitiva della mia formazione, ai pensieri più istintivi ed emotivi, di gioia, speranza, ma anche paura. Attraverso questi media riesco a “fermare” il tempo, a cristallizzare emozioni che non voglio perdere. Raccolgo un attimo e lo condivido, e in quella condivisione l’esperienza si espande: non è più solo mia. Credo che comprendere il flusso della condivisione significhi anche superare la solitudine, accedendo a un altrove — forse più caotico, ma profondamente condiviso.
GP: Il suono ha bisogno di ascolto, dei sensi e anche di una dimensione emotiva. Penso sia molto importante intendere l’arte come forma di cura e di ascolto anche in senso metaforico. Il tempo inteso come un suono che unisce e rivela è molto interessante. Vedi questo come uno scambio, una forma di cura?
VDZ: Nella mia pratica artistica la ricerca del suono è strettamente legata al tentativo di dare significato allo scorrere del tempo. La domanda che ritorna nel testo, “What’s the noise of time”, è una ricerca che in fondo non trova una chiara risposta. Il tempo non ha suono, o se lo ha è qualcosa di irreale e fantasioso. La musica scandisce il tempo non solo in senso reale ma anche metafisico. Penso al ticchettio del metronomo: regolare e meccanico. Suonare mi aiuta a liberarmi da questa rigidità in modo emotivo. Chiedo alla musica di lenire le mie ferite legate all’idea di scorrimento per cui le situazioni e relazioni passano e mutano, a volte perdendosi nell’idea del passato. Scrivo per congelare un momento, con la musica l’emozione ritorna nel presente in forma sublimata, permanendo nella mia composizione. Queste due forme espressive si compensano reciprocamente, l’una sostiene l’altra. Quindi risponderei di sì alla tua domanda. Il testo, la musica e il suono che unisco nella mia pratica artistica funzionano per me come una forma di terapia. Molto di ciò viene dal dolore di esperienze passate: performando con il suono, la voce e le mie parole accetto il trauma, togliendomi di dosso un grande peso. Condividendo attraverso la performance, ciò che è intimo diventa collettivo. The noise of time è una frase che rimanda a qualcosa di irreale, ma le due parti, intimo e collettivo, si uniscono. Anche nella tela infatti ritornano simboli come se fossero archetipi. Nei momenti di depressione il tempo assume una forma dilatata e dolorosa, può essere anche plurale e quindi i tempi. In un certo senso un’ora può essere vissuta così intensamente da corrispondere a una settimana. Devo fidarmi della percezione dei miei sensi, oppure questi definiscono soltanto un modo per sopravvivere? Tutto questo non è tangibile. Attraversare un momento difficile può sembrare come se durasse una vita: ho capito che dandogli un suono sarebbe passato più in fretta.
GP: Quando mi hai parlato dell’idea di ricreare una scacchiera da Milliony ho subito pensato a Il Settimo Sigillo (1957) di Bergman, dove il protagonista, il cavaliere Antonius Blok, gioca una lunga partita a scacchi contro la morte per guadagnare tempo. La partita scandisce lo scorrere del film, oltre che la durata della vita del protagonista. Ogni mossa è un atto di resistenza, una scelta che ritarda l’inevitabile. Nel tuo testo, la scacchiera non è solo una metafora, ma un ambiente mentale e simbolico. Come nel film, anche nel tuo testo Noise of Time (2025) il gioco è lo specchio della vita. Ma, mentre nel film le regole sono chiare (vince chi sopravvive più a lungo), nel testo il gioco si fa surreale, glitchato, distorto: le pedine parlano, si muovono in loop, non portano salvezza ma maggiore consapevolezza del disordine. Sembra arrivare un senso di accettazione: come la inquadri nella tua produzione artistica?
VDZ: I soggetti che si muovono sulla scacchiera presentano una certa rigidità nei movimenti. Queste pedine, nel mio testo, vengono sconvolte dall’arrivo delle frecce: «Those little arrows I invented in my mind don’t ignore each other. They align or they are lying?» Le frecce sono pensieri che introducono il caos, dilatando i tempi del gioco. Porgono domande, scuotono e fanno vacillare. L’alfiere e la sella non giocano più le loro mosse, vengono interrogati da frecce di pensiero che portano a contraddirsi. Alla fine del testo emerge l’accettazione della contraddizione: un’analisi insieme personale e cosmica. Guardando all’etimologia di Chaos si vede come dallo spazio vuoto e abissale provenga la possibilità di ogni cosa. In origine significava apertura e creazione, solo in seguito è diventato sinonimo di disordine. Il mio modo di intendere questa partita, che poi è la vita stessa, va oltre l’idea capitalistica che vede il tempo come qualcosa da sfruttare al massimo. Il caos apre infinite possibilità, seguendo le emozioni. Questo è il sotto-testo di tutta la mostra, che ripropone una partita a scacchi quasi surreale. Alfiere e sella differiscono per colore dal dualismo bianco-nero del pavimento e della tela: sono entrambi argento, rimangono in una zona grigia, non si sfidano. Il film di Bergman è stato per me una grande fonte di ispirazione. Mi ha fatto riflettere sulla morte, sul lasciare andare. Il film procede grazie al procrastinarsi della morte del cavaliere. Questo mi ha fatto pensare alla possibilità di dimenticare e di lasciare andare. Con Bergman più il personaggio sopravvive più la storia continua.
GP: Come Antonius Blok, anche la voce narrante del tuo testo cerca una forma di risposta: non tanto una verità assoluta, ma un orientamento, un “arrow”, una freccia, una direzione nel rumore indistinto dell’esistenza. Il paradosso è che proprio nel caos sembra esserci la risposta più autentica. Nel sound piece in mostra, trovi che la domanda in loop del testo e la relativa accettazione della dimensione caotica e imprevedibile della vita abbiano in fondo una risposta?
VDZ: Più che una risposta, alla fine arriva l’accettazione in senso Cioraniano: non una resa passiva, ma un amaro riconoscimento del dolore come parte dell’esistenza, elaborato e condiviso attraverso la scrittura. Così impariamo ad accettare le cose come sono, belle o brutte che siano. A volte capita di svalutare gli eventi dopo una delusione, o anche solo per prevenirne il dolore. Se nulla ha valore allora tutto è possibile, come su un foglio bianco. Dal nulla nasce ogni possibilità. Una freccia che compie un giro intero. Seguendo una direzione ciclica e immaginaria degli eventi, accetti ogni cosa non negativamente ma lucidamente, permettendo al tempo di scorrere più veloce. Per ciascuno di noi tempo e spazio assumono connotazioni diverse e accettando questo, il loro peso perde significato. Proprio da questo vuoto può nascere qualcosa di nuovo sul binario infinito degli eventi.
GP: Il tuo testo è, in fondo, un ‘settimo sigillo’ scritto per il nostro tempo: in una società post-verità, iper-connessa e disorientata, il bisogno di senso viene sostituito dal bisogno di orientamento, e i simboli (bishop, knight, arrows) sono resti culturali fluttuanti, non certezze. Là dove Bergman usava il silenzio e l’ordine per raccontare l’angoscia, tu usi il rumore e il disordine per mostrare una crisi simile: la ricerca del ritmo giusto per vivere.
VDZ: Esattamente. Per come ho inteso io questa partita sulla scacchiera delle esperienze, gli unici appigli che propongo sono figure radicate nella memoria collettiva. Alcune sono arcaiche, come la scacchiera, che servono anche per nominare e analizzare la nostra contemporaneità fatta di caos, parole e immagini nette. La nostra mente e i nostri occhi sono continuamente sovraccarichi di input, portandoci a una forma di isteria contemporanea. Un tempo era la religione a unirci, oggi sono i prodotti e le merci a dominarci, gettandoci in un vortice di ansia e insoddisfazione. Anche di questo parlano il mio testo e la tela. Sì, analizzo questa tensione come fossero frecce impazzite che portano a pensieri intrusivi. I temi di cui parlo potrebbero sembrare, a una prima lettura, lontani e metafisici. Ma in realtà sono metafore della fatica che accomuna le generazioni di occidentali vicine alla nostra.
GP: Nel capitolo sull’(a)teologia gotica di Claudio Kulesko in Demonologia Rivoluzionaria (2020) scrive: «La storia del mondo in quanto storia naturale, non è che una stratificazione di eventi e processi mai definitivamente “morti e sepolti” che continuano a esercitare forza agentiva da una dimensione ribassata, o addirittura sotterranea, rispetto a quella attuale — eventi e processi che possono anche ripresentarsi in forma alterata, scombussolando la nostra percezione temporale.» Questo mi ha fatto pensare a quando parli di eventi come un loop, un ciclo continuo. Non c’è risoluzione a questo gioco infinito, le traiettorie si moltiplicano e ripropongono…
VDZ: Possiamo dubitare della nostra percezione. Quando capita, perdiamo le coordinate. Siamo cresciuti con un sistema scolastico e familiare che troppo spesso abituava a risposte certe, senza stimolare la coscienza critica. Ma tutto ciò che sappiamo, pensiero scientifico compreso, nasce dalla possibilità di pensare il mondo in modo immaginifico oltre che razionale. Se penso agli eventi storici, troppo spesso vengono presentati come certi, fissati in bolle di date e luoghi che tralasciano dati, informazioni e storie di vita. La storia, così come viene scritta, non può essere veritiera perché basata su una selezione. Credo che ogni persona insieme alle proprie azioni faccia parte di un unico pattern: indecifrabile e indefinibile, ma ciclico, continuo.
GP: Sempre nel tuo testo emerge un’ossessione per il tempo, che non è lineare: non si parla del “passare del tempo” ma del suo rumore, cioè di una percezione sensoriale, inquieta e meccanica. Un meccanismo che confonde orientamento e memoria. “The backwash of time” è un’immagine potente: il tempo non fluisce avanti ma ritorna come risacca, confondendo ciò che è passato e ciò che è presente. Questa confusione semantica si ritrova anche nella pubblicazione creata da Domenico Romeo. Come possiamo interpretare questo ritorno partendo dal mondo metafisico?
VDZ: Scrivere e partire dal testo per me è stato fondamentale. Le parole scritte hanno una valenza fisica: vedere nero su bianco mi ha aiutata a interiorizzare ciò che ho prodotto. Con Domenico Romeo ho creato una pubblicazione di poesia concreta che ha reso le mie parole ancora più tangibili e visive. La sua interpretazione, fatta di ripetizioni grafiche, ha dato nuova vita al testo trasformandolo in forma. Si è aggiunto così un altro layer, non solo estetico ma anche di significato: le forme nate dall’interpretazione di Domenico hanno enfatizzato il valore delle parole. Ha dato importanza ai vuoti, agli spazi tra lettere e tra parole. A volte le parole si ripetono, danzano sulla pagina, si ossessionano. Non sono musica, ma diventano rumorose.
GP: Nel contesto della sua ricerca, che si articola tra pratiche performative, dimensione sonora e scrittura, “Noise of Time” sembra configurarsi come un dispositivo transmediale in cui testo, voce e spazio espositivo coesistono in una dimensione esperienziale intima e non replicabile. In che modo la dimensione performativa e musicale ha informato la scrittura e la costruzione dell’opera, e quale valore ha assunto, nel processo curatoriale, l’attivazione di un ascolto individuale e site-specific, quasi in controtendenza rispetto alla smaterializzazione dell’esperienza sonora contemporanea?
VDZ: Lavorando spesso con la musica e la performance, anche la mia scrittura tende ad assorbirne i ritmi, sviluppando una forma che si avvicina alla poesia sonora o alla partitura aperta. È proprio da questa contaminazione organica che è emersa, in maniera del tutto spontanea, l’esigenza di trasformare “Noise of Time” in una serie di tracce sonore. Insieme al musicista Leo, abbiamo sviluppato una sorta di colonna sonora della mostra: brani in forma di demo, ascoltabili esclusivamente nello spazio espositivo attraverso un lettore CD installato a parete. Ho scelto volutamente una modalità di ascolto intima e individuale, in cui ogni fruitore è chiamato a un’interazione diretta e quasi tattile con il suono. Lontano dalle logiche digitali della diffusione continua, questo formato restituisce al pubblico un’esperienza concreta e rallentata, quasi analogica, un tête-à-tête con la voce, la parola e la musica. Alcune tracce si avvicinano alla forma-canzone, altre si strutturano come spoken word, mentre altre ancora sono nate da collaborazioni con altri musicisti. Questa serie di sperimentazioni ha poi generato un’esplorazione più ampia, che si tradurrà prossimamente nella pubblicazione di un disco. In questo modo il testo continua a mutare, attraversando diversi stati materici: da quello visivo a quello sonoro, fino alla dimensione stampata. Mi interessa che le parole non restino fisse, ma si rendano disponibili alla trasformazione, al passaggio da un medium all’altro, come se il senso potesse espandersi attraverso i diversi formati.