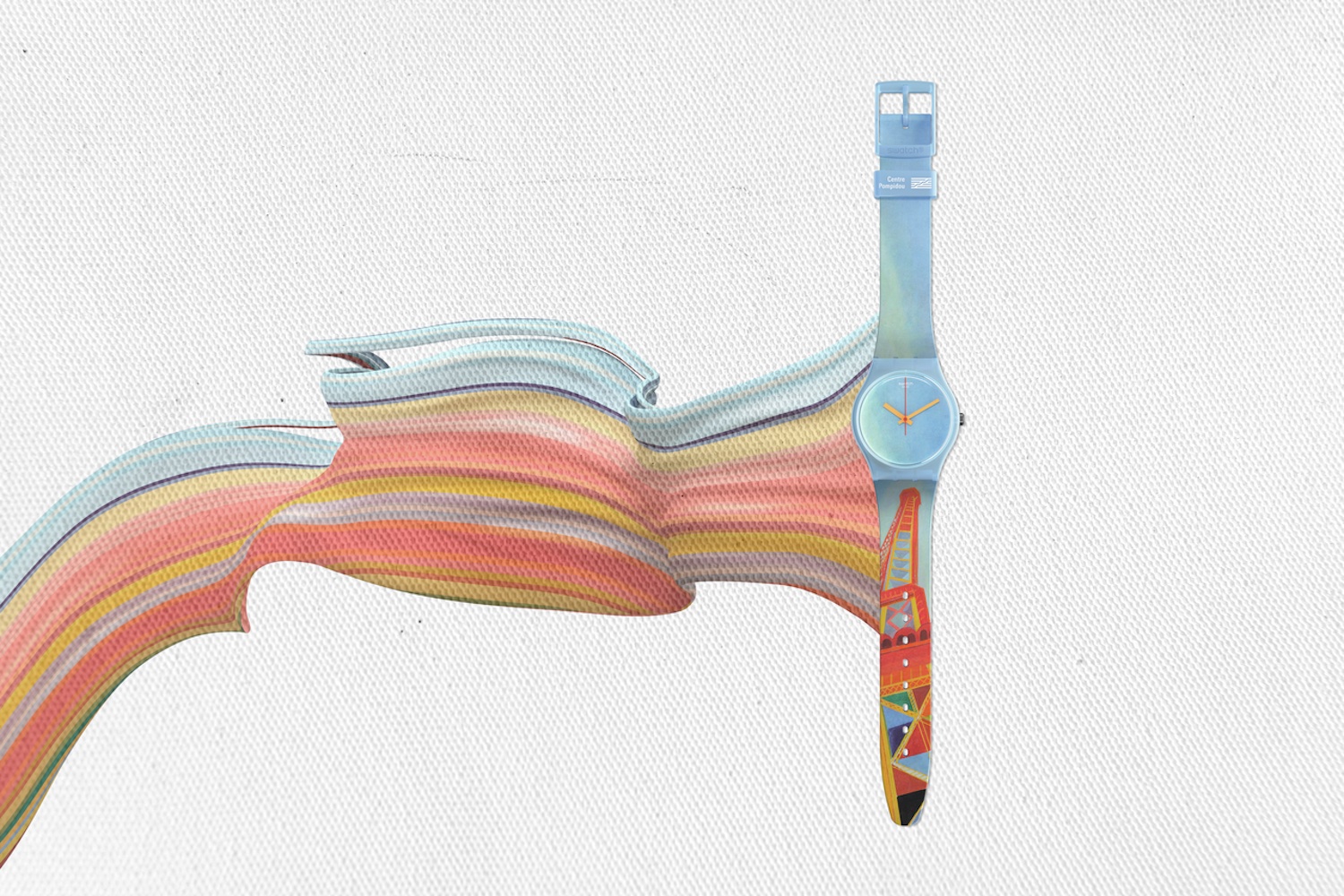Quando Ruth Beraha racconta del proprio percorso, lo fai nei termini di una favola – o forse sono io a comprenderla così. C’è la stessa idea di necessità, di aiutanti che sembrano scendere da un’altra dimensione proprio al momento giusto, il rifiuto del proprio destino che torna comunque immancabilmente a cercarti. Dopo una preparazione incentrata sulle lettere e sulla pittura, studia arti visive e studi curatoriali e contestualmente inizia a lavorare nel mondo della pubblicità. «Mi sono svegliata – dice – cinque anni dopo che ero direttrice di produzione pubblicitaria e il mio corpo mi ha imposto di smettere». Inizia così un percorso di riavvicinamento non solo all’arte – che non se ne era mai andata – ma al sistema che la sostiene, la comunica. Un mondo che, come sa bene che lo abita o cerca di farlo, concede pochi lasciapassare. Non mi interessa, in questa sede, la concatenazione di eventi che porta Ruth Beraha prima tra i padiglioni della Biennale come assistente e poi come artista in residenza per la Fondazione Bevilacqua la Masa, di fatto riaprendo la strada verso il riconoscimento sistemico, ma quanto piuttosto le sue opere si portino dentro di questo percorso: uno sguardo lucido ma mai didascalico (lo definisce sempre sul crinale) sulla violenza sistemica del rapporto tra l’io e l’altro, una coscienza performativa profonda e a volte sprezzante che mantiene in qualche modo la delicatezza del canone pittorico, creando un attrito ironico in cui le cose si dispiegano senza spiegarsi.
Ci incontriamo in una Bologna rovente, sua città di adozione.
Ruth Beraha: Bologna è la città che ho scelto. E, da milanese, questo non significa che odi Milano. Tutt’altro. Ma è una città per un altro momento di vita.
Valentina Avanzini: Per quale vita?
RB: Per me è stata la città della crescita. Dopo il liceo artistico mi sono fermata lì per studiare Storia dell’Arte e intanto imparavo pittura e teoria del colore da un pittore. Un manierista: dipingere era sempre stata la mia ‘cosa’ e avevo bisogno di imparare la tecnica. Dopo la laurea ho fatto il mio unico vero anno di Accademia a Gerusalemme, seguendo le lezioni senza iscrivermi e litigando con la pittura, ma poi sono scappata anche da lì. Sono tornata alla NABA quasi per caso e lavorando nel frattempo nella produzione pubblicitaria, anche per pagare le opere, che erano diventate molto più costose dei quadri di un tempo. Poi l’università è finita e mi sono svegliata cinque anni dopo che ero direttore di produzione e odiavo la mia vita. Mi sono dovuta fermare. Per questo ti dico che fare l’artista è stata una scelta obbligata. Non avrei potuto fare nient’altro, ma, potendo, non l’avrei mai scelto. Il consiglio che do a ogni giovane artista: se puoi, evita. Impara altro. Ho mollato il lavoro a trent’anni e quasi per caso mi sono trovata a fare l’assistente a Giorgio Andreotta Calò alla Biennale di Venezia, dove poi ho conosciuto anche Roberto Cuoghi, che è stato una guida davvero importante. Occuparmi della sua opera al padiglione Italia curato da Cecilia Alemani mi ha permesso di rimanere a Venezia per un annetto e nel frattempo – anche lì, non so bene come – di entrare in residenza a Bevilacqua La Masa.
VA: Venezia, insomma, è stata una tappa fondamentale.
RB: Esatto. Lì ho anche conosciuto Marta, la mia compagna, e a Bologna sono arrivata seguendo lei. Di nuovo per un caso fortuito, nel frattempo ero stata chiamata per la mostra “That’s it”, al MAMbo, per cui Lorenzo Balbi aveva fatto una selezione di artisti nati negli anni Ottanta. Lì esponevo un’opera che aveva bisogno della mia manutenzione: una vasca di piranha che nuotano intorno al calco in argilla di un passamontagna, intitolato Us (Self Portrait) (2018). Non volevo che fosse lo staff del museo a dover immergere le mani e cambiare l’acqua.
VA: Ecco: nel tuo lavoro tornano spesso opere intitolate Self-portrait, ma raramente si tratta di ritratti nel senso tradizionale del termine. Sono oggetti, installazioni, architetture o suoni che sembrano parlare più di relazioni di potere, tensioni e contraddizioni che di un’identità individuale. Forse più di tutti, più ancora dei piranha (e anche prima) penso alle mazze da baseball in vetro che hai realizzato a Bevilacqua, Run Home (self-portrait) (2018).
RB: In generale, ho sempre pensato che quello che esce fuori da me sia, in qualche misura, un autoritratto. Mi rendo conto del rischio di banalità di questa frase, ma è così. Come i pittori che dipingono sempre una sola faccia – la loro. E continuo a parlare di pittura perché rimane quello il mio mezzo privilegiato nonostante, alla fine, sia l’unico che non utilizzo mai davvero e non dipingo più il mio volto – forse anche perché mi sono formata sull’onda lunga del concetto. Nel tempo ho poi smesso di usare il termine autoritratto, ma sono ancora convinta che uno scarto così grande tra cosa si sta oggettivamente guardando e il suo nome dia ancora più forza all’intimità dell’istanza che comunque, in ogni caso, ne comporta la nascita. Le mazze, ad esempio, sono immediatamente riconducibili alla forza, alla violenza, eppure il materiale di cui sono formate obbliga alla fragilità, alla delicatezza.
VA: E questo è evidente. Anche se permane quasi una sensazione di eresia nel nominare qualcosa autoritratto.
RB: Forse, in questo senso, per me è stato fondamentale conoscere Cuoghi, e il suo lavoro che riusciva a parlare in sintesi, ma con forza estrema, di iconografia religiosa, di iconoclastia, di ripetizione e di corruzione. Quindi sì, un’eresia: ma anche una liberazione, non trovi? Come capire che stavo andando verso l’artista e la persona che volevo essere. Non penso che sia un caso che Run Home (self-portrait) sia nato alla fine di quella residenza, come una forma di restituzione di quello che avevo vissuto. Inizialmente avevo pensato a una specie di rage room che ruotava intorno alla distruzione del vetro veneziano. Ma poi ho capito che quella violenza doveva rimanere dentro la forma, come una sorta di frustrazione, una potenza non esaudita. Mi capita spesso di sintetizzare il mio lavoro dicendo che si occupa della fragilità e della violenza di tutte le relazioni. Il modo in cui guardo e quello in cui vengo guardata. L’iconoclastia, la negazione dell’immagine come forma estrema di violenza ma anche come forma di amore più puro.
VA: Mi sembra che questo sia ancora più visibile all’estremo opposto dell’autoritratto, nei tuoi “ritratti corali”: folle tenute insieme non tanto da uno spazio, quanto da una fede, un credo, un sistema di convinzioni. In questo caso, anche nelle tue opere, la violenza non rimane sottesa, ma è ben visibile.
RB: Certo, quello che è visibile a livello del singolo è visibile a livello di massa: la violenza, la fragilità, ma anche gli aspetti positivi, come l’amorevolezza. Quando penso alle masse spesso mi capita di partire dallo sport. Un mondo che frequento da sempre, che è stato molto importante per me e di cui, quindi, conosco anche il lato più oscuro. La dimensione collettiva cambia l’individuo, lo porta a comportarsi diversamente, a recepire l’altro in un modo completamente diverso. Ed è su questa ambiguità che cerco di giocare, è questo il crinale che cerco di non scavallare mai. Questo permette che le possibilità restino aperte, che la narrazione dell’opera continui in chi la osserva, senza che io dia indicazioni precise. è anche un modo di lasciarla andare: l’opera non ti appartiene più completamente.
VA: Questo risuona con l’opera che hai realizzato per “Take Me I’m Yours, Pensiero Stupendo” (2017), in Hangar Bicocca. In una mostra molto caotica, incentrata sulla disseminazione delle opere, il tuo era un lavoro sonoro, che in qualche modo accorpava, creava una comunità diffusa di chi era disposto ad ascoltarlo.
RB: per me quell’opera, in realtà, aveva un risvolto molto violento: nel caos ti obbligava all’ascolto di una registrazione tridimensionale, quindi fatta apposta per confondere i limiti di ciò che stava dentro e fuori di te. Ma è appunto questo quello di cui ti parlavo: so delle reazioni più diverse, chi l’ha avvertita come me, come te, chi si è messo a piangere; è evidentemente un lavoro che funziona, perché funziona al di fuori di me.
VA: Tornando alle masse, invece, e allo sport, mi interessa il modo preciso eppure esteso in cui masse-comunità si ricompongono nelle tue opere intorno a un’identità ma anche a una fede. Penso ad esempio agli stormi di uccelli nella tua ultima mostra presso NContemporary, in dialogo con le masse di volti che disegni a partire da tifosi di calcio e masse trumpiste. Ma anche al tuo lavoro Non sarai mai solo (2019), dove i cori da stadio vengono riletti in un’ottica fortemente emotiva, quasi poetica.
RB: Esatto. Anche Non sarai mai solo parla di un’ambiguità nella dimensione della fede, di una collettività violenta come solo la dimensione plurale può essere. I cori da stadio del Livorno presi integralmente e cantati da un coro nel contesto di una chiesa. La figura dell’ultrà, in particolare, mi attira, perché è una componente reietta della società, al limite del criminale, ma allo stesso tempo è estremamente trasversale. Ultrà possono essere tutti: classe operaia, medici, chiunque, le persone più a modo nella vita di tutti i giorni. Trasportare la stessa narrazione in un altro contesto, sentire chi non salta è pisano cantato da un coro in doppio petto stranisce e in qualche modo potenzia la violenza del racconto, qualcosa che risuona con i discorsi distopici che in questo momento storico ci accompagnano ovunque, come se fossimo in un film di fantascienza.
VA: Questo senso di scavallamento della realtà mi sembra ancora più evidente quando le folle che rappresenti non sono umane. Penso ai piranha placidamente immersi in quello che sembra essere un relitto sommerso, o ancora agli uccelli di ceramica di “Fortune’s always hiding, I’ve looked everywhere” (2024). Un’opera, questa, che ho sempre interpretato come uno schianto, come una fine, mentre tu descrivi come un “guardare oltre” i limiti materiali delle pareti in cui sono esposti.
RB: Certo, sicuramente esiste un elemento distopico, e anche molto violento. Il fatto, come dicevo, è che non ho una risposta definitiva. Non una posizione netta e non la voglio avere. Il punto di interesse, quello che mi permette di continuare la mia indagine e di farmi domande, è proprio questo. Voglio restare sul crinale, lì dove non c’è possibilità di continuare ad aprire porte, di continuare a interrogarsi. Nel caso degli uccelli sicuramente il punto di partenza è il congelamento di questo attimo di schianto, ma per me aveva molto a che fare con lo sguardo, di poter guardare oltre la dimensione fisica, con un occhio non umano e in qualche modo visionario.
VA: Questa attenzione allo sguardo torna in altre tue opere, come la serie di occhi in ceramica Visionarie (2021).
RB: Anche in questo caso, quello che mi interessava era la creazione di uno sguardo senza che l’immagine generata fosse inaccessibile. Una forma di iconoclastia. Ma anche qualcosa di simile al concetto che sta alla base degli uccellini: lo sguardo al di là, l’immagine che non potrai mai controllare.
VA: Mi risuona molto con il racconto che Berger – un grandissimo studioso dello sguardo – fa della capacità dei cani di vedere oltre gli ordini del reale che vediamo noi, in Perché guardiamo gli animali.
RB: Ma certo. In generale, ho sempre avuto una grande fascinazione e un grande amore per gli animali. Hanno sempre accompagnato il mio lavoro, anche solo come metafore. Una delle opere a cui sono più affezionata, anche se spesso non viene considerata, è Goodfellas (2019), una serie di poster che ritrae gli animali che famosamente hanno accompagnato figure di grande potere. Una fotografia della cuteness utilizzata come arma politica di costruzione dell’immagine. È come se parlare di animali, o meglio con gli animali, fosse più sintetico, più diretto. È così anche per gli uccelli, sia quelli in ceramica che i disegni esposti da NContemporary: erano disegni che non avrei potuto non fare, capisci? Forse perché sono tra gli animali che più strettamente convivono anche nella mia quotidianità: per lo più invisibili, popolano gli alberi intorno alla casa dove vivo, sono un’esistenza altra, vera, sempre presente.
VA: Un’esistenza vera e altra, certo, ma anche un simbolo fortissimo che attraversa tutta la storia dell’arte.
RB: Certo. Non avendo fatto un accademia vera e propria, tutta l’iconografia classica italiana è stata una fonte inesauribile per me, dalle chiese alle strutture di potere: l’uccello ad esempio, è l’aquila dell’imperialismo ma è anche lo spirito santo. Un simbolo magnifico.
VA: Sì, ma c’è anche una certa violenza nei simboli, no? Nell’astrazione, in generale: è sempre un togliere qualcosa.
RB: È vero. Con questa violenza ho cercato di confrontarmi: i piranha, ad esempio, non li ho mai più esposti, anche se mi sono stati chiesti. Ho capito che non era quello che mi interessava. Parlare attraverso gli animali e le loro forme, però, mi permette di saltare un passaggio. Il rapporto è forzatamente impari. In qualche modo stiamo già sempre parlando di violenza, di paura, anche se magari questi elementi non sono espliciti. C’è una relazione sbilanciata, ancestrale, ecologica, metaforica – anche nel fatto che li rendiamo simbolo. Gli uccelli, ad esempio, mi permettono di parlare delle folle come stormi. Ma questi uccelli di ceramica che attraversano i muri, se tu li guardi come singolo oggetto sono innocui, teneri, puoi tenerli in una mano: c’è una ambiguità potentissima, che poi è tutto ciò di cui voglio parlare.