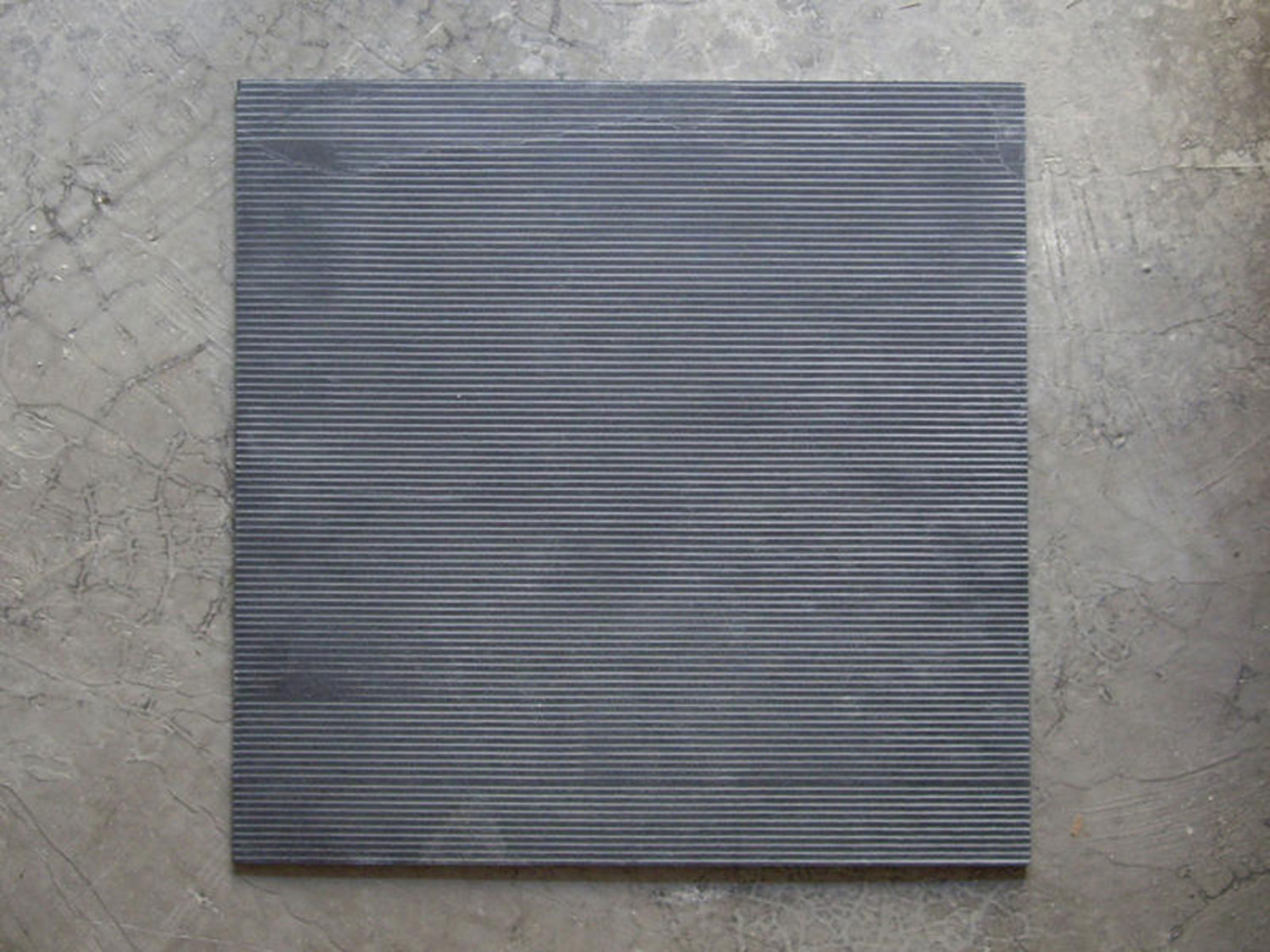“Abstract America: New Painting and Sculpture”, la grande rassegna allestita nella nuova sede della Saatchi Gallery a Londra, include oltre cento opere di trentatrè artisti, quasi tutti attivi tra New York e Los Angeles.
Gli aggettivi “astratto” e “nuovo” del titolo sono stati motivo di polemiche da parte della stampa inglese, che sostiene non si tratti affatto di una mostra di opere astratte, per la presenza di elementi figurativi in molti lavori, né tantomeno nuova, perché alcuni degli artisti partecipanti hanno già esposto in personali o collettive organizzate da Charles Saatchi, come per esempio “USA Today”, presentata alla Royal Academy nel 2006. Tutto vero. Ma qual è il parametro per giudicare il grado di novità di un artista? Nelle mostre di Saatchi l’aggettivo nuovo è una costante, un marchio, svuotato ormai di significato. Ricordo nei primi anni Novanta la mostra sull’arte tedesca, “New German Art”, che comprendeva i lavori Abstract America Stella Santacatterina di artisti già ampiamente conosciuti in Europa. A Londra, effettivamente, non erano mai arrivati, per lo meno non in uno spazio pubblico. Si tratta perciò di un falso problema, una questione marginale e sviante.
L’allestimento, che si sviluppa nelle tredici sale della galleria, costituisce un’ottima lezione installativa, dove emergono divergenze e affinità che creano un insieme dialettico e articolato. Queste caratteristiche ci inducono a riflettere sul fatto che uno degli obiettivi di “Abstract America” sia proprio quello di proporre uno spaccato di un particolare aspetto dell’arte americana di oggi. Risulta evidente, infatti, che la rassegna non vuole proporre il “nuovo”, bensì creare occasioni di riflessione su una situazione che è già presente nel circuito internazionale del sistema dell’arte.

Tecnica mista, 300 x 180 x 80 cm. Courtesy Saatchi Gallery, Londra.
Circa la dicotomia tra figurazione e astrazione, bisogna ricordare che il termine astrazione non è una tendenza, bensì un’interpretazione del mondo (topologicamente diversa dalla figuralità), e di per sè richiama alla mente un capitolo della storia dell’arte, esattamente quello che Kandinsky, Balla, Malevich e Mondrian hanno caratterizzato in senso rivoluzionario dalla prima metà del secolo scorso. E poi c’è la New York School, grande stagione artistica e luogo di sintesi tra l’automatismo surrealista del segno e il repertorio formale dell’espressionismo. L’astrattismo americano degli anni Cinquanta, unito all’influenza dell’era digitale, sembrerebbe essere l’elemento comune di questo gruppo di artisti. E l’affermazione fatta da Peter Halley diventa in questa occasione tangibile: “Sul finire del Ventesimo secolo la realtà diventa sempre più astratta, dunque la pittura astratta è divenuta una figurazione del reale”. Tuttavia, la parola “astratta” è qui accostata ad “America” e perciò più propriamente la mostra avrebbe potuto chiamarsi: “La pittura e la scultura dell’ultimo decennio in un’America sempre più astratta”. Questa è la prima riflessione che ho fatto visitandola.
Man mano che si attraversano le sale si vive un’atmosfera di transitorietà, di déjà-vu, che supera la leggera vivacità, l’allegro divertimento e l’ironia che pure alcune delle opere suscitano. Saltano agli occhi una disinibita libertà e un indiscriminato eclettismo. Si delineano un panorama e un sistema di varianti che rimandano all’arte americana ed europea degli anni Ottanta e Novanta: Neo-Geo, Neosurrealismo, Neoastrattismo, Neoespressionismo, Neo-pop, Underground Art e Graffitismo. L’impressione dominante è quella di trovarsi di fronte a delle opere dove il problema dell’artista è stato, di volta in volta, quello di scegliere dove collocarsi e cosa segnalare nella mischia, se una forma minimal, Pop, Op, o altro. Un’ulteriore astrazione dalla realtà e dell’arte da sè stessa potrebbe essere una chiave di lettura e di analisi di molte opere in mostra.
Il gesto automatico surrealista rivisitato da Jasper Johns e Robert Rauschenberg (la collaborazione dei due artisti che passavano con l’automobile su grandi fogli di carta) e la definizione di Harold Rosenberg: “La tela diventa un’arena su cui agire piuttosto che rappresentare”, sono lo spunto delle pitture performative di Aaron Young. In Greeting Card, titolo mutuato da un’opera di Jackson Pollock del 1944, Young stende dei colori fluorescenti (giallo, verde, rosso e arancione) su pannelli di compensato di grandi dimensioni. Dopo essere stati ricoperti con uno strato di vernice nera, i pannelli diventano la pista di un gruppo di motociclisti professionisti. Il risultato è una pittura vivace e piacevole alla sguardo, un groviglio di linee che non ci fa pensare tanto agli innumerevoli stimoli visuali e artistici di una metropoli, quanto piuttosto alle infinite combinazioni della computer graphics. I pannelli di compensato non recano nessuna traccia del furore messo in atto dall’evento performativo. Potremmo non sapere nulla se non fosse per il video che documenta la performance.
Anche le sculture di Agathe Snow sono il risultato finale di una performance: l’artista installa nello spazio della mostra tre crocifissi, o meglio spaventapasseri. La figura sulla croce è formata dai più svariati materiali: palloni, stoffe e spazzatura. Nelle superfici realizzate da Mark Grotjahn troviamo, invece, alcuni riferimenti alla Op Art, che in Untitled (Face), per esempio, vengono proposti in chiave ritualistica e totemica, con una fitta trama di segni su cartone e tela. Sempre sulla linea della Op Art si collocano anche i lavori di Bart Exposito, dove troviamo il ritmico sistema di produzione, assemblaggio e trasformazione dell’immagine. Francesca DiMattio, forse l’artista più giovane della mostra (e della collezione Saatchi), con un dipinto della lughezza di dieci metri, ripercorre vari stili pittorici e architettonici del passato. In Broken Arch usa l’architettura come oggetto e mezzo per ristrutturare il suo concetto di spazio. Decisamente divertenti sono le due opere di Matt Johnson: The Pianist (2005) (omaggio a Robert J. Lang) e Malus, Sieversii (2008). La prima, un origami a grandezza naturale, rappresenta la figura di un pianista nell’atto di suonare il suo pianoforte a coda. Quest’opera, costituita da un unico telo cerato di colore blu, firmato International Blue Klein, vorrebbe essere un riferimento all’arte di Klein, invece l’immagine della scultura stessa, nella sua patetica e ironica monumentalità, richiama la pittura di Mark Kostabi. Il secondo lavoro è invece un torsolo di mela verde scolpito in legno di acero. Se a un primo sguardo sembra di essere davanti a una mela mangiucchiata, avvicinandosi e girando attorno alla teca di vetro che la racchiude, si notano delle minuscole scale escheriane cesellate attorno al frutto di legno. Forse un rimando alle architetture verticali della Grande Mela?

La composizione dei dipinti di Chris Martin si ispira a quella di Ross Blechner, ma è più materica e i colori sono quelli brillanti della Pop Art. In Mother Popcorn (2006-2007), un collage e olio su tela che deriva il titolo da un brano della star della musica funk e soul, James Brown, sono stati incollati, tra gli altri inserimenti materici, alcuni vinili del musicista. Anche Jonas Wood guarda alla Pop Art, e al cubismo, per realizzare i suoi paessaggi della periferia urbana, riferendosi principalmente a Edward Hopper. Alla fonte futurista attingono due opere di Kristin Baker: Ride the Lightning (2003) e The Raft of Perseus (2006), due grandi lavori in acrilico su PVC, che si rifanno da una parte all’immaginario della Formula Uno, dall’altra a quello della mitologia della Grecia classica, attraverso l’utilizzo di colori aggressivamente vivaci, tipici dell’immagine pubblicitaria. Emerge una superficie animata al tempo stesso da movimenti implosivi ed esplosivi.
In mostra anche l’installazione-scultura Nine (2007), del duo cubano composto da Guerra De la Paz e Nevaldo De la Paz, i quali lavorano con materiali di scarto recuperati dal quotidiano e dai mercatini dell’usato di Little Haiti, a Miami. Un’accumulo di vestiti d’ogni sorta, dal quale spuntano solo le gambe e le scarpe di nove fantomatici personaggi che reggono l’intero fardello, come a simboleggiare la forza e il valore della comunità. Esemplare, delicato e minimal è il lavoro di Gedi Sibony. Untitled (2009) è un grande foglio di plastica da imballaggio, attaccato al muro con nastro adesivo marrone al posto di un presunto quadro.
Sempre sul filone minimal, Stephen G. Rhodes, con il suo Ssspecific Object (2006), motteggiando l’omonimo saggio di Donald Judd, ci propone una scultura di gomma scherzosa quanto kitsch, in cui sembra che un serpente nero e verde abbia ingoiato uno dei parallelepipedi Di Judd. Untitled (The Spiral Staircase) (2007) di Peter Coffin è una brillante reinterpretazione della scala infinita di Escher. Si tratta di una grande scala che, ripetendosi su sè stessa, forma un’imponente struttura circolare installata a parete. La scultura, suggerendo un movimento circolare e infinito, ha un forte impatto visivo e concettuale e chiarisce il significato del termine “astrazione” nell’arte americana: perdita della funzionalità dell’oggetto e distorsione dell’immagine. Spiral Staircase potrebbe essere una metafora della mostra che, girando su se stessa, diventa semplicemente astratta.