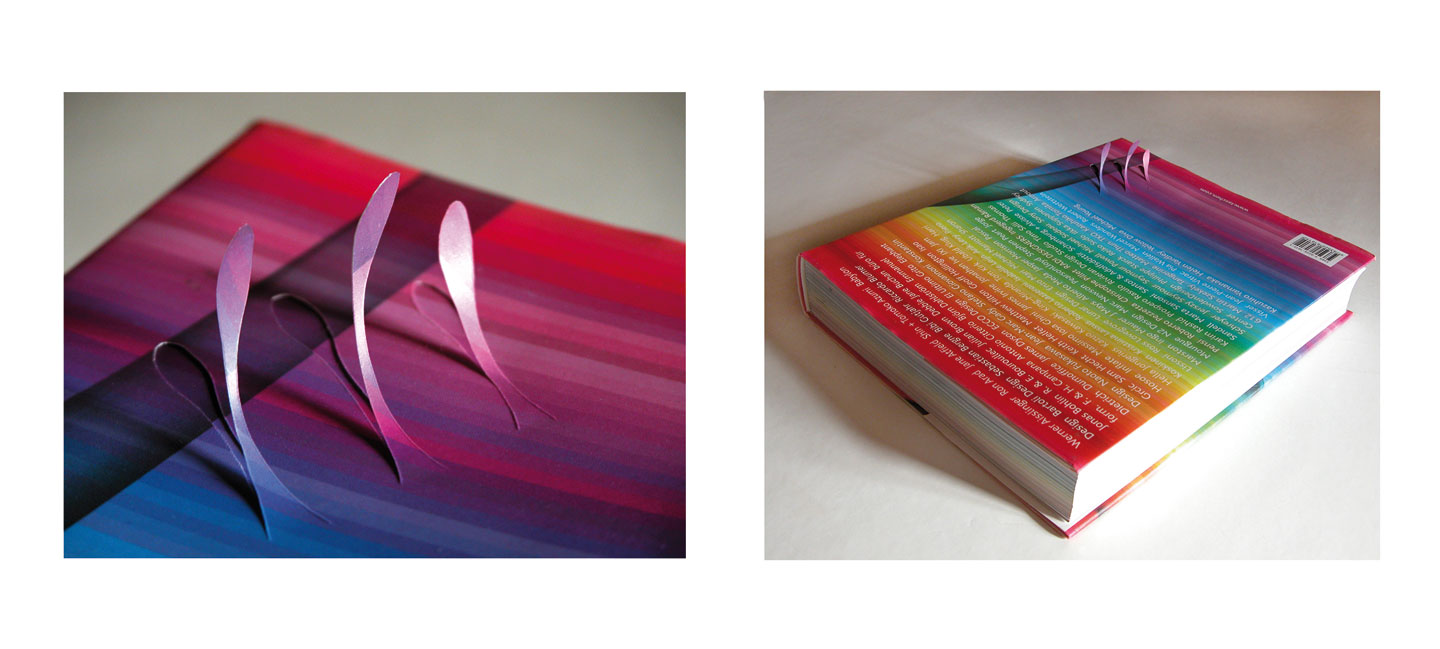Jade Niklai: La tua arte mi ricorda l’antica arte della narrazione. Fatto e finzione sono consistentemente inframmezzati con il significato e l’interpretazione, e le opere spesso fanno riferimento a testi che le accompagnano. La narrazione è una pratica culturale tipicamente cubana, oppure si tratta di un approccio personale?
Diango Hernandez: Specialmente quando preparo mostre personali, le storie brevi, che sono per lo più connesse a temi autobiografici, diventano rilevanti all’interno del mio lavoro. Elaborare fatti che appartengono a esperienze personali e mescolarli a elementi di finzione mi permette successivamente di creare “stanze” e oggetti che sono connessi tra di loro in una sorta di narrazione, che può condurre sia me che lo spettatore verso una specifica drammaturgia. Non direi che la narrazione è un approccio particolarmente cubano, ma è qualcosa che viene dalla mia passione per la letteratura piuttosto che da un particolare background culturale.
JN: Il tuo lavoro è interpretato dai più come una riflessione sulla memoria personale e sulla storia collettiva della vita cubana durante gli anni Ottanta e Novanta. Hai vissuto all’estero per più di otto anni — prima in Italia e in Spagna e dal 2003 a Düsseldorf — e il tuo lavoro ti porta in giro per il mondo regolarmente. In che modo queste esperienze influenzano la tua pratica artistica?
DH: Alla fine degli anni Novanta, un amico artista con più esperienza di me mi fece due domande: “Puoi immaginare di vivere all’estero?” e “Riesci a immaginare quanto questo influenzerebbe il tuo lavoro?”. Queste domande erano spesso argomento di discussione tra gli artisti cubani. Nessuno in realtà sapeva all’epoca cosa dire effettivamente su questa questione. Eppure c’era una paura diffusa, una volta trasferito all’estero, di perdere le tue “radici culturali” e i tuoi riferimenti.

JN: In passato hai parlato dell’importanza dell’“omissione” piuttosto che dell’“addizione” all’interno del tuo lavoro.
DH: In generale, considero l’omissione più importante dell’addizione, in particolare quando si viene a definire un pezzo o uno spazio con il quale sto lavorando. Tuttavia, questo è più forte in alcuni progetti piuttosto che in altri. L’omissione per me è legata al silenzio, l’addizione al rumore. In molti casi, mi piace mantenere la tranquillità e portare nello spazio più silenzio che rumore. Il silenzio è una cosa molto potente quando è usato nella giusta maniera. Quando il silenzio diventa un materiale forte e fisico come il marmo, è in grado di divertire e sfidarci in un modo molto speciale.
JN: Il tuo lavoro prende sempre in considerazione il contesto espositivo. Questo soprattutto per quanto riguarda le installazioni. Lavori esclusivamente su commissione oppure i tuoi lavori prendono vita all’interno del proprio spazio e tempo?
DH: Io lavoro in modi diversi, e questi cambiano spesso a seconda del modo in cui la mostra è stata progettata e organizzata. Idealmente mi piace lavorare nel mio studio e preparare tutto ciò che riesco da solo. Questo non è sempre possibile, specialmente con le installazioni, che sono fortemente condizionate dalla logistica, dal budget, ecc. In questi casi, lavoro in situ e poi il prodotto è il risultato di molti “incidenti”. A volte sono a mio agio a fare così, altre volte è terribilmente stressante. Tuttavia è difficile dire quando un’opera deve avere il proprio spazio e tempo, perché sono convinto che ciò che proviene dal mio studio è un’opera d’arte; tutto il resto appartiene al processo.

JN: Il tuo modo di lavorare è al contempo vecchia scuola e contemporaneità: cerchi oggetti al mercatino delle pulci o su eBay, sei avvezzo all’installazione ma ritieni il disegno fondamentale al tuo pensiero e al tuo lavoro. In che modo intendi sposare questi approcci differenti? Capita che uno abbia la meglio sull’altro?
DH: Penso che il disegno sia una delle cose più belle che tutti noi possiamo fare. Tutta la realtà che esiste ogni giorno di fronte ai nostri occhi può sfidare la fisica, la logica. In questo senso, disegno, pittura e installazione sono tutte la stessa cosa per me; sono tutti elementi del “grande disegno” che voglio disegnare attraverso il mio lavoro. Un disegno in cui tempi-spazi-storie-geografie-ideologie-sogni-impossibili sono tutti insieme, a volte sotto forma di linee di inchiostro, e a volte come una sedia di legno incompleta.
JN: Molta della tua arte è non-figurativa, è ampiamente “umana” nei toni e nelle apparenze. Molte delle tue installazioni si riflettono sulle vite che abitavano una volta gli oggetti.
DH: I valori con cui sono cresciuto erano tutti basati sulla convinzione che gli uomini sono al centro di tutto. Non c’è niente di più importante per me degli uomini. Come sai, crescere in un Paese socialista implica l’assenza della religione, per questo io appartengo a una generazione che non è mai entrata in una chiesa a Cuba prima dell’età adulta. Né i miei amici né io abbiamo praticato alcuna forma di religione. Anche ora, quando chiedo che tipo di ruolo gli uomini giocano in una società socialista, penso ancora che tutto quello che noi stiamo facendo come società è migliorare il benessere dell’umanità.

JN: Hai parlato dell’importante distinzione tra la “casa” e lo “studio”; nello specifico, quanto privato e intimo quest’ultimo sia per te. Pensi sia così a causa o nonostante i tuoi anni di viaggio?
DH: Ho concepito lo studio come spazio privato. Voglio mantenere questo spazio più “puro” possibile. Voglio tenerlo lontano dalle influenze delle persone che possono contaminare il mio pensiero con i loro desideri e le loro opinioni transitorie. Credo che oggigiorno l’artista abbia bisogno di proteggere il suo ambiente di lavoro; ci sono molti modi di comunicare quello che facciamo senza la necessità di aprire le porte dello studio a estranei. Ho bisogno di lavorare in una situazione molto isolata, e lo studio è l’unico posto che mi offre il modo di stare all’interno del mio mondo e non in una particolare città o paese. Viaggiare mi annoia. Preferisco stare a casa, anche se so che viaggiare è estremamente importante e infatti viaggio molto. Ma questo non è il motivo per cui tengo il mio studio fuori dai “pacchetti divertimento”. A volte colleziono arte, e in collezione ho alcune fotografie di studi di artista dei primi anni del Novecento. Questi spazi sono pieni di mistero.
JN: La tua attività artistica è cominciata in un collettivo cubano chiamato Ordo Amoris Cabinet e di volta in volta hai lavorato con artisti come Anne Pohlamann; hai anche collaborato con Mouse on Mars (Sun State). Collaborare è un’impresa arricchente ma potenzialmente difficile. Ti sei trovato nella posizione di “direttore” in queste circostanze, oppure hai dato piena libertà artistica ai tuoi partner creativi?
DH: Ho giocato ruoli differenti in ognuna di queste collaborazioni. A volte sei l’unico a parlare e altre volte stai solo ad ascoltare. Ho imparato che collaborare significa dare una parte di te. Lavorando insieme, i ruoli sono strettamente definiti all’interno dei perimetri della collaborazione. Ecco perché preferisco pensare a una collaborazione intellettuale come a un modello basato sul dialogo, piuttosto che a un prodotto. La produzione solitamente porta i vecchi dilemmi in prima linea: questo è un modello che può distruggere il rapporto tra colui che pensa e colui che produce l’oggetto. Non sono un direttore. Amo la libertà, e nonostante la necessità di controllo, in una reale collaborazione intellettuale, se tu hai bisogno di un direttore allora la collaborazione è già morta.