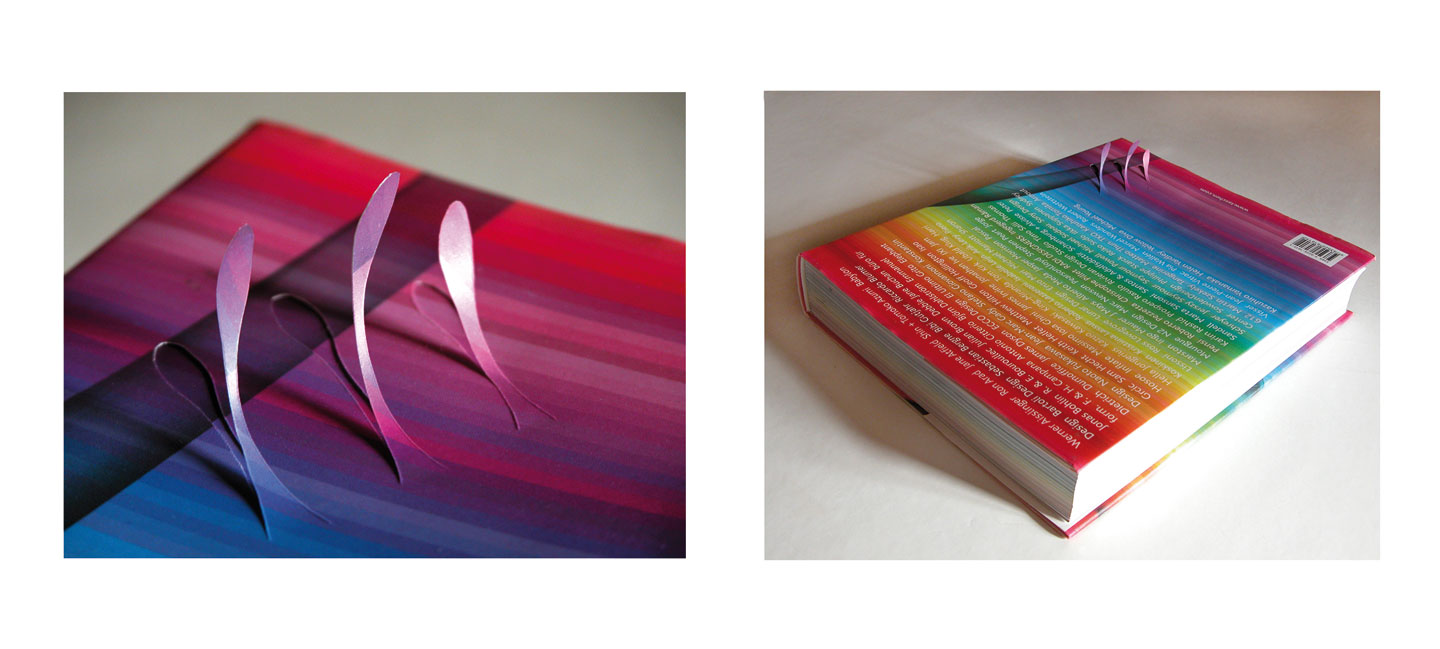Pubblicato originariamente in Flash Art Italia no. 304 Luglio – Settembre 2012.

Maurizio Cattelan: Stiamo facendo questa cosa in occasione della tua mostra a New York. Mi rendo conto che l’ultima volta che hai avuto una mostra qui è stato nel 1969. Ti piace l’America?
Domenico Gnoli: Amo l’America. Ho anche vissuto qui, ma i miei legami sono esclusivamente italiani.
MC: Ti riferisci al background che caratterizza il tuo lavoro?
DG: Sì.
MC: Sei nato a Roma. Questo significa che i tuoi dipinti sono ancora “romani” rispetto allo status internazionale che hanno acquisito?
DG: Be’, proprio come me, sono romani per natura, non per vocazione. Una sorta di inventario della Roma in cui sono cresciuto, possibilmente più una Roma che ricordo che una Roma che conosco. Un repertorio di ombrelli, sedie, ceste, tavolini dei bar sui marciapiedi, pesce e verdure esposti nell’ombrosa intimità di piccoli mercati, le solenni e scure lavanderie — tutto ciò, in poche parole, che passa sull’acciottolato delle strette, imprevedibili strade della vecchia Roma. E l’odore, il rumore, e poi infine la notte… le bottiglierie vuote, le “osterie” con le cianfrusaglie e gli avanzi di incontri informali, alcune pronte a chiudere, con le sedie messe sui tavoli in modo che il pavimento possa essere pulito, solo un tavolo ancora apparecchiato con le sedie intorno per la cena dei camerieri stanchi… e poi il rumore cessa, ma le voci continuano — le ironiche sagge voci dei romani, le voci sagge di una saggia città.
MC: Come è stata la tua infanzia a Roma?
DG: Non c’è molto da dire sulla mia infanzia. Ricordo esplosioni di intensa felicità, seguite subito dopo da una profonda melanconia che dava vita a riflessioni e commenti da parte di coloro che mi erano intorno su come la mia vita fosse lontana dalla mia età. Da allora, ho sempre vissuto senza età, dato che ogni anno la ripudiavo, scegliendone un’altra per la sola buona ragione che mi piaceva di più.

MC: Fantastico. Quindi cambiavi la tua età ogni anno?
DG: Sì. Perché no? La vita può essere considerata un immenso guardaroba, con tante tessere del domino appese nei suoi anfratti, una tessera per anno. Ora non vedo perché non potrei cambiare la mia maschera in questo guardaroba almeno due volte al giorno.
MC: Come hai cominciato a dipingere?
DG: Bene, sono nato sapendo che dovevo essere un pittore perché mio padre, uno storico dell’arte, presentava sempre la pittura come l’unica cosa accettabile nella vita.
MC: Se era uno storico dell’arte, sono sicuro si occupava di pittura tradizionale.
DG: Sì, mi ha indirizzato verso la pittura classica italiana, contro la quale presto mi ribellai, ma senza mai perdere il gusto e la maestria del Rinascimento.
MC: Posso dirlo. È veramente interessante perché ho sempre pensato che tu eri in un certo senso nel mezzo, tra la generazione dell’Informale e quella dell’Arte Povera.
DG: Lo so. Per molti anni mi è stato difficile dipingere perché non capivo la pittura informale che all’epoca dominava tirannicamente i pittori e i collezionisti.
MC: Posso capirlo. Il tuo lavoro sembra più in debito con il Surrealismo che con l’arte Informale.
DG: Davvero? Lo ritieni surrealista?
MC: Be’, se pensiamo a Giorgio de Chirico, sì. I tuoi oggetti sono un po’ metafisici, non credi?
DG: Io sono metafisico nella misura in cui sono alla ricerca di una pittura non eloquente, immobile e d’atmosfera, che si nutre di situazioni statiche.
MC: Giusto. Ma non in maniera teatrale.
DG: No, non ho mai provato a recitare, a fabbricare un’immagine. Uso sempre determinati e semplici elementi, non voglio aggiungere o sottrarre nulla. Non ho mai voluto distorcere. Isolo e rappresento. Le mie tematiche derivano da eventi attuali, da situazioni famigliari, dalla vita di tutti i giorni, perché non intervengo mai in maniera attiva nei confronti dell’oggetto, posso sentire la magia della sua presenza.
MC: Hai avuto una parentesi anche come scenografo. Pensi che questo abbia condizionato il tuo modo di dipingere o di percepire gli oggetti comuni?
DG: Non lo so. Ero appassionatamente interessato al teatro e ho realizzato scenografie per Barrault, l’Old Vic, e la Schauspielhaus di Zurigo. A ogni modo, non sarei mai riuscito ad abituarmi alla comunità e alla vita sociale di uno scenografo teatrale.

MC: Sì. La pittura è un’esperienza molto più privata. E non devi preoccuparti del tuo pubblico ogni sera. Be’, in verità tu lo fai, ma in maniera differente.
DG: Un pubblico forse non è necessario alla ricerca della propria anima, ma è vitale per un mago, colui che realizza prodigi. Questo anche perché i prodigi si alimentano di altri prodigi, la fantasia di fantasia. Ritornando al mio lavoro, lasciami affermare che chiamo prodigio tutto ciò che è inventato, tutto ciò che comincia a esistere dal secondo in cui è concepito, è il processo non il risultato, il principio e non i suoi frutti.
MC: Qual è il tuo principio? Perché lo stai facendo?
DG: Perché lo sto facendo? Ma non è questo il punto. Lo sto facendo perché questo è ciò che accade veramente dentro di te. Cominci a guardare le cose e sembrano a posto, normali come sempre, ma poi le osservi un po’ di più e i tuoi sentimenti entrano a farne parte, le cose cominciano a cambiare per te e vanno avanti fino a che non vedi solo i tuoi sentimenti, e questo perché vedi la confusione.
MC: Ma negli anni Sessanta ci fu l’avvento dei new media. Non sei stato tentato di esplorare questi linguaggi in relazione con gli oggetti comuni piuttosto che contare su un medium tradizionale come la pittura?
DG: Oh, so quanto pateticamente inadeguato sia il mio mezzo, ma sfortunatamente non dispongo di altro.
MC: No, no, non volevo dire questo. Quello che stavo cercando di dire era: se tu eri interessato agli oggetti comuni, perché non hai lavorato direttamente con essi piuttosto che provare solo a dipingerli?
DG: Non lo so. Tutto ciò che so è che la mia era una teoria sull’arte completamente nuova, un nuovo approccio che faceva apparire le figure proprio come erano nella realtà. Ma non voglio pensare che credo di essere una specie di genio, niente del genere. L’idea si è generata spontaneamente nell’anticamera della mia coscienza e io devo solo dare la sostanza pittorica. La mia vita mi procura queste immagini che diventano espressioni della mia quotidianità.

MC: Questo è qualcosa che anche gli artisti pop stavano facendo. Ti piace la Pop Art?
DG: Oh, sì. Solo grazie alla Pop Art la mia pittura è divenuta comprensibile.
MC: Da dove credi che venga la passione della Pop Art per gli oggetti comuni?
DG: Posso parlare solo per me, ma secondo la mia opinione l’immaginazione e l’invenzione non possono dare vita a qualcosa di più importante, più bello e più terrificante dell’oggetto comune, amplificato dall’attenzione che noi gli rivolgiamo. Un oggetto solo, di fronte a me solo, esattamente di fronte a me come mi sarebbe piaciuto avere di fronte qualcuno che davvero mi interessa, con una buona luce per osservarlo.
MC: Quindi l’oggetto è ordinario ma non impersonale.
DG: No. Parla di me molto più di ogni altra cosa, mi riempie di paura, disgusto e incanto.
MC: Ti capisco. Mi sento nello stesso modo a proposito della rivista a cui sto lavorando ora, Toilet Paper. Penso che ci sia un sacco di me dentro, ma molte persone la percepiscono solo come un modo furbo per conquistare un pubblico più ampio.
DG: Se un artista ha la possibilità di contattare un pubblico infinitamente più ampio attraverso le pagine di una pubblicazione, dovrebbe cercare di investire di più e andare avanti nel suo sforzo di trasmettere la sua immagine più profonda come può.
MC: Grazie. Questo mi rincuora.
DG: Bene.
MC: C’è qualche domanda alla quale non ho risposto?
DG: Per me di sicuro nessuna.