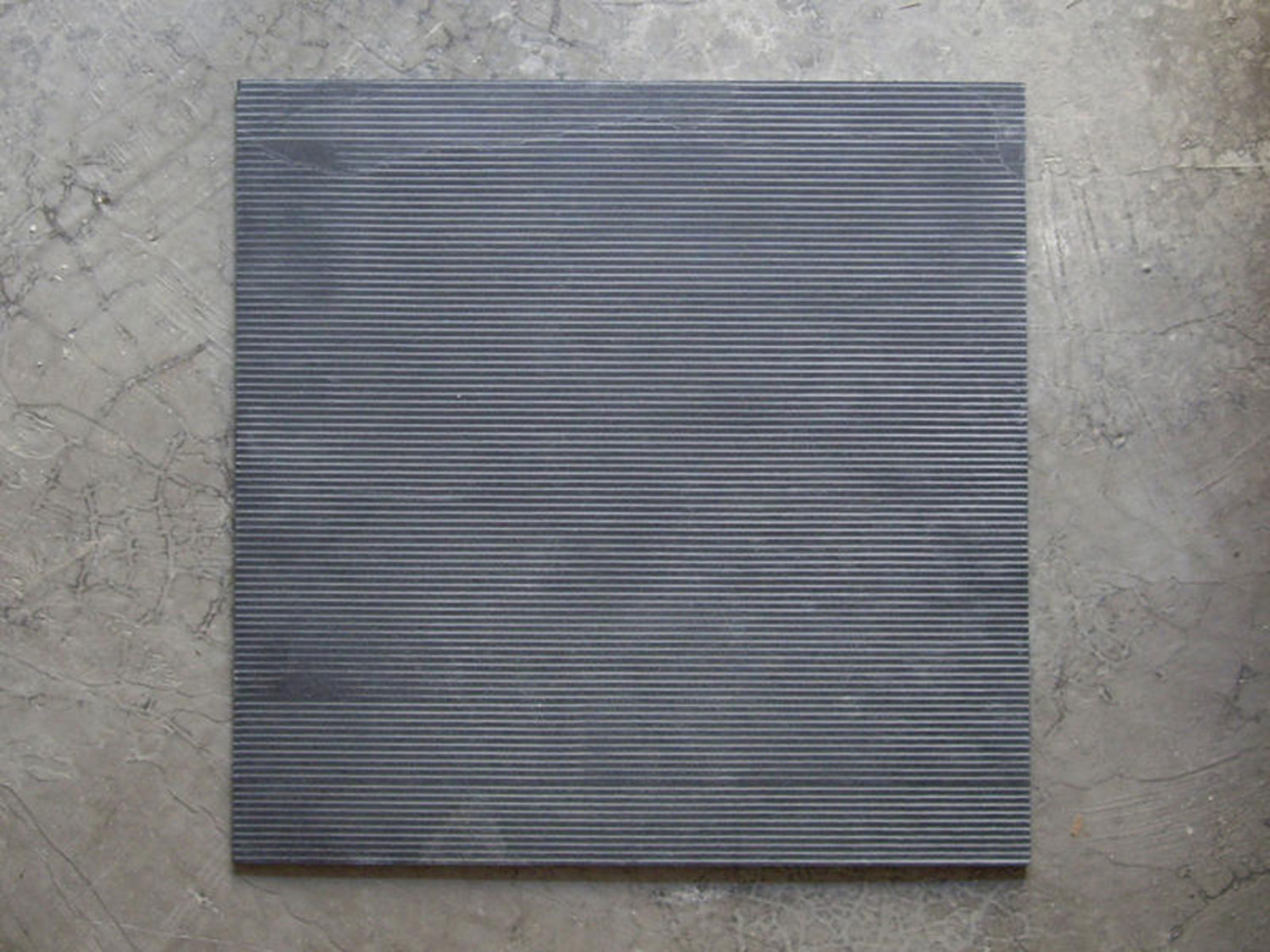Come ha dichiarato l’artista stesso: “In una lotta per defi nire il sentimento e la forma di una modernità futura, la modestia è solo un segno contemporaneo retrospettivo che testimonia l’imperscrutabilità della passata ambizione”. Nella dialettica tra antico, con le sue forme espressive (pittura inclusa), e moderno, con i suoi strumenti mediali (cinema e video), il lavoro di Mark Lewis emerge oggi nel suo incomparabile valore di paradigma. Solo apparentemente Lewis è un artista che lavora con il video. In realtà, la sua è un’opera di rilettura strategica del significato stesso del presente, nel tentativo di interpretarlo fuori dalla costrittiva defi nizione di “contemporaneità”, e assumendosi l’onere di istituire un confronto tra i due poli paradossali del passato (l’antichità come fonte di verità) e del futuro (come orizzonte di speranza). È chiaro che al confronto con questi due invalicabili confini, la condizione umana odierna appare in tutta la sua fragilità, per non dire nel suo aspetto fallimentare: è per questo che nei suoi film Lewis è tanto attratto da rovine moderniste, angoli urbani anonimi, porzioni laterali di centri commerciali, frammenti di non-luoghi, o anche semplicemente parchi, edifici senza nulla di speciale, ma anche da vecchi trucchi cinematografi ci come la retroproiezione, o elementi del linguaggio del cinema ancora in auge come lo zoom, il dettaglio, il carrello laterale, l’inquadratura fissa e via dicendo. Nella “modestia” complessiva delle sue immagini, però, appaiono in evidenza dei dettagli del tutto straordinari, che apparentano i suoi lavori alla grande pittura europea del Settecento e Novecento, da Henry Fantin-Latour a Gustave Caillebotte, fino a Manet. Non si tratta tuttavia di mere assonanze formali: in Lewis la forma è un portato diretto del tempo; è come se la magia delle immagini del passato, per esempio la citazione di Latour nelle fasi finali di North Circular (2000), dove compare una piccola trottola luminosa, non fosse solo nostalgicamente evocata, ma tornasse per qualche istante a rivivere, per poi tornare a inabissarsi di nuovo. Per questo il tempo, la dimensione temporale è tanto importante nei video di Lewis, ma non come, per esempio, in Bill Viola (in cui in genere è il ralenti a costituire l’accorgimento per sollevare strategicamente l’attenzione), quanto piuttosto come calcolatissima durata del pezzo in rapporto alla capacità attentiva dello spettatore.

Marco Senaldi: I titoli dei tuoi lavori di solito contengono esattamente le indicazioni su ciò che effettivamente si vedrà (Zoom, Reverse, Dolly, Pan, Tilt, ecc.). È così anche per il tuo ultimo lavoro Autofocus (2009)? In che senso questi titoli anticipano la fine del pezzo che vedremo, o meglio, tolgono ogni suspense, che invece è un escamotage tipicamente cinematografico?
Mark Lewis: Quando ho realizzato Bricklayers Arms, non ho usato un titolo esplicativo chiaro e semplice come faccio di solito, ho pensato fosse un po’ pedante. Nei miei film odio l’idea di suspense, mentre la tragedia di ogni film è proprio che c’è sempre una fine, un finale, è per questo che non mi piace lavorare con il cinema. Sono ossessionato dall’idea della fine; il problema è che questa idea è onnipresente, fin dall’inizio di un film ce ne si prospetta il finale. Quando ho iniziato a lavorare con il cinema ho sentito questa tragedia, questo problema dell’arte che ha una durata. Non ci penso mai coscientemente mentre lavoro, ma negli ultimi dieci anni ho cercato di indagare questa problematica, specialmente perché mi piace l’idea che le mie opere vengano viste più e più volte, che si possa vederle un po’ e poi andarsene, e tornare ancora due o tre volte finché non è sufficiente. Non voglio che la fi ne sia come prestabilita, non mi piace quando arrivano i titoli di coda ed è tutto finito e si prende un bel respiro profondo.
MS: Molti artisti contemporanei sono stati tentati dalla strada della regia — negli anni Novanta ci si era abituati a questo sconfi namento, a cominciare da Robert Longo, passando per Julian Schnabel, per finire con Cindy Sherman — , un fenomeno che all’inizio fu salutato con favore, ma che ben presto finì per mostrarsi un’arma a doppio taglio, quasi una dimostrazione che gli altri media “artistici” erano una “seconda scelta”; mentre altri artisti, da Bill Viola a Bruce Nauman, hanno accuratamente evitato questa strada…
ML: Non ho mai voluto fare un vero film, non è uno dei miei desideri, la mia arte non è una seconda scelta rispetto al cinema o una scelta differente rispetto alla fotografia. Non penso che i miei film siano dei “corti”, credo che abbiano la giusta durata per quello che devono esprimere. Se volessi, potrei farne di più lunghi, ne ho già realizzato uno di quaranta minuti, Backstory [presentato a Venezia, n.d.r.], ma i film che ho prodotto dovevano avere una determinata lunghezza, consona al luogo in cui andavano mostrati; musei o gallerie non sono posti adatti per la proiezione di fi lm lunghi, non ci sono le condizioni giuste. Negli ultimi anni ho lavorato do molto a Los Angeles con le maggiori case di produzione, e devo ammettere che c’è qualcosa di eccitante in questo modo di lavorare; dal punto di vista produttivo lavoro con delle vere e proprie troupe.

MS: So che all’inizio ti occupavi di fotografia, nella linea della Vancouver School, e che hai sempre unito al lavoro artistico l’impegno teorico, tra cui anche una collaborazione con Laura Mulvey.
ML: Effettivamente ero un fotografo e sono finito per caso a realizzare film. Agli inizi degli anni Novanta mi interessava molto la public art ispirata alla produzione monumentale dell’Unione Sovietica e un giorno, mentre prendevo un drink con Laura Mulvey (grande teorica del cinema e “creatrice” della FFT – Feminist Film Theory), lei mi ha detto, quasi per scherzo: “È interessante quello su cui stai lavorando, dovresti farci un film”. Poi, tornato in Canada, ebbi la fortuna di trovare i finanziamenti e così andammo a girare a Mosca nel 1992, nel periodo tra Gorbaciov e Eltsin, filmando le statue distrutte della rivoluzione e intervistando diverse persone.
MS: Uno dei grandi spartiacque tra videoarte e cinema è probabilmente costituito dal cambiamento di quello che i teorici di cinema defi niscono “dispositivo”, che nel caso del video conduce dritto alla forma videoinstallativa. In fondo, anche artisti interessati fondamentalmente ai contenuti, come Douglas Gordon o Tacita Dean, alla fine tendono sempre a installare i loro lavori secondo la retorica dello site-specifi c; cosa che mi sembra tu non faccia, anzi, il tuo atteggiamento sembra piuttosto quello di mostrare il visibile come una specie di trappola che nasconde la sua verità dietro di sé.
ML: I miei dispositivi espositivi sono sempre molto semplici e di solito non uso schermi multipli. Li ho usati solo per A Sense of the End (1996), opera largamente discussa tra i teorici del cinema; tuttavia, devo ammettere che non mi sento del tutto a mio agio con quell’opera, perché non mi interessano le installazioni, ma le immagini che si muovono. Penso sia una distinzione molto importante. Credo che molti giovani artisti lavorino come me, perché l’installazione è ormai un po’ di maniera. Quando si va in un museo e si vedono delle installazioni video, sembrano tutte uguali, sono una sorta di readymade. Certo, le installazioni sono sempre lì a ricordare che nel cinema c’è un apparato espositivo nascosto e questo è un atteggiamento molto legato all’avanguardia del ready-made. Non mi interessa mostrare l’apparato cinematografi co, anche se ovviamente non si può fare a meno di un proiettore. Per questa stessa ragione non adopero le tipiche “black box” per i miei video, bensì lo spazio. Inoltre, devo anche tenere conto del fatto che in una stanza ci potrebbero essere più proiezioni e per questo generalmente realizzo opere di piccole dimensioni, anzi, ultimamente sempre più piccole vista la crescita dei costi di produzione. In questo senso uso l’architettura come un pittore o un fotografo, perché il punto in comune tra queste attività e il mio lavoro è il creare immagini, rappresentare. È quello che gli artisti hanno sempre fatto: cercare di rappresentare il mondo. Credo sia un desiderio dell’uomo vedere un’immagine e poter dire che, rispetto a quel posto, a quello sguardo, a quella visione, rivela qualcosa di strano o enigmatico, che anche qualcun altro può comprendere. Questo è il motivo per cui si creano immagini, affinché altre persone possano trovarvi una visione, una costellazione di senso. Questo è il motivo per cui, anche dopo un secolo di iconoclastia, si fanno ancora immagini, in un modo o nell’altro. Io, per esempio, creo immagini ordinarie, quasi sempre modeste, e farei film con qualsiasi soggetto: paesaggi, oggetti, ritratti, sono tutte possibilità per il mio lavoro.

Galerie Serge le Borgne, Parigi. © Mark Lewis Studio.
MS: Ho letto una volta una conversazione con Jeff Wall a proposito del cinema, in cui a un certo punto afferma che non ne può più di andare al cinema e di restarsene seduto due ore davanti a delle immagini che passano su un telone bianco — una specie di smagamento post-postmoderno della vecchia “suspension of disbelief”, come la chiamano gli americani, ossia della voglia di “crederci”… Anche per te il cinema ha esaurito la sua funzione storica, oppure può dire ancora qualcosa agli artisti? E se sì, che cosa?
ML: Penso che uno dei problemi di ciò che chiamiamo simulacri cinematografici, della forma dominante di cui abbiamo parlato in cui l’arte ha approcciato il video e la tradizione cinematografica, stia nel rivelare al pubblico la relazione critica nei confronti del cinematografico, come fanno il cinema ironico o quello citazionista. Ma questo non è il mio obiettivo. A una conferenza agli inizi degli anni Novanta, quando l’arte iniziava a usare massicciamente il cinema, Raymond Bellour mi disse una cosa che non posso dimenticare. Lui era molto scettico verso quella tendenza, perché veniva dalla critica cinematografica, e disse che il cinema già di per sé è un’installazione di successo, una sorta di installazione esemplare che ha avuto la sua forma perfetta nei trent’anni intercorsi tra l’invenzione del sonoro e l’avvento della televisione. E noi di questa forma di installazione sappiamo perfettamente tutto e possiamo solo spiegare all’infinito perché è perfetta, senza esaurirne la perfezione. Così, l’idea di rimettere in mostra continuamente questa forma nelle gallerie e nei musei era per lui, in un certo senso, ridondante. Per me, in effetti, tutte le varianti installative messe in pratica dai filmmaker e dai videomaker sono solo la mimesi della forma, dei motivi e dell’organizzazione della pittura. La cosa più importante è che i miei film siano film e non cerco di pretendere che non lo siano. Certo, il tema dell’avanguardia è stato proprio quello dello straordinario, ossia mostrare che le cose non sono quello che sembrano. È stato un momento storico molto importante per tutti noi, ma ciò non ha distrutto le immagini, non le ha rese impossibili, anzi ha spronato tutti a fare meglio, in una sorta di contraddizione con l’assunto dell’avanguardia stessa. Molti artisti seguono ancora quella tradizione perché sono interessati all’impossibilità, come tema filosofico, e anche se l’idea della distruzione dell’immagine non esiste più veramente, il gesto di quella tradizione è ancora una possibilità artistica perseguibile.
MS: In che senso riesci a collegare la tua attività artistica con il tuo impegno teoretico [Lewis codirige con Charles Esche la collana di teoria dell’arte Afterall, distribuita da MIT Press, n.d.r.], e che senso ha questa voglia di teorizzare che ricorda la posizione modernista, quando gli artisti si impegnavano con manifesti, dichiarazioni, prese di posizione?
ML: Non so se i miei film stiano dopo la fine della teoria dell’arte o dopo la fine del cinema, ma più mi immergo nella loro realizzazione meno mi interessa teorizzarci sopra. C’è chi dice che l’arte contemporanea è il modo di fare filosofia nel Ventesimo secolo, ma tutto ciò non mi appartiene. Penso che l’arte sia una filosofi a debole e che sia importante ridurre alla forma base, materiale, ciò che si fa.
MS: Osservando i tuoi lavori, che giustamente definisci film, dato che sono girati sempre in 35mm e solo in un secondo tempo riversati su DVD, si percepisce che l’impegno va a insistere sui limiti — sia su quelli della percezione, da parte dello spettatore, sia su quelli della produzione di una determinata immagine, da parte del regista-creatore — anziché sul medium come tale… In Two Impossible Films [due fi lm basati su due progetti “impossibili”: il primo sull’idea di Ejzenštejn di fare un film usando come sceneggiatura Il Capitale di Marx, il secondo sull’idea del produttore hollywoodiano Florenz Ziegfeld di scritturare Freud per sceneggiare un film d’amore, n.d.r.] addirittura il film come tale non esiste più — la tua “realizzazione” dell’impossibile sconfina in una sorta di esercizio di decostruzione filosofica del cinema come tale.
ML: In un film ci sono poche possibilità e a me non interessa quello che si può dire, ma quello che affiora da queste poche possibilità. Così, quando si riduce un film ai suoi elementi costitutivi, alla sua struttura fondamentale, se emerge qualcosa di filosofico, non dipende da un’idea, ma da quello che l’opera stessa produce. È la produzione che genera l’idea ed è la forma stessa che può rivelare qualcosa.