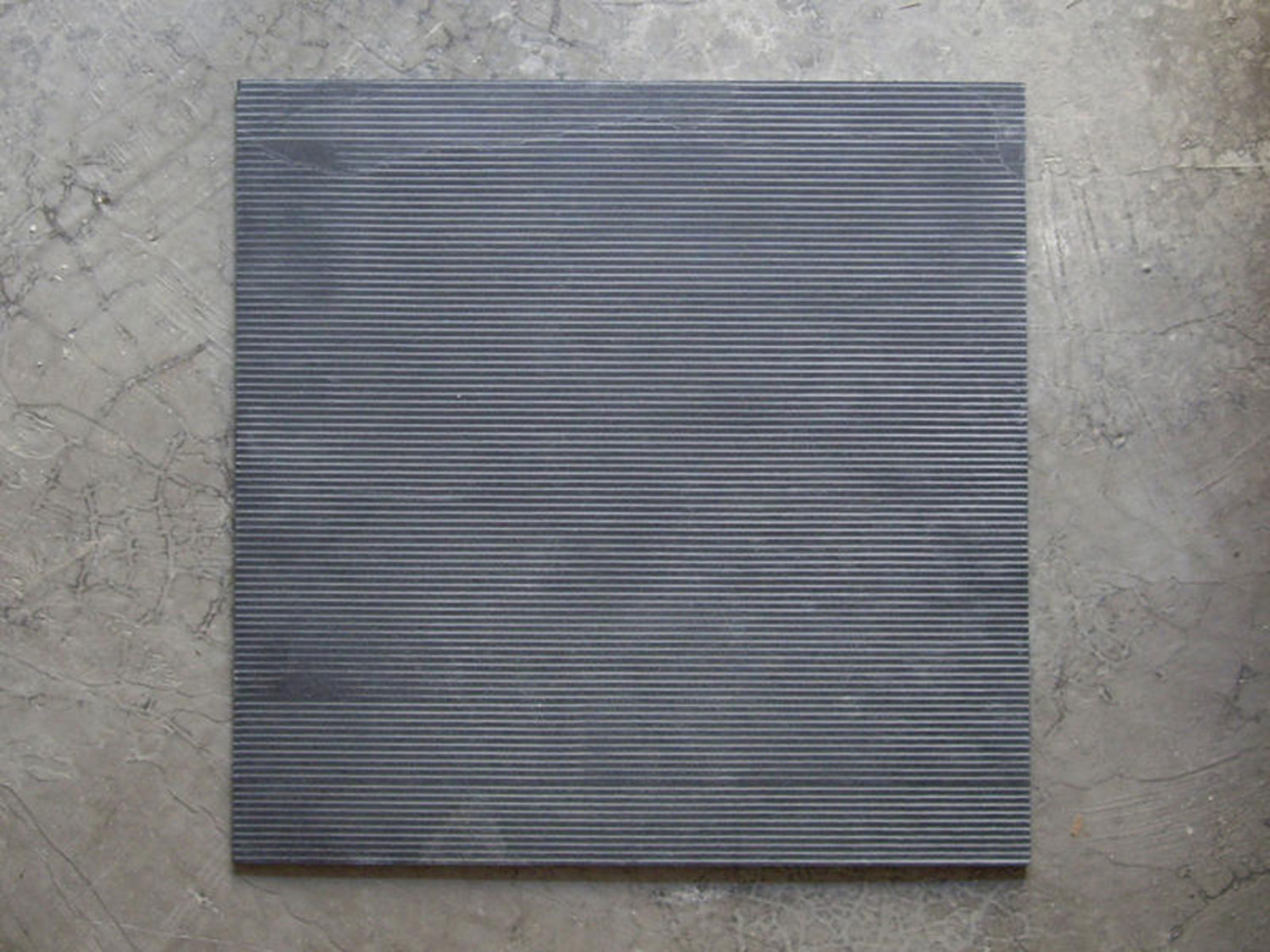Trisha Brown È un’icona della danza contemporanea. Il Festival RED (Reggio Emilia Danza), in collaborazione con la Collezione Maramotti, ha presentato tre coreografi e della Trisha Brown Dance Company (tra cui due prime italiane) al Teatro Valli e sei “Early Works” (in prima e in esclusiva italiana) presso la sede della Collezione Maramotti. Gli “Early Works”, composti tra il 1970 e il 1974, hanno una durata che varia tra i due e i quindici minuti, prevedono un numero variabile di danzatori (da uno a nove) e sono in alcuni casi accompagnati da musica (Floor of the Forest, Accumulation, Group Primary Accumulation, Sticks, Figure Eight, Spanish Dance, quest’ultima con una canzone di Bob Dylan). Queste coreografi e hanno spesso una struttura affi ne alle opere coeve della Minimal Art e nascono in opposizione alla spettacolarizzazione del balletto e della Modern Dance. Si tratta di un’arte astratta, scientifica e matematica.

Laura Cherubini: Iniziamo con il rapporto con Ann Halprin. So che insieme ad altri esponenti della danza, come Simone Forti, Yvonne Rainer, Steve Paxton e anche Bob Morris, ha fatto parte della Dancer’s Workshop Company diretta da Ann Halprin.
Trisha Brown: Ho lavorato con lei alla fine degli anni Cinquanta.
LC: Ci può raccontare di questa comunità e dei rapporti che c’erano con la Halprin e con gli altri danzatori del gruppo?
TB: Ero molto vicina a Simone Forti, ci legava una grande amicizia. Aveva avuto esperienze come direttrice di spettacoli jazz. Facevamo parte della Compagnia di Ann Halprin, tra le quattro migliori compagnie a quel tempo in America. Tutto cominciò in California. La cosa più importante all’interno delle lezioni di Ann Halprin era il compito, il dovere. I doveri comprendevano anche spazzare i pavimenti. Ci ha insegnato a trovare l’oggetto nell’arte.
LC: Qual è per lei l’importanza che Halprin ha avuto nella danza?
TB: Ann Halprin ha portato un’improvvisazione molto sofisticata nella danza americana. L’improvvisazione a quel tempo era considerata come qualcosa di basso profilo. Simone e io abbiamo cominciato ad arrampicarci sui muri di uno studio all’interno del quale poter provare. Non avevamo soldi e io avevo anche un figlio molto piccolo.
LC: A proposito di Simone Forti, Fabio Sargentini mi ha raccontato che è stato proprio dopo averla incontrata che ha deciso di trasformare L’Attico. All’origine era la galleria di suo padre, in un elegante appartamento in Piazza di Spagna, ma Sargentini utilizzò un nuovo spazio, il garage di via Beccaria, per il lavoro di Pino Pascali. Pensava, infatti, che la galleria fosse troppo stretta per Pascali che vi aveva portato il vero mare. Alla morte precoce di Pascali nel ’68, Sargentini si sentì demotivato, ma quando Simone Forti passò a trovarlo, capì che il garage poteva essere lo spazio giusto per il lavoro che voi stavate facendo a New York. Furono poi i cavalli di Jannis Kounellis a inaugurarlo ufficialmente. Subito dopo Sargentini realizzò il festival Danza Volo Musica Dinamite (1969) di cui spero lei possa raccontarci qualcosa.
TB: Non ricordo tutti i dettagli. Deborah Hay aveva un fidanzato, David Bradshaw, era lui il dinamitardo del titolo. Indossava una bandana legata intorno alla fronte. Aveva messo un po’ di dinamite sul fondo di un piccolo lago e aveva un macchinario per farla esplodere. Tutti i pesci morirono e molte persone scapparono. Adesso rido, ma allora mi spaventai un po’.
LC: Come era la New York del ’61-62, quando lei arrivò? C’era questo personaggio, Robert Dunn, membro del gruppo Fluxus, che era stato allievo di John Cage alla New School for Social Research e che teneva corsi di composizione alla scuola di Merce Cunningham, in cui oltre a lei vi erano anche Yvonne Rainer e Steve Paxton. Se non sbaglio nello stesso edificio aveva sede il Living Theatre. Dunque a New York in quegli anni si trovavano il gruppo Fluxus, il Living Theatre e la New Dance.
TB: All’angolo tra la quattrordicesima e la sesta strada c’era lo Studio di Merce Cunningham; a quello stesso incrocio c’era un coffee shop dove ho incontrato Steve Paxton, inventore di un particolare tipo di danza che possiamo definire Contact Improvisation. In Italia in quel periodo sono stati pubblicati libri di fotografia molto belli. Ricordo soprattutto un fotografo, Ugo Mulas, che ha fotografato anche i miei lavori. Mulas partecipò a una cena del Ringraziamento o di Natale a casa di Robert Rauschenberg; c’era un lunghissimo tavolo nero apparecchiato.
LC: In quel periodo molte foto di performance da Sargentini sono state scattate da un fotografo romano, Claudio Abate. Per riprendere il discorso, vorrei domandare quali erano i rapporti con il Living?
TB: Non c’erano grandi rapporti con il Living, anche se si trovavano nella quattordicesima strada. Allora non c’erano molti soldi e io avrei dato il mio braccio destro per vedere Merce Cunningham, ma non altrettanto per il Living. Prendevo lezioni da Carolyn Brown, la migliore ballerina della compagnia di Merce Cunningham.
LC: Nei primi anni Settanta lei si è impegnata nella costruzione di attrezzi, meccanismi, strumenti, per contrastare la forza di gravità. Nel ciclo di “Equipment Pieces” si camminava sui muri esterni o interni di un edificio (Man Walking Down the Side of a Building, 1969; Walking on the Wall, 1971).
TB: Camminare è l’azione più semplice e comune a tutti. Inoltre non c’era un teatro in cui poter lavorare.

LC: In qualche modo è la città a diventare un grande teatro all’aria aperta. Addirittura con Roof Piece (1971 e 1973) i danzatori si trasmettevano segni da tetto a tetto, tessendo la rete di una danza invisibile. Mi colpisce la convergenza di ricerche, negli stessi anni, intorno al tentativo di annullare la forza di gravità in lavori completamente diversi come quelli di Gino De Dominicis.
TB: Ricordo quando ho conosciuto La Monte Young. In quel periodo avevo vent’anni e mi ero appena diplomata al college. Indossava un abito nero da signore e una cravatta. Per il suo concerto aveva liberato varie farfalle, non capivamo che cosa volesse fare. Aveva davanti a sé una tavola di legno e ha cominciato a cucinare una ricetta della mamma, poi tutti hanno cantato al microfono per tutta la notte. Era un momento incredibile, all’epoca ho fatto alcuni tra i miei migliori lavori.
LC: Parliamo dei lavori presentati a Reggio Emilia.
TB: Al Teatro Valli di Reggio Emilia la Trisha Brown Dance Company ha presentato tre lavori: il pezzo principale del repertorio, Set and Reset, con musiche di Laurie Anderson, poi You Can See Us (1995), una coreografia che mi era stata chiesta da Bob Rauschenberg, e infine il lavoro più recente, L’Amour au théâtre (2009). Per You Can See Us Rauschenberg mi aveva chiesto di danzare con la schiena rivolta al pubblico. La cosa mi preoccupava perché pensavo che qualcuno potesse non avere l’immagine esatta. Avrei preferito fare dei cerchi volgendomi verso il pubblico. Ma una volta in studio, Bob mi vide fare il giro completo mentre lanciavo una gamba in aria e mi disse: “Trisha, tu puoi fare tutto quello che vuoi!”. Con questo movimento per un attimo volgevo il viso al pubblico. Il terzo pezzo si basa su un’opera di Jean-Philippe Rameau. Alla Collezione Maramotti, invece, vengono presentati i lavori storici, gli “Early Works”.
LC: Due anni fa, in occasione di documenta a Kassel, ho avuto modo di vedere due di queste coreografi e storiche: Floor of the Forest (1970), una struttura di tubi e corde a cui sono appesi indumenti da cui gli interpreti entrano ed escono, e Accumulation (1971), successione di gesti che si accumulano. Avevano un ruolo centrale nella grande rassegna e c’erano anche alcuni bellissimi disegni. Quale evoluzione c’è stata dai lavori storici ai nuovi?
TB: In luglio a Aix-en-Provence ci saranno nuovi pezzi con la musica.
LC: La maggior parte dei pezzi storici invece non aveva musica; è a partire dall’81 che la musica assume un ruolo maggiore. Ricordiamo tra l’altro alcune collaborazioni con Salvatore Sciarrino.
TB: Tutti sanno che con la musica ti muovi più facilmente, tuttavia senza musica il movimento è più lineare, più puro.
LC: A proposito dei lavori più recenti, alcuni dei quali presentati qui a Reggio Emilia, qual è l’importanza della musica?
TB: In generale la musica commissionata a Laurie Anderson per Set and Reset è la migliore per il mio lavoro. Altri pezzi del mio repertorio di cui apprezzo particolarmente l’accompagnamento musicale sono O composite (2004) e I Love My Robots (2007).