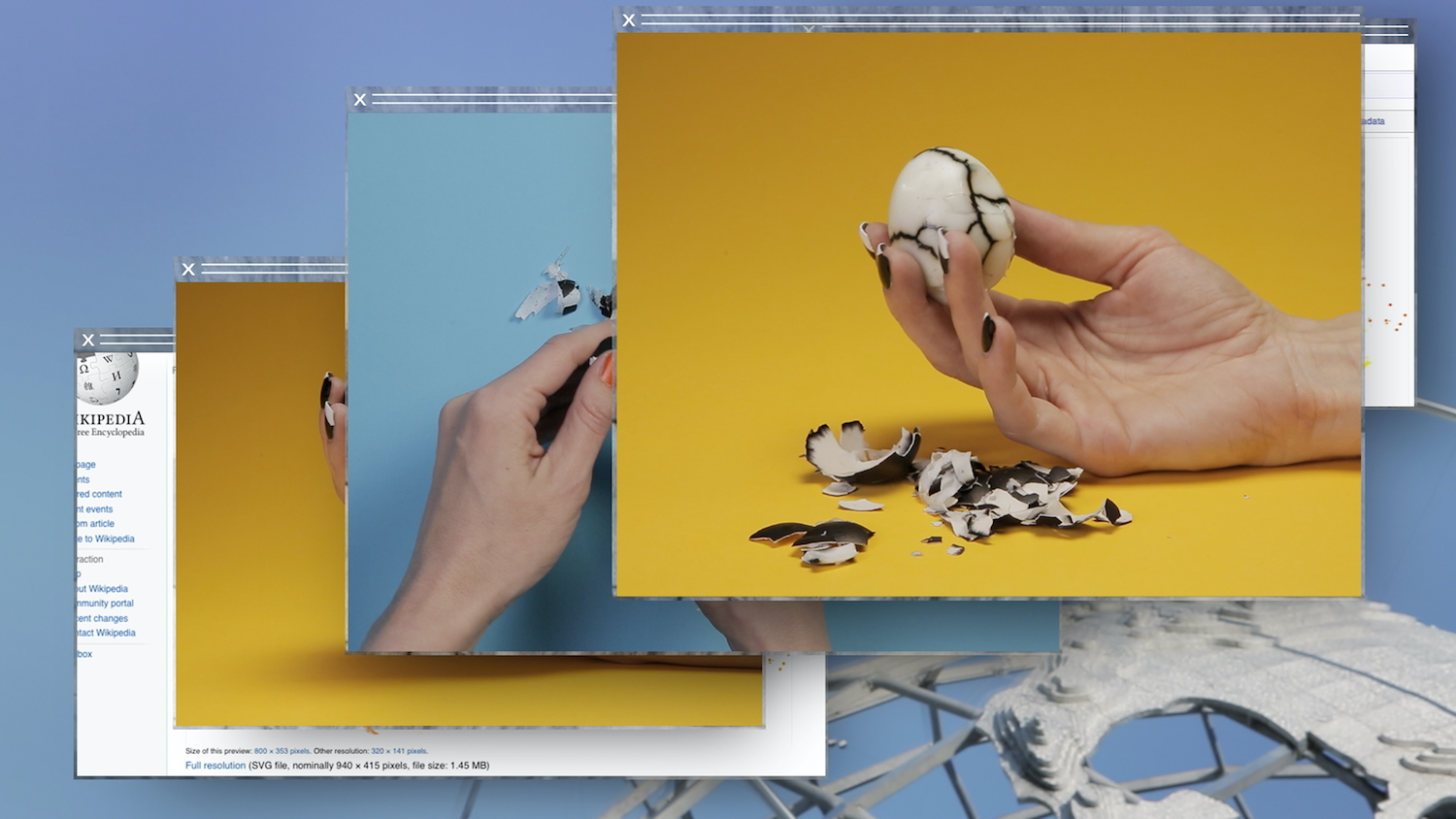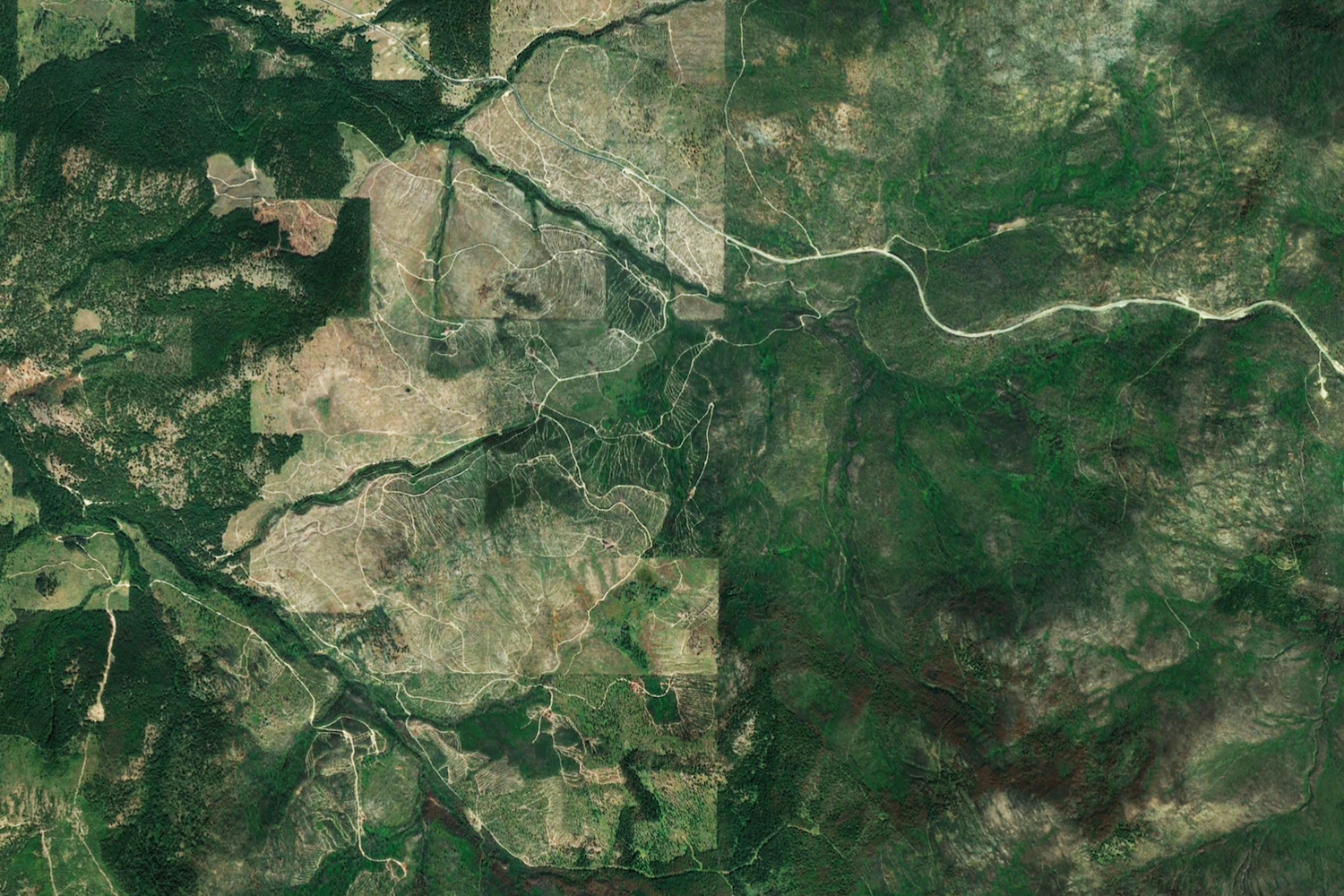Azzardare una mappatura dell’attuale condizione culturale è per certi versi ardito e per altri fallimentare. Mentre il coraggio risiede nel misurarsi con un panorama frammentato e ormai orgoglioso del proprio statuto, l’impossibilità deriva dalla difficoltà con cui, una volta dentro, si distingue una o l’altra disciplina. In entrambi i casi la sensazione è quella di perdersi fin dal principio.
Ogni ambito culturale si configura come un territorio dai confini sfocati e, quando propriamente artistico, ha la strana attitudine a considerare le altre discipline come un’inesauribile riserva di stimoli o un trampolino per le proprie fantasie. Il punto non è stabilire la validità dell’approccio, dal momento in cui la creatività è sempre stata l’enzima necessario per tracciare percorsi ibridi e direzioni multiple; l’obiettivo è capire quanto l’arte padroneggi questo potenziale e sappia farlo fruttare in momenti in cui sarebbe necessario ne raccogliesse i massimi profitti.
Per dirla con una metafora geopolitica, approdare nello ‘stato’ dell’arte significa riconoscerle un’autonomia strutturale e contenutistica – una sorta di identità linguistica, estetica, più in generale sintattica –, quanto ammettere la fondamentale alleanza con altri territori, prossimi e remoti. Insistendo con il parallelismo e distillandone ancora pochi elementi tutt’altro che avulsi dalla quotidianità, si può dire che il corretto funzionamento dell’intero sistema dipenda dall’equilibrio esistente tra riflessioni interne ed esterne e che si misuri con la capacità che ogni ‘stato’ ha di intervenire sulla propria identità. Lungi dal cadere nel più ingenuo “sovranismo” e senza affrontare gli annosi problemi del sistema dell’arte – peraltro della massima urgenza ed estremamente attuali –, questo discorso ha il solo scopo di domandarsi quando l’arte abbia accettato le estreme conseguenze di una condizione interdisciplineare e quanto ne sappia oggi trarre un consapevole vantaggio.
La crisi delle grandi narrazioni¹ esplosa con il postmoderno, è stata forse l’occasione inaugurale dell’esasperata polifonia contemporanea: un disordine strutturale e sovra-disciplinare che ha richiesto l’utilizzo di un modello fluido di resistenza e adattamento. L’entropia da allora crescente ha di fatto ampliato la generale fissità degli ambiti di conoscenza e proposto un nuovo gioco linguistico basato su eteronomie permeabili, versatili e camaleontiche. Le arti visive, esempio di generale trasformismo e sempre attente a catalizzare le esigenze dei loro contesti di riferimento, hanno reso possibile qualsiasi contaminazione e trasformato ogni utopia in un ‘buon luogo’² (almeno) per l’immaginazione.
D’altronde l’artista è sempre stato un fastidioso antagonista in grado di spingere i contenuti delle proprie narrazioni al limite del possibile e le ibridazioni che derivano dalle sue azioni si sono spesso dimostrate, anche quando non futuribili, preziose occasioni di confronto.
Le sperimentazioni artistiche anni Settanta, le prime narrazioni video o passeggiate fenomenologiche nel tempo e nello spazio, rappresentavano di per sé un’ibridazione disciplinare dal momento che né il video né il corpo erano materia consolidata sulla scena artistica e, uno dal cinema e l’altro da danza e teatro, interpretavano le regole dei loro ambiti d’origine tutt’altro che fedelmente. Questo slittamento mediale richiese un immediato intervento teorico e, primi fra tutti, gli Octoberists³ impiegarono le prime fonti eteronome per risolvere problemi di natura estetica e contenutistica. Il saggio “The Aesthetic of Narcissism”, pubblicato da Rosalind Krauss sul primo numero di October (1976), ebbe proprio lo scopo di definire lo spirito di rinnovamento che stava attraversando l’arte e, affrontando un’intera generazione di artisti⁴, considerò il loro lavoro come il principio di un “narcisismo” che aveva ampie basi su altre discipline, prima fra tutte la psicanalisi. Quella di Krauss e dei tanti colleghi che la seguirono, fu un’analisi allargata e plausibile che, giustificata dalle esigenze del momento storico-sociale, non dimenticava lo ‘stato’ dell’arte piuttosto ne specificava i problemi ricorrendo alle metafore più adeguate. Da allora generazioni di autori si sono misurati con la possibilità di stabilire regimi di produzione fluidamente ancorati ai propri contenuti e hanno cercato di non compromettere l’integrità del contenitore pur allontanandosene concettualmente e contestualmente.
La fascinazione per le nuove tecnologie, l’attenzione a contesti sociali sensibili, il riconoscimento in discorsi filosofico-scientifici o l’inesauribile curiosità per la natura, sono solo alcune delle immersioni extra-disciplinari che hanno concesso all’arte di arricchire le proprie metafore epistemologiche. I tanti lavori che sono derivati da questo prezioso ‘saccheggio’ ne hanno tanto interpretato gli assunti quanto se ne sono distanziati rendendoli immagine: sono intervenuti sullo ‘stato’ dell’arte da un punto di vista strutturale e hanno spesso permesso un aggiornamento della sua grammatica estetico-formale. Una sfumatura che appare oggi più labile e di cui è sintomo un generale immobilismo.
Alla certezza che leggere un testo di Krauss o guardare un lavoro degli ‘artisti narcisisti’ significhi analizzare deliberate contaminazioni che hanno inevitabilmente ri-configurato l’arte, si sostituisce il dubbio che tante delle narrazioni contemporanee si sovrappongano ad altre discipline puntando, ambiguamente, a una sorta di coincidenza. Pur ammettendo una comunanza d’intenti o riconoscendo particolari momenti di tangenza, il linguaggio specifico di ogni ‘stato’ dovrebbe avere regole proprie in grado di ordinarne il proprio ‘statuto’: l’arte, invece, ha smesso di alimentare le voci del proprio dizionario e di aggiornare la propria nomenclatura adattandosi a utilizzare quella di altri ambiti della conoscenza. Tutt’altro che banale, l’operazione diventa l’indizio di una ricerca artistica solo opportunisticamente dialogante e restituisce una terminologia disallineata alle esigenze reali.
Non si tratta di scoraggiare la naturale propensione dell’arte a essere trans-, cross- o inter-disciplinare né, tantomeno, di promuovere qualsiasi svantaggiosa idea circa l’introversione della disciplina; è invece un invito a non perdere l’occasione di affrontare una condizione strutturale dell’arte che coincide con il fare l’opera⁵.
Se l’analisi mediale si vanifica davanti alla frammentazione del contesto di riferimento forse è il caso studiarne le motivazioni o l’alternativa; se guardare ad altre discipline è oggi inalienabile e ci ricorda che l’arte è uno strumento (legittimo) di natura partecipativa, sociale, relazionale e dialogica, tanto vale analizzarne la complessità strutturale, le forze e le criticità; se, come è giusto, è così importante il confronto con la produzione ‘scientifica’, è bene che l’arte ne condivida la credibilità senza subirne (solo) il fascino.
Come tutte le attività che privilegiano modelli di conoscenza fluidi e olistici, l’arte possiede una ambiguità intrinseca che, per dirla nuovamente con la geopolitica, coincide proprio con l’equilibrio tra una spinta di crescita interna e la partecipazione a una missione più ampia, in questo caso culturale. Il fatto che esista un’affinità con altre discipline e che esse trovino soluzioni a criticità comuni esercitando i propri espedienti linguistici, non coincide con la risoluzione dei problemi del singolo ambito: l’arte, dal medium al display, dal supporto al dispositivo, dal fare al fruire, ne ha tanti e, troppi, apertamente irrisolti.
Nel pieno della sua “svolta fringe”⁶, l’arte ha ancora bisogno di delimitare il proprio campo di indagine non tanto per garantire una specializzazione del sapere, quanto per rendersi conto che la contaminazione disciplinare può essere proficua solo qualora sia consapevolmente direzionata a riflessioni autonome e interne. Soprattutto in momenti di crisi o apparente immobilismo, può essere un bene sostenere un certo confinamento nel proprio ‘stato’.