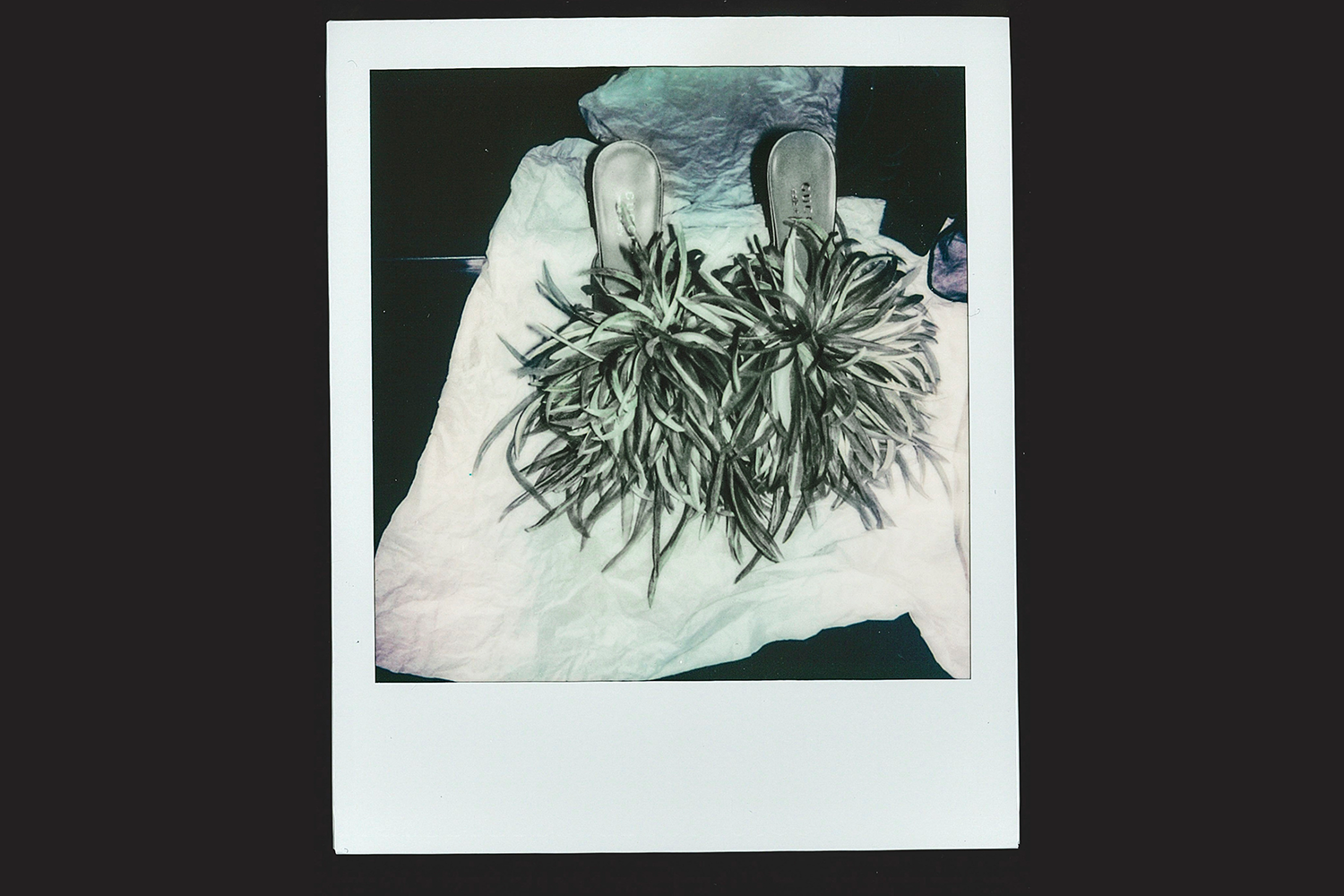Milano ha visto di tutto in Piazza Affari, ma non un cinema, velluto marrone e senape, incastonato nel tempio della finanza, per decostruire un brand. Davanti il monito di Cattelan. Gucci non ha sfilato: ha messo in scena The Tiger, un atto filosofico vestito.
Demna entra in Gucci come un regista che applica lo straniamento brechtiano al sistema moda. Insieme a Spike Jonze e Halina Reijn, compie un gesto che non chiede consenso ma produce rivelazione. Gli abiti cessano di accompagnare l’immagine per generarla: diventano attori a loro volta, protagonisti che scrivono il personaggio sul corpo degli interpreti—Demi Moore come matriarca fantasy, e un cast che trasforma ogni capo in maschera narrativa—imponendo ritmo, tono, ruolo.
Il plot è minimo: una festa di compleanno a Los Angeles che ha sullo sfondo intelligenze artificiali ormai conquistatrici del mondo. È teatro dell’assurdo applicato al lusso, dove il capitale si auto-satirizza secondo la logica situazionista del détournement. All’improvviso, però, il caleidoscopio si apre su un lirismo da videoarte—le piscine, le dissolvenze liquide, le lisergiche liturgie—come un inciso poetico che sospende la narrazione per rivelarne la nervatura emotiva. È il sublime che irrompe nel simulacro baudrillardiano, restituendo densità ontologica a ciò che sembrava pura superficie.
Questa non è “l’assenza di collezione”: è una capsule pienamente Gucci che opera una rivoluzione ontologica. Le api come araldica fantasy, gli accenti medievali e surreali, l’ironia che scolla le superfici—tutto concorre a una decostruzione che rilegge i codici per differenza, non per accumulo. Come nelle Mythologies barthesiane, il segno viene svuotato del suo contenuto naturale per essere riempito di storia. Demna dichiara esplicitamente la fase di transizione (“non è ancora la mia visione, è Gucci visto da me”), ma intanto compie l’operazione più radicale: restituisce al brand l’identificabilità attraverso la precisione del linguaggio, non l’ipertrofia del segno.
La mossa genealogica è evidente: “La Famiglia”—lookbook di 37 archetipi—funziona come controcampo sociologico. L’archivio—Tom Ford, anni Settanta—non è nostalgia ma laboratorio: il passato come jetztzeit benjaminiano che illumina il presente. La sottrazione come costruzione: qui sta il nucleo filosofico dell’operazione, un’estetica della via negativa che echeggia Meister Eckhart applicato alla grammatica del lusso.
Demna parla di “nuovo minimalismo” non come revival anni Sessanta, ma come disciplina per apprendere ciò che ancora non sa. È un atto di umiltà intellettuale rarissima in un’industria drogata di onniscienza simulata. Il minimalismo diventa così una tecnologia cognitiva, un dispositivo per vedere l’invisibile del proprio gesto creativo. Non l’essenzialità rassicurante, ma l’inquietudine produttiva di Donald Judd: forme pure che generano domande invece di fornire risposte.
Il dispositivo filmico chiarisce il metodo: l’abbandono del controllo come pratica filosofica. “Il controllo è una droga pericolosa”—lasciarlo andare significa aprirsi all’evento imprevisto che fa emergere l’umano sotto la griglia del marchio. È la lezione dell’automatismo surrealista applicata al sistema moda, ma anche l’eco dell’estetica dell’indeterminazione di John Cage trasferita dal campo musicale a quello vestimentario. Per una maison che ha costruito il proprio potere sull’ipertrofia del segno, questa è la vera rivoluzione: mettere il segno in crisi senza annullarlo.
The Tiger non è branded content: è un manifesto su come si produce oggi valore culturale nel lusso. La critica filosofica è integrata nell’operazione stessa, l’intelligenza artificiale come metafora del desiderio che si autoalimenta, la festa come liturgia del vuoto, la moda come ultimo baluardo dell’umano in un mondo post-umano.
L’operazione Tiger non risolve nulla “in cassa” nell’immediato e non deve, perché opera su un piano diverso. Riposiziona la conversazione, restituisce a Gucci l’autorialità senza cadere nell’artefatto iconografico fine a se stesso. Sposta la moda dall’evento al dispositivo narrativo, dove il brand torna a essere linguaggio, non griglia di merci.
La capsule funziona come “reminder attivo” dei codici; il film apre una grammatica inedita dove ironia e politica convivono; la tigre—emblema del desiderio che divora il proprio oggetto, metafora perfetta del consumo luxury—non viene addomesticata: viene convocata nella sua potenza inquietante. Come nella poesia di Blake (“Tiger! Tiger! burning bright”), la bellezza coincide con il terrore, l’attrazione con la distruzione.
È qui che Demna rivela la sua matrice più profonda: la vera sovversione non consiste nel rifiutare lo spettacolo, ma nel rivoltarne la grammatica contro se stesso. The Tiger è puro détournement: deviazione semantica che trasforma il circo del lusso in teatro dell’assurdo, la passerella in palcoscenico dove il pubblico è chiamato a riconoscere i propri meccanismi di desiderio. L’arte non come ornamento del potere, ma come sua critica immanente.
La rivoluzione, se c’è, è qui: nell’aver trasformato una capsule collection in dispositivo filosofico. Gucci non aveva bisogno di essere salvata. Aveva bisogno di essere ripensata. E la tigre, ora, è libera di mordere.